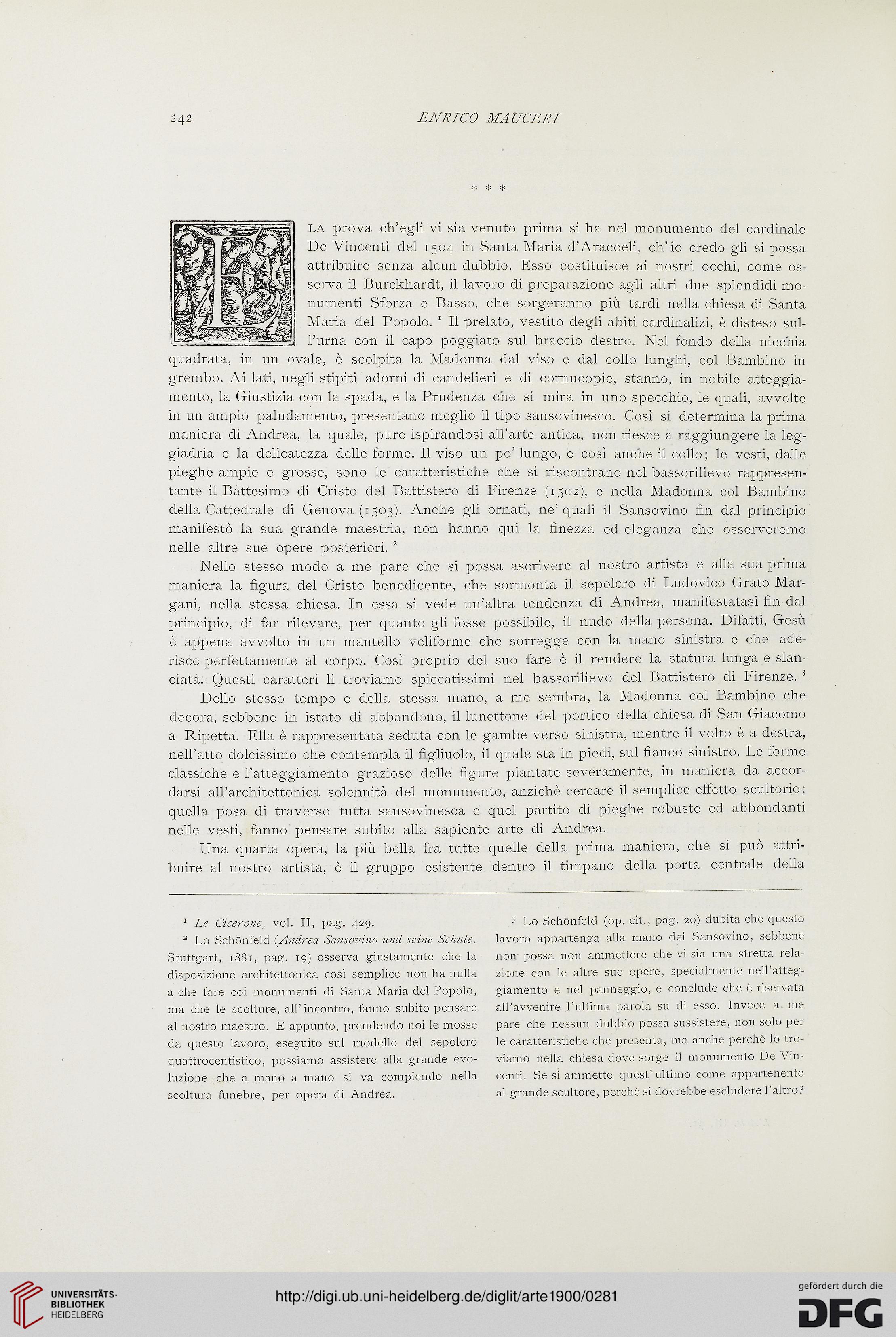2/\2
ENRICO MAUCERÌ
* * *
LA prova ch'egli vi sia venuto prima si ha nel monumento del cardinale
De Vincenti del 1504 in Santa Maria d'Aracoeli, ch'io credo gli si possa
attribuire senza alcun dubbio. Esso costituisce ai nostri occhi, come os-
serva il Burckhardt, il lavoro di preparazione agli altri due splendidi mo-
numenti Sforza e Basso, che sorgeranno più tardi nella chiesa di Santa
Maria del Popolo. 1 II prelato, vestito degli abiti cardinalizi, è disteso sul-
l'urna con il capo poggiato sul braccio destro. Nel fondo della nicchia
quadrata, in un ovale, è scolpita la Madonna dal viso e dal collo lunghi, col Bambino in
grembo. Ai lati, negli stipiti adorni di candelieri e di cornucopie, stanno, in nobile atteggia-
mento, la Giustizia con la spada, e la Prudenza che si mira in uno specchio, le quali, avvolte
in un ampio paludamento, presentano meglio il tipo sansovinesco. Così si determina la prima
maniera di Andrea, la quale, pure ispirandosi all'arte antica, non riesce a raggiungere la leg-
giadria e la delicatezza delle forme. Il viso un po' lungo, e così anche il collo; le vesti, dalle
pieghe ampie e grosse, sono le caratteristiche che si riscontrano nel bassorilievo rappresen-
tante il Battesimo di Cristo del Battistero di Firenze (1502), e nella Madonna col Bambino
della Cattedrale di Genova (1503). Anche gli ornati, ne'quali il Sansovino fin dal principio
manifestò la sua grande maestria, non hanno qui la finezza ed eleganza che osserveremo
nelle altre sue opere posteriori. 2
Nello stesso modo a me pare che si possa ascrivere al nostro artista e alla sua prima
maniera la figura del Cristo benedicente, che sormonta il sepolcro di Ludovico Grato Mar-
gani, nella stessa chiesa. In essa si vede un'altra tendenza di Andrea, manifestatasi fin dal
principio, di far rilevare, per quanto gli fosse possibile, il nudo della persona. Difatti, Gesù
è appena avvolto in un mantello veliforme che sorregge con la mano sinistra e che ade-
risce perfettamente al corpo. Così proprio del suo fare è il rendere la statura lunga e slan-
ciata. Questi caratteri li troviamo spiccatissimi nel bassorilievo del Battistero di Firenze. 3
Dello stesso tempo e della stessa mano, a me sembra, la Madonna col Bambino che
decora, sebbene in istato di abbandono, il hmettone del portico della chiesa di San Giacomo
a Ripetta. Ella è rappresentata seduta con le gambe verso sinistra, mentre il volto è a destra,
nell'atto dolcissimo che contempla il figliuolo, il quale sta in piedi, sul fianco sinistro. Le forme
classiche e l'atteggiamento grazioso delle figure piantate severamente, in maniera da accor-
darsi all'architettonica solennità del monumento, anziché cercare il semplice effetto scultorio;
quella posa di traverso tutta sansovinesca e quel partito di pieghe robuste ed abbondanti
nelle vesti, fanno pensare subito alla sapiente arte di Andrea.
Una quarta opera, la più bella fra tutte quelle della prima maniera, che si può attri-
buire al nostro artista, è il gruppo esistente dentro il timpano della porta centrale della
1 Le Cicerone, voi. II, pag. 429.
" Lo Schonfeld {Andrea Sansovino una1 seine Schule.
Stuttgart, 1881, pag. 19) osserva giustamente che la
disposizione architettonica così semplice non ha nulla
a che fare coi monumenti di Santa Maria del Popolo,
ma che le scolture, all'incontro, fanno subito pensare
al nostro maestro. E appunto, prendendo noi le mosse
da questo lavoro, eseguito sul modello del sepolcro
quattrocentistico, possiamo assistere alla grande evo-
luzione che a mano a mano si va compiendo nella
scoltura funebre, per opera di Andrea.
3 Lo Schonfeld (op. cit., pag. 20) dubita che questo
lavoro appartenga alla mano del Sansovino, sebbene
non possa non ammettere che vi sia una stretta rela-
zione con le altre sue opere, specialmente nell'atteg-
giamento e nel panneggio, e conclude che è riservata
all'avvenire l'ultima parola su di esso. Invece a me
pare che nessun dubbio possa sussistere, non solo pel-
le caratteristiche che presenta, ma anche perchè lo tro-
viamo nella chiesa dove sorge il monumento De Vin-
centi. Se si ammette quest'ultimo come appartenente
al grande scultore, perchè si dovrebbe escludere l'altro?
ENRICO MAUCERÌ
* * *
LA prova ch'egli vi sia venuto prima si ha nel monumento del cardinale
De Vincenti del 1504 in Santa Maria d'Aracoeli, ch'io credo gli si possa
attribuire senza alcun dubbio. Esso costituisce ai nostri occhi, come os-
serva il Burckhardt, il lavoro di preparazione agli altri due splendidi mo-
numenti Sforza e Basso, che sorgeranno più tardi nella chiesa di Santa
Maria del Popolo. 1 II prelato, vestito degli abiti cardinalizi, è disteso sul-
l'urna con il capo poggiato sul braccio destro. Nel fondo della nicchia
quadrata, in un ovale, è scolpita la Madonna dal viso e dal collo lunghi, col Bambino in
grembo. Ai lati, negli stipiti adorni di candelieri e di cornucopie, stanno, in nobile atteggia-
mento, la Giustizia con la spada, e la Prudenza che si mira in uno specchio, le quali, avvolte
in un ampio paludamento, presentano meglio il tipo sansovinesco. Così si determina la prima
maniera di Andrea, la quale, pure ispirandosi all'arte antica, non riesce a raggiungere la leg-
giadria e la delicatezza delle forme. Il viso un po' lungo, e così anche il collo; le vesti, dalle
pieghe ampie e grosse, sono le caratteristiche che si riscontrano nel bassorilievo rappresen-
tante il Battesimo di Cristo del Battistero di Firenze (1502), e nella Madonna col Bambino
della Cattedrale di Genova (1503). Anche gli ornati, ne'quali il Sansovino fin dal principio
manifestò la sua grande maestria, non hanno qui la finezza ed eleganza che osserveremo
nelle altre sue opere posteriori. 2
Nello stesso modo a me pare che si possa ascrivere al nostro artista e alla sua prima
maniera la figura del Cristo benedicente, che sormonta il sepolcro di Ludovico Grato Mar-
gani, nella stessa chiesa. In essa si vede un'altra tendenza di Andrea, manifestatasi fin dal
principio, di far rilevare, per quanto gli fosse possibile, il nudo della persona. Difatti, Gesù
è appena avvolto in un mantello veliforme che sorregge con la mano sinistra e che ade-
risce perfettamente al corpo. Così proprio del suo fare è il rendere la statura lunga e slan-
ciata. Questi caratteri li troviamo spiccatissimi nel bassorilievo del Battistero di Firenze. 3
Dello stesso tempo e della stessa mano, a me sembra, la Madonna col Bambino che
decora, sebbene in istato di abbandono, il hmettone del portico della chiesa di San Giacomo
a Ripetta. Ella è rappresentata seduta con le gambe verso sinistra, mentre il volto è a destra,
nell'atto dolcissimo che contempla il figliuolo, il quale sta in piedi, sul fianco sinistro. Le forme
classiche e l'atteggiamento grazioso delle figure piantate severamente, in maniera da accor-
darsi all'architettonica solennità del monumento, anziché cercare il semplice effetto scultorio;
quella posa di traverso tutta sansovinesca e quel partito di pieghe robuste ed abbondanti
nelle vesti, fanno pensare subito alla sapiente arte di Andrea.
Una quarta opera, la più bella fra tutte quelle della prima maniera, che si può attri-
buire al nostro artista, è il gruppo esistente dentro il timpano della porta centrale della
1 Le Cicerone, voi. II, pag. 429.
" Lo Schonfeld {Andrea Sansovino una1 seine Schule.
Stuttgart, 1881, pag. 19) osserva giustamente che la
disposizione architettonica così semplice non ha nulla
a che fare coi monumenti di Santa Maria del Popolo,
ma che le scolture, all'incontro, fanno subito pensare
al nostro maestro. E appunto, prendendo noi le mosse
da questo lavoro, eseguito sul modello del sepolcro
quattrocentistico, possiamo assistere alla grande evo-
luzione che a mano a mano si va compiendo nella
scoltura funebre, per opera di Andrea.
3 Lo Schonfeld (op. cit., pag. 20) dubita che questo
lavoro appartenga alla mano del Sansovino, sebbene
non possa non ammettere che vi sia una stretta rela-
zione con le altre sue opere, specialmente nell'atteg-
giamento e nel panneggio, e conclude che è riservata
all'avvenire l'ultima parola su di esso. Invece a me
pare che nessun dubbio possa sussistere, non solo pel-
le caratteristiche che presenta, ma anche perchè lo tro-
viamo nella chiesa dove sorge il monumento De Vin-
centi. Se si ammette quest'ultimo come appartenente
al grande scultore, perchè si dovrebbe escludere l'altro?