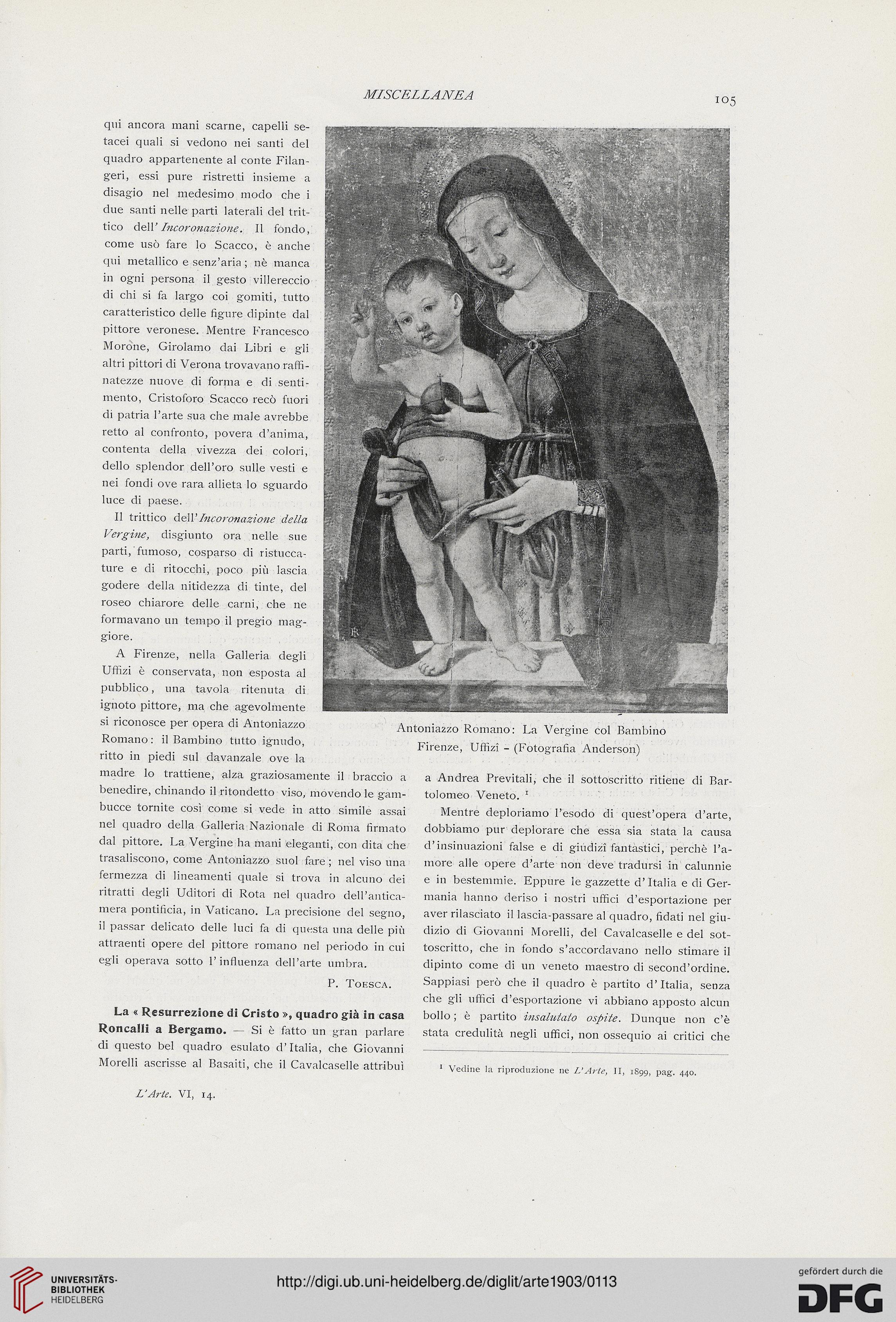MISCELLANEA
105
Antoniazzo Romano: La Vergine col Bambino
Firenze, Uffizi - (Fotografia Anderson)
qui ancora mani scarne, capelli se-
tacei quali si vedono nei santi del
quadro appartenente al conte Filan-
geri, essi pure ristretti insieme a
disagio nel medesimo modo che i
due santi nelle parti laterali del trit-
tico dell'Incoronazione. Il fondo,
come usò fare lo Scacco, è anche
qui metallico e senz’aria ; nè manca
in ogni persona il gesto villereccio
di chi si fa largo coi gomiti, tutto
caratteristico delle figure dipinte dal
pittore veronese. Mentre Francesco
Morène, Girolamo dai Libri e gli
altri pittori di Verona trovavano raffi-
natezze nuove di fornia e di senti-
mento, Cristoforo Scacco recò fuori
di patria l’arte sua che male avrebbe
retto al confronto, povera d’anima,
contenta della vivezza dei colori,
dello splendor dell’oro sulle vesti e
nei fondi ove rara allieta lo sguardo
luce di paese.
Il trittico dell’Incoronazione della
Vergine, disgiunto Ora nelle sue
parti, fumoso, cosparso di ristucca-
ture e di ritocchi, poco più lascia
godere della nitidezza di tinte, del
roseo chiarore delle carni, che ne
formavano un tempo il pregio mag-
giore.
A Firenze, nella Galleria degli
Uffizi è conservata, non esposta al
pubblico, una tavola ritenuta di
ignoto pittore, ma che agevolmente
si riconosce per opera di Antoniazzo
Romano : il Bambino tutto ignudo,
ritto in piedi sul davanzale ove la
madre lo trattiene, alza graziosamente il braccio a
benedire, chinando il ritondetto viso, movendo le gam-
bucce tornite così come si vede in atto simile assai
nel quadro della Galleria Nazionale di Roma firmato
dal pittore. La Vergine ha mani eleganti, con dita che
trasaliscono, come Antoniazzo suol fare ; nel viso una
fermezza di lineamenti quale si trova in alcuno dei
ritratti degli Uditori di Rota nel quadro dell’antica-
mera pontificia, in Vaticano. La precisione del segno,
il passar delicato delle luci fa di questa una delle più
attraenti opere del pittore romano nel periodo in cui
egli operava sotto l’influenza dell’arte umbra.
P. Toesca.
La « Resurrezione di Cristo », quadro già in casa
Roncalli a Bergamo. — Si è fatto un gran parlare
di questo bel quadro esulato d’Italia, che Giovanni
Morelli ascrisse al Basaiti, che il Cavalcasene attribuì
a Andrea Previtali, che il sottoscritto ritiene di Bar-
tolomeo Veneto. 1
Mentre deploriamo l’esodo di quest’opera d’arte,
dobbiamo pur deplorare che essa sia stata la causa
d’insinuazioni false e di giudizi fantastici, perchè l’a-
more alle opere d’arte non deve tradursi in calunnie
e in bestemmie. Eppure le gazzette d’Italia e di Ger-
mania hanno deriso i nostri uffici d’esportazione per
aver rilasciato il lascia-passare al quadro, fidati nel giu-
dizio di Giovanni Morelli, del Cavalcasene e del sot-
toscritto, che in fondo s’accordavano nello stimare il
dipinto come di un veneto maestro di second’ordine.
Sappiasi però che il quadro è partito d’Italia, senza
che gli uffici d’esportazione vi abbiano apposto alcun
bollo ; è partito insalutato ospite. Dunque non c’è
stata credulità negli uffici, non ossequio ai critici che
1 Vedine la riproduzione ne L’Arte, II, 1899, pag. 440.
L'Arte. VI, 14.
105
Antoniazzo Romano: La Vergine col Bambino
Firenze, Uffizi - (Fotografia Anderson)
qui ancora mani scarne, capelli se-
tacei quali si vedono nei santi del
quadro appartenente al conte Filan-
geri, essi pure ristretti insieme a
disagio nel medesimo modo che i
due santi nelle parti laterali del trit-
tico dell'Incoronazione. Il fondo,
come usò fare lo Scacco, è anche
qui metallico e senz’aria ; nè manca
in ogni persona il gesto villereccio
di chi si fa largo coi gomiti, tutto
caratteristico delle figure dipinte dal
pittore veronese. Mentre Francesco
Morène, Girolamo dai Libri e gli
altri pittori di Verona trovavano raffi-
natezze nuove di fornia e di senti-
mento, Cristoforo Scacco recò fuori
di patria l’arte sua che male avrebbe
retto al confronto, povera d’anima,
contenta della vivezza dei colori,
dello splendor dell’oro sulle vesti e
nei fondi ove rara allieta lo sguardo
luce di paese.
Il trittico dell’Incoronazione della
Vergine, disgiunto Ora nelle sue
parti, fumoso, cosparso di ristucca-
ture e di ritocchi, poco più lascia
godere della nitidezza di tinte, del
roseo chiarore delle carni, che ne
formavano un tempo il pregio mag-
giore.
A Firenze, nella Galleria degli
Uffizi è conservata, non esposta al
pubblico, una tavola ritenuta di
ignoto pittore, ma che agevolmente
si riconosce per opera di Antoniazzo
Romano : il Bambino tutto ignudo,
ritto in piedi sul davanzale ove la
madre lo trattiene, alza graziosamente il braccio a
benedire, chinando il ritondetto viso, movendo le gam-
bucce tornite così come si vede in atto simile assai
nel quadro della Galleria Nazionale di Roma firmato
dal pittore. La Vergine ha mani eleganti, con dita che
trasaliscono, come Antoniazzo suol fare ; nel viso una
fermezza di lineamenti quale si trova in alcuno dei
ritratti degli Uditori di Rota nel quadro dell’antica-
mera pontificia, in Vaticano. La precisione del segno,
il passar delicato delle luci fa di questa una delle più
attraenti opere del pittore romano nel periodo in cui
egli operava sotto l’influenza dell’arte umbra.
P. Toesca.
La « Resurrezione di Cristo », quadro già in casa
Roncalli a Bergamo. — Si è fatto un gran parlare
di questo bel quadro esulato d’Italia, che Giovanni
Morelli ascrisse al Basaiti, che il Cavalcasene attribuì
a Andrea Previtali, che il sottoscritto ritiene di Bar-
tolomeo Veneto. 1
Mentre deploriamo l’esodo di quest’opera d’arte,
dobbiamo pur deplorare che essa sia stata la causa
d’insinuazioni false e di giudizi fantastici, perchè l’a-
more alle opere d’arte non deve tradursi in calunnie
e in bestemmie. Eppure le gazzette d’Italia e di Ger-
mania hanno deriso i nostri uffici d’esportazione per
aver rilasciato il lascia-passare al quadro, fidati nel giu-
dizio di Giovanni Morelli, del Cavalcasene e del sot-
toscritto, che in fondo s’accordavano nello stimare il
dipinto come di un veneto maestro di second’ordine.
Sappiasi però che il quadro è partito d’Italia, senza
che gli uffici d’esportazione vi abbiano apposto alcun
bollo ; è partito insalutato ospite. Dunque non c’è
stata credulità negli uffici, non ossequio ai critici che
1 Vedine la riproduzione ne L’Arte, II, 1899, pag. 440.
L'Arte. VI, 14.