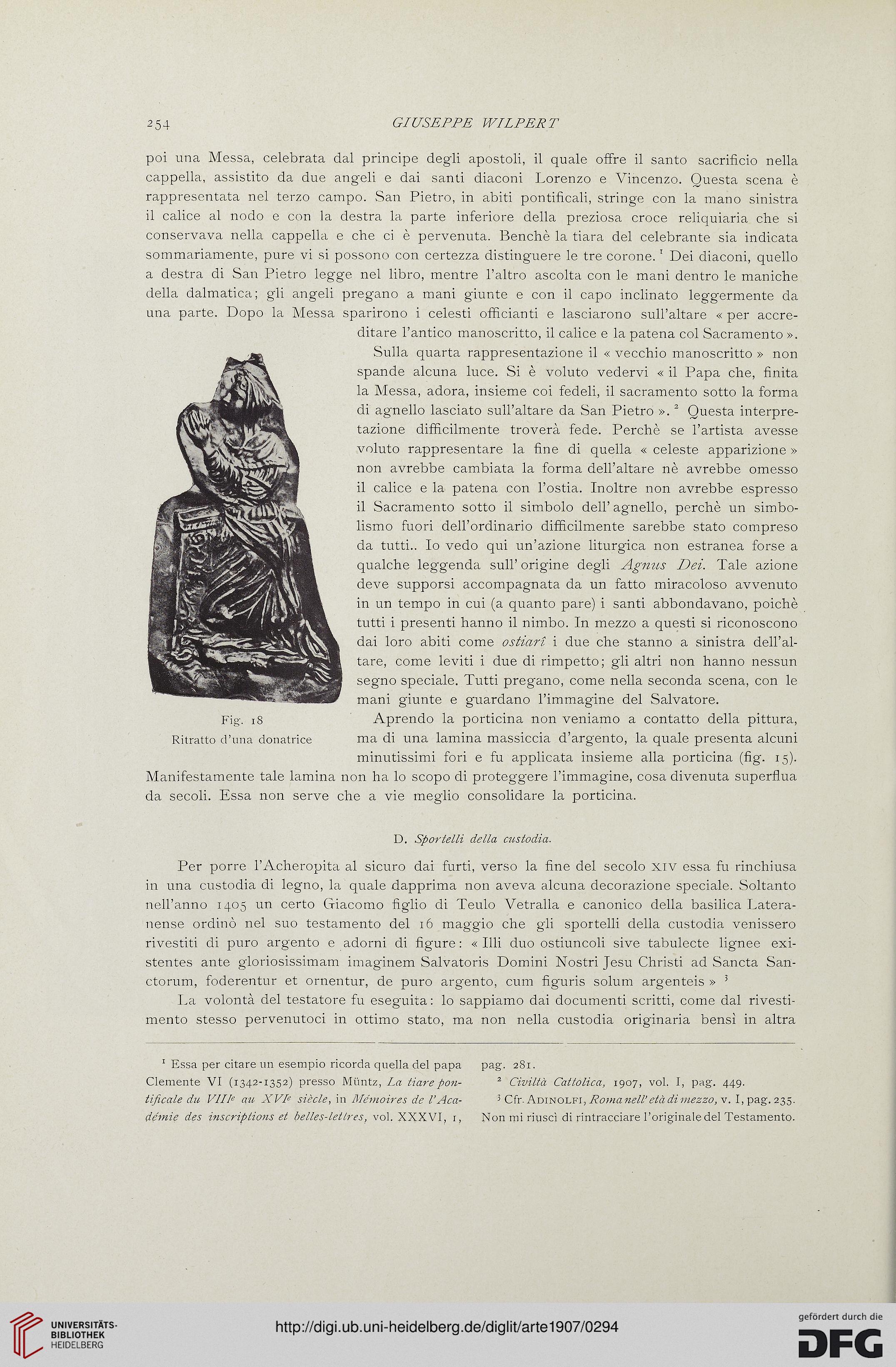254
GIUSEPPE WILPERT
poi una Messa, celebrata dal principe degli apostoli, il quale offre il santo sacrificio nella
cappella, assistito da due angeli e dai santi diaconi Lorenzo e Vincenzo. Questa scena è
rappresentata nel terzo campo. San Pietro, in abiti pontificali, stringe con la mano sinistra
il calice al nodo e con la destra la parte inferiore della preziosa croce reliquiaria che si
conservava nella cappella e che ci è pervenuta. Benché la tiara del celebrante sia indicata
sommariamente, pure vi si possono con certezza distinguere le tre corone.1 Dei diaconi, quello
a destra di San Pietro legge nel libro, mentre l’altro ascolta con le mani dentro le maniche
della dalmatica; gli angeli pregano a mani giunte e con il capo inclinato leggermente da
una parte. Dopo la Messa sparirono i celesti officianti e lasciarono sull’altare « per accre-
ditare l’antico manoscritto, il calice e la patena col Sacramento ».
Sulla quarta rappresentazione il « vecchio manoscritto » non
spande alcuna luce. Si è voluto vedervi « il Papa che, finita
la Messa, adora, insieme coi fedeli, il sacramento sotto la forma
di agnello lasciato sull’altare da San Pietro ».2 Questa interpre-
tazione diffìcilmente troverà fede. Perchè se l’artista avesse
voluto rappresentare la fine di quella « celeste apparizione »
non avrebbe cambiata la forma dell’altare nè avrebbe omesso
il calice e la patena con l’ostia. Inoltre non avrebbe espresso
il Sacramento sotto il simbolo dell’ agnello, perchè un simbo-
lismo fuori dell’ordinario diffìcilmente sarebbe stato compreso
da tutti.. Io vedo qui un’azione liturgica non estranea forse a
qualche leggenda sull’ origine degli Agnus Dei. Tale azione
deve supporsi accompagnata da un fatto miracoloso avvenuto
in un tempo in cui (a quanto pare) i santi abbondavano, poiché
tutti i presenti hanno il nimbo. In mezzo a questi si riconoscono
dai loro abiti come ostiart i due che stanno a sinistra dell’al-
tare, come leviti i due di rimpetto; gli altri non hanno nessun
segno speciale. Tutti pregano, come nella seconda scena, con le
mani giunte e guardano l’immagine del Salvatore.
Aprendo la porticina non veniamo a contatto della pittura,
ma di una lamina massiccia d’argento, la quale presenta alcuni
minutissimi fori e fu applicata insieme alla porticina (fig. 15).
Manifestamente tale lamina non ha lo scopo di proteggere l’immagine, cosa divenuta superflua
da secoli. Essa non serve che a vie meglio consolidare la porticina.
Fig. 18
Ritratto d’una donatrice
D. Sportelli della custodia.
Per porre l’Acheropita al sicuro dai furti, verso la fine del secolo XIV essa fu rinchiusa
in una custodia di legno, la quale dapprima non aveva alcuna decorazione speciale. Soltanto
nell’anno 1405 un certo Giacomo figlio di Teulo Vetralla e canonico della basilica Latera-
nense ordinò nel suo testamento del 16 maggio che gli sportelli della custodia venissero
rivestiti di puro argento e adorni di figure : « Illi duo ostiuncoli sive tabulecte lignee exi-
stentes ante gloriosissimam imag'inem Salvatoris Domini Nostri Jesu Christi ad Sancta San-
ctorum, foderentur et ornentur, de puro argento, cum fìg'uris solum argenteis » 3
La volontà del testatore fu eseguita : lo sappiamo dai documenti scritti, come dal rivesti-
mento stesso pervenutoci in ottimo stato, ma non nella custodia originaria bensì in altra
1 Essa per citare un esempio ricorda quella del papa pag. 281.
Clemente VI (1342-1352) presso Muntz, La tiare pori- 2 Civiltà Cattolica, 1907, voi. I, pag. 449.
tificale du VIIIc au XVIe siècle, in Mémoires de l’Aca- 3 Cfr- Adinolfi, Romandi’ età di mezzo, sr. I, pag. 235.
démie des inscriptions et belles-lettres, voi. XXXVI, r, Non mi riuscì di rintracciare l’originale del Testamento.
GIUSEPPE WILPERT
poi una Messa, celebrata dal principe degli apostoli, il quale offre il santo sacrificio nella
cappella, assistito da due angeli e dai santi diaconi Lorenzo e Vincenzo. Questa scena è
rappresentata nel terzo campo. San Pietro, in abiti pontificali, stringe con la mano sinistra
il calice al nodo e con la destra la parte inferiore della preziosa croce reliquiaria che si
conservava nella cappella e che ci è pervenuta. Benché la tiara del celebrante sia indicata
sommariamente, pure vi si possono con certezza distinguere le tre corone.1 Dei diaconi, quello
a destra di San Pietro legge nel libro, mentre l’altro ascolta con le mani dentro le maniche
della dalmatica; gli angeli pregano a mani giunte e con il capo inclinato leggermente da
una parte. Dopo la Messa sparirono i celesti officianti e lasciarono sull’altare « per accre-
ditare l’antico manoscritto, il calice e la patena col Sacramento ».
Sulla quarta rappresentazione il « vecchio manoscritto » non
spande alcuna luce. Si è voluto vedervi « il Papa che, finita
la Messa, adora, insieme coi fedeli, il sacramento sotto la forma
di agnello lasciato sull’altare da San Pietro ».2 Questa interpre-
tazione diffìcilmente troverà fede. Perchè se l’artista avesse
voluto rappresentare la fine di quella « celeste apparizione »
non avrebbe cambiata la forma dell’altare nè avrebbe omesso
il calice e la patena con l’ostia. Inoltre non avrebbe espresso
il Sacramento sotto il simbolo dell’ agnello, perchè un simbo-
lismo fuori dell’ordinario diffìcilmente sarebbe stato compreso
da tutti.. Io vedo qui un’azione liturgica non estranea forse a
qualche leggenda sull’ origine degli Agnus Dei. Tale azione
deve supporsi accompagnata da un fatto miracoloso avvenuto
in un tempo in cui (a quanto pare) i santi abbondavano, poiché
tutti i presenti hanno il nimbo. In mezzo a questi si riconoscono
dai loro abiti come ostiart i due che stanno a sinistra dell’al-
tare, come leviti i due di rimpetto; gli altri non hanno nessun
segno speciale. Tutti pregano, come nella seconda scena, con le
mani giunte e guardano l’immagine del Salvatore.
Aprendo la porticina non veniamo a contatto della pittura,
ma di una lamina massiccia d’argento, la quale presenta alcuni
minutissimi fori e fu applicata insieme alla porticina (fig. 15).
Manifestamente tale lamina non ha lo scopo di proteggere l’immagine, cosa divenuta superflua
da secoli. Essa non serve che a vie meglio consolidare la porticina.
Fig. 18
Ritratto d’una donatrice
D. Sportelli della custodia.
Per porre l’Acheropita al sicuro dai furti, verso la fine del secolo XIV essa fu rinchiusa
in una custodia di legno, la quale dapprima non aveva alcuna decorazione speciale. Soltanto
nell’anno 1405 un certo Giacomo figlio di Teulo Vetralla e canonico della basilica Latera-
nense ordinò nel suo testamento del 16 maggio che gli sportelli della custodia venissero
rivestiti di puro argento e adorni di figure : « Illi duo ostiuncoli sive tabulecte lignee exi-
stentes ante gloriosissimam imag'inem Salvatoris Domini Nostri Jesu Christi ad Sancta San-
ctorum, foderentur et ornentur, de puro argento, cum fìg'uris solum argenteis » 3
La volontà del testatore fu eseguita : lo sappiamo dai documenti scritti, come dal rivesti-
mento stesso pervenutoci in ottimo stato, ma non nella custodia originaria bensì in altra
1 Essa per citare un esempio ricorda quella del papa pag. 281.
Clemente VI (1342-1352) presso Muntz, La tiare pori- 2 Civiltà Cattolica, 1907, voi. I, pag. 449.
tificale du VIIIc au XVIe siècle, in Mémoires de l’Aca- 3 Cfr- Adinolfi, Romandi’ età di mezzo, sr. I, pag. 235.
démie des inscriptions et belles-lettres, voi. XXXVI, r, Non mi riuscì di rintracciare l’originale del Testamento.