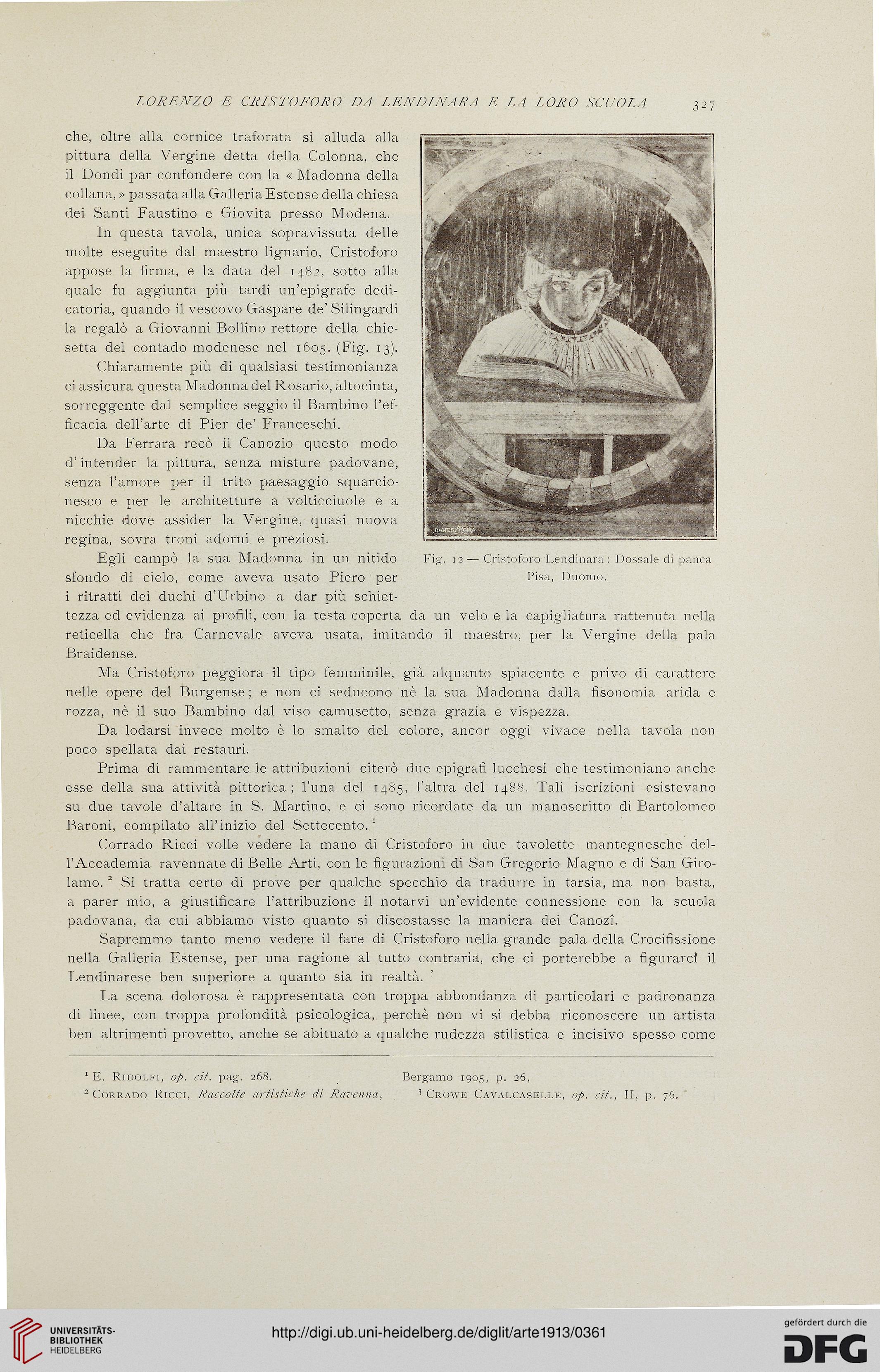LORENZO E CRISTOFORO DA LEATDINAR A E LA LORO SCUOLA
327
che, oltre alla cornice traforata si alluda alla
pittura della Vergine detta della Colonna, che
il Dondi par confondere con la « Madonna della
collana, » passata alla Galleria Estense della chiesa
dei Santi Faustino e Giovita presso Modena.
In questa tavola, unica sopravissuta delle
molte eseguite dal maestro lignario, Cristoforo
appose la firma, e la data del 1482, sotto alla
quale fu aggiunta più tardi un’epigrafe dedi-
catoria, quando il vescovo Gaspare de’ Silingardi
la regalò a Giovanni Bollino rettore della chie-
setta del contado modenese nel 1605. (Fig. 13).
Chiaramente più di qualsiasi testimonianza
ci assicura questa Madonna del Rosario, altocinta,
sorreggente dal semplice seggio il Bambino l’ef-
ficacia dell’arte di Pier de’ Franceschi.
Da Ferrara recò il Canozio questo modo
d’intender la pittura, senza misture padovane,
senza l’amore per il trito paesaggio squarcio-
nesco e per le architetture a volticciuole e a
nicchie dove assider la Vergine, quasi nuova
regina, sovra troni adorni e preziosi.
Egli campò la sua Madonna in un nitido
sfondo di cielo, come aveva usato Piero per
i ritratti dei duchi d’Urbino a dar più schiet-
tezza ed evidenza ai profili, con la testa coperta da un velo e la capigliatura rattenuta nella
reticella che fra Carnevale aveva usata, imitando il maestro, per la Vergine della pala
Braidense.
Ma Cristoforo peggiora il tipo femminile, già alquanto spiacente e privo di carattere
nelle opere del Burgense ; e non ci seducono nè la sua Madonna dalla fisonomia arida e
rozza, nè il suo Bambino dal viso camusetto, senza grazia e vispezza.
Da lodarsi invece molto è lo smalto del colore, ancor oggi vivace nella tavola non
poco spellata dai restauri.
Prima di rammentare le attribuzioni citerò due epigrafi lucchesi che testimoniano anche
esse della sua attività pittorica; duna del 1485, l’altra del 1488. Tali iscrizioni esistevano
su due tavole d’altare in S. Martino, e ci sono ricordate da un manoscritto di Bartolomeo
Baroni, compilato all’inizio del Settecento.1
Corrado Ricci volle vedere la mano di Cristoforo in due tavolette mantegnesche del-
l’Accademia ravennate di Belle Arti, con le figurazioni di San Gregorio Magno e di San Giro-
lamo. 2 Si tratta certo di prove per qualche specchio da tradurre in tarsia, ma non basta,
a parer mio, a giustificare l’attribuzione il notarvi un’evidente connessione con la scuola
padovana, da cui abbiamo visto quanto si discostasse la maniera dei Canozi.
Sapremmo tanto meno vedere il fare di Cristoforo nella grande pala della Crocifissione
nella Galleria Estense, per una ragione al tutto contraria, che ci porterebbe a figurarci il
Lendinarese ben superiore a quanto sia in realtà.
La scena dolorosa è rappresentata con troppa abbondanza di particolari e padronanza
di linee, con troppa profondità psicologica, perchè non vi si debba riconoscere un artista
ben altrimenti provetto, anche se abituato a qualche rudezza stilistica e incisivo spesso come
1 E. Ridolfi, op. cit. pag. 268. Bergamo 1905, p. 26,
2 Corrado Ricci, Raccolte artistiche di Ravenna, 3 Crowe Cavalcaseli^-:, op. cit., II, p. 76.
Fig. 12 — Cristoforo Lendinara : Dossale di panca
Pisa, Duomo.
327
che, oltre alla cornice traforata si alluda alla
pittura della Vergine detta della Colonna, che
il Dondi par confondere con la « Madonna della
collana, » passata alla Galleria Estense della chiesa
dei Santi Faustino e Giovita presso Modena.
In questa tavola, unica sopravissuta delle
molte eseguite dal maestro lignario, Cristoforo
appose la firma, e la data del 1482, sotto alla
quale fu aggiunta più tardi un’epigrafe dedi-
catoria, quando il vescovo Gaspare de’ Silingardi
la regalò a Giovanni Bollino rettore della chie-
setta del contado modenese nel 1605. (Fig. 13).
Chiaramente più di qualsiasi testimonianza
ci assicura questa Madonna del Rosario, altocinta,
sorreggente dal semplice seggio il Bambino l’ef-
ficacia dell’arte di Pier de’ Franceschi.
Da Ferrara recò il Canozio questo modo
d’intender la pittura, senza misture padovane,
senza l’amore per il trito paesaggio squarcio-
nesco e per le architetture a volticciuole e a
nicchie dove assider la Vergine, quasi nuova
regina, sovra troni adorni e preziosi.
Egli campò la sua Madonna in un nitido
sfondo di cielo, come aveva usato Piero per
i ritratti dei duchi d’Urbino a dar più schiet-
tezza ed evidenza ai profili, con la testa coperta da un velo e la capigliatura rattenuta nella
reticella che fra Carnevale aveva usata, imitando il maestro, per la Vergine della pala
Braidense.
Ma Cristoforo peggiora il tipo femminile, già alquanto spiacente e privo di carattere
nelle opere del Burgense ; e non ci seducono nè la sua Madonna dalla fisonomia arida e
rozza, nè il suo Bambino dal viso camusetto, senza grazia e vispezza.
Da lodarsi invece molto è lo smalto del colore, ancor oggi vivace nella tavola non
poco spellata dai restauri.
Prima di rammentare le attribuzioni citerò due epigrafi lucchesi che testimoniano anche
esse della sua attività pittorica; duna del 1485, l’altra del 1488. Tali iscrizioni esistevano
su due tavole d’altare in S. Martino, e ci sono ricordate da un manoscritto di Bartolomeo
Baroni, compilato all’inizio del Settecento.1
Corrado Ricci volle vedere la mano di Cristoforo in due tavolette mantegnesche del-
l’Accademia ravennate di Belle Arti, con le figurazioni di San Gregorio Magno e di San Giro-
lamo. 2 Si tratta certo di prove per qualche specchio da tradurre in tarsia, ma non basta,
a parer mio, a giustificare l’attribuzione il notarvi un’evidente connessione con la scuola
padovana, da cui abbiamo visto quanto si discostasse la maniera dei Canozi.
Sapremmo tanto meno vedere il fare di Cristoforo nella grande pala della Crocifissione
nella Galleria Estense, per una ragione al tutto contraria, che ci porterebbe a figurarci il
Lendinarese ben superiore a quanto sia in realtà.
La scena dolorosa è rappresentata con troppa abbondanza di particolari e padronanza
di linee, con troppa profondità psicologica, perchè non vi si debba riconoscere un artista
ben altrimenti provetto, anche se abituato a qualche rudezza stilistica e incisivo spesso come
1 E. Ridolfi, op. cit. pag. 268. Bergamo 1905, p. 26,
2 Corrado Ricci, Raccolte artistiche di Ravenna, 3 Crowe Cavalcaseli^-:, op. cit., II, p. 76.
Fig. 12 — Cristoforo Lendinara : Dossale di panca
Pisa, Duomo.