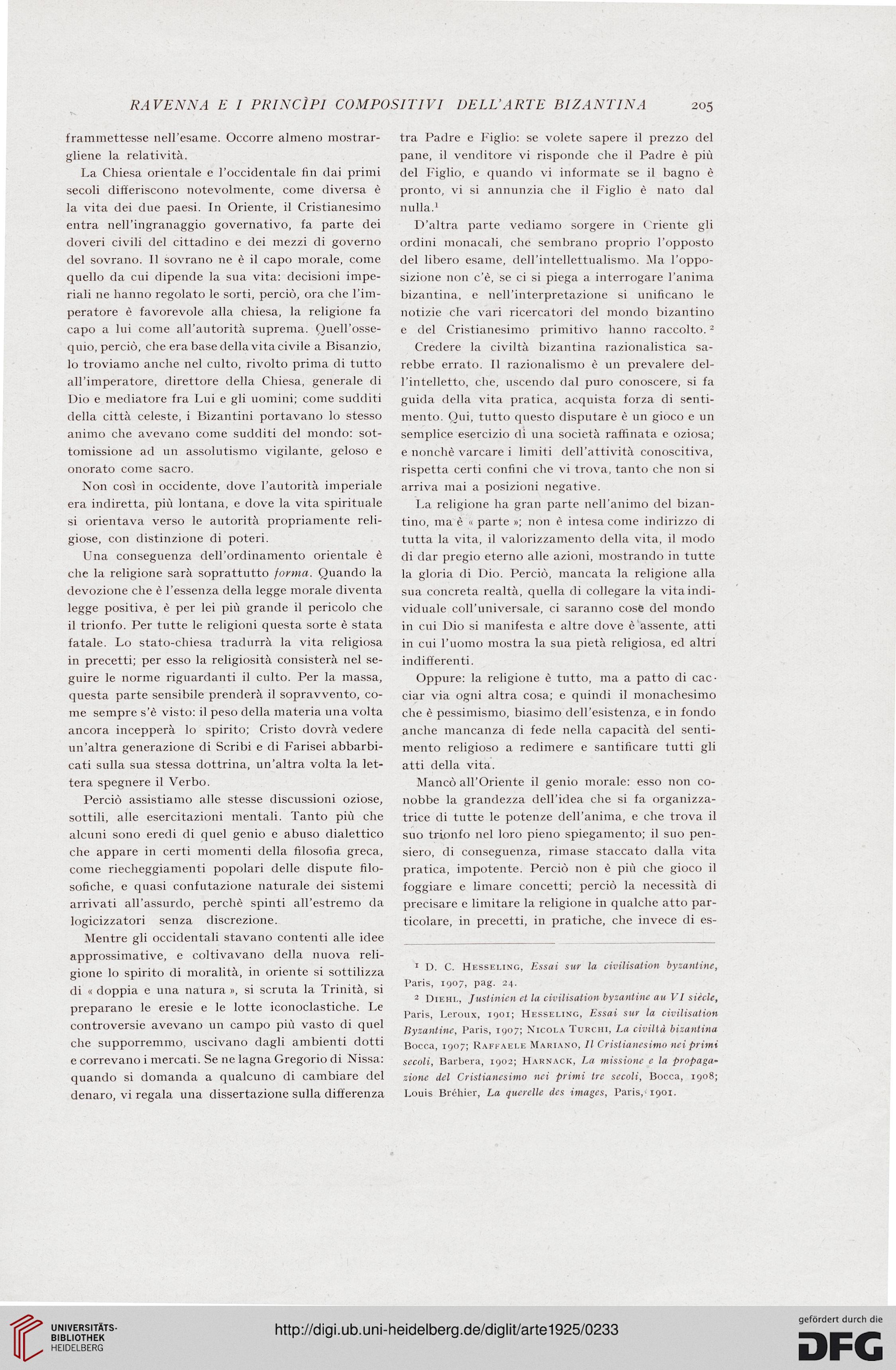RAVENNA E I PRINCÌPI COMPOSITIVI DELL'ARTE BIZANTINA 205
frammettesse nell'esame. Occorre almeno mostrar-
gliene la relatività.
La Chiesa orientale e l'occidentale fin dai primi
secoli differiscono notevolmente, come diversa è
la vita dei due paesi. In Oriente, il Cristianesimo
entra nell'ingranaggio governativo, fa parte dei
doveri civili del cittadino e dei mezzi di governo
del sovrano. Il sovrano ne è il capo morale, come
quello da cui dipende la sua vita: decisioni impe-
riali ne hanno regolato le sorti, perciò, ora che l'im-
peratore è favorevole alla chiesa, la religione fa
capo a lui come all'autorità suprema. Quell'osse-
quio, perciò, che era base della vi taci vile a Bisanzio,
10 troviamo anche nel culto, rivolto prima di tutto
all'imperatore, direttore della Chiesa, generale di
Dio e mediatore fra Lui e gli uomini; come sudditi
della città celeste, i Bizantini portavano lo stesso
animo che avevano come sudditi del mondo: sot-
tomissione ad un assolutismo vigilante, geloso e
onorato come sacro.
Non così in occidente, dove l'autorità imperiale
era indiretta, più lontana, e dove la vita spirituale
si orientava verso le autorità propriamente reli-
giose, con distinzione di poteri.
Una conseguenza dell'ordinamento orientale è
che la religione sarà soprattutto forma. Quando la
devozione che è l'essenza della legge morale diventa
legge positiva, è per lei più grande il pericolo che
11 trionfo. Per tutte le religioni questa sorte è stata
fatale. Lo stato-chiesa tradurrà la vita religiosa
in precetti; per esso la religiosità consisterà nel se-
guire le norme riguardanti il culto. Per la massa,
questa parte sensibile prenderà il sopravvento, co-
me sempre s'è visto: il peso della materia una volta
ancora incepperà lo spirito; Cristo dovrà vedere
un'altra generazione di Scribi e di Farisei abbarbi-
cati sulla sua stessa dottrina, un'altra volta la let-
tera spegnere il Verbo.
Perciò assistiamo alle stesse discussioni oziose,
sottili, alle esercitazioni mentali. Tanto più che
alcuni sono eredi di quel genio e abuso dialettico
che appare in certi momenti della filosofia greca,
come riecheggiamenti popolari delle dispute filo-
sofiche, e quasi confutazione naturale dei sistemi
arrivati all'assurdo, perchè spinti all'estremo da
logicizzatori senza discrezione.
Mentre gli occidentali stavano contenti alle idee
approssimative, e coltivavano della nuova reli-
gione lo spirito di moralità, in oriente si sottilizza
di « doppia e una natura », si scruta la Trinità, si
preparano le eresie e le lotte iconoclastiche. Le
controversie avevano un campo più vasto di quel
che supporremmo, uscivano dagli ambienti dotti
e correvano i mercati. Se ne lagna Gregorio di Nissa:
quando si domanda a qualcuno di cambiare del
denaro, vi regala una dissertazione sulla differenza
tra Padre e Piglio: se volete sapere il prezzo del
pane, il venditore vi risponde che il Padre è più
del Figlio, e quando vi informate se il bagno è
pronto, vi si annunzia che il Figlio è nato dal
nulla.1
D'altra parte vediamo sorgere in ( riente gli
ordini monacali, che sembrano proprio l'opposto
del libero esame, dell'intellettualismo. Ma l'oppo-
sizione non c'è, se ci si piega a interrogare l'anima
bizantina, e nell'interpretazione si unificano le
notizie che vari ricercatori del mondo bizantino
e del Cristianesimo primitivo hanno raccolto.2
Credere la civiltà bizantina razionalistica sa-
rebbe errato. 11 razionalismo è un prevalere del-
l'intelletto, che, uscendo dal puro conoscere, si fa
guida della vita pratica, acquista forza di senti-
mento. (>ui, tutto questo disputare è un gioco e un
semplice esercizio di una società raffinata e oziosa;
e nonché varcare i limiti dell'attività conoscitiva,
rispetta certi confini che vi trova, tanto che non si
arriva mai a posizioni negative.
La religione ha gran parte nell'animo del bizan-
tino, ma è « parte »; non è intesa come indirizzo di
tutta la vita, il valorizzamento della vita, il modo
di dar pregio eterno alle azioni, mostrando in tutte
la gloria di Dio. Perciò, mancata la religione alla
sua concreta realtà, quella di collegare la vita indi-
viduale coll'universale, ci saranno cose del mondo
in cui Dio si manifesta e altre dove è assente, atti
in cui l'uomo mostra la sua pietà religiosa, ed altri
indifferenti.
Oppure: la religione è tutto, ma a patto di cac-
ciar via ogni altra cosa; e quindi il monachesimo
che è pessimismo, biasimo dell'esistenza, e in fondo
anche mancanza di fede nella capacità del senti-
mento religioso a redimere e santificare tutti gli
atti della vita.
Mancò all'Oriente il genio morale: esso non co-
nobbe la grandezza dell'idea che si fa organizza-
trice di tutte le potenze dell'anima, e che trova il
suo trionfo nel loro pieno spiegamento; il suo pen-
siero, di conseguenza, rimase staccato dalla vita
pratica, impotente. Perciò non è più che gioco il
foggiare e limare concetti; perciò la necessità di
precisare e limitare la religione in qualche atto par-
ticolare, in precetti, in pratiche, che invece di es-
1 I). C. Hesseung, Essai sur la civilisation byzantine,
Paris, 1907, pag. 24.
2 Diehi., Justinien et la civilisation byzantine au VI siècle,
Paris, Leroux, 1901; Hesseling, Essai sur la civilisation
Byzantine, Paris, 1907; Nicola Turchi, La civiltà bizantina
Bocca, 1907; Raffaele Mariano, // Cristianesimo nei primi
secoli. Barbera, 1902; Harnack, La missione e la propaga-
zione del Cristianesimo nei primi tre secoli, Bocca, 1908;
Louis Bréhier, La querelle des images, Paris, 1901.
frammettesse nell'esame. Occorre almeno mostrar-
gliene la relatività.
La Chiesa orientale e l'occidentale fin dai primi
secoli differiscono notevolmente, come diversa è
la vita dei due paesi. In Oriente, il Cristianesimo
entra nell'ingranaggio governativo, fa parte dei
doveri civili del cittadino e dei mezzi di governo
del sovrano. Il sovrano ne è il capo morale, come
quello da cui dipende la sua vita: decisioni impe-
riali ne hanno regolato le sorti, perciò, ora che l'im-
peratore è favorevole alla chiesa, la religione fa
capo a lui come all'autorità suprema. Quell'osse-
quio, perciò, che era base della vi taci vile a Bisanzio,
10 troviamo anche nel culto, rivolto prima di tutto
all'imperatore, direttore della Chiesa, generale di
Dio e mediatore fra Lui e gli uomini; come sudditi
della città celeste, i Bizantini portavano lo stesso
animo che avevano come sudditi del mondo: sot-
tomissione ad un assolutismo vigilante, geloso e
onorato come sacro.
Non così in occidente, dove l'autorità imperiale
era indiretta, più lontana, e dove la vita spirituale
si orientava verso le autorità propriamente reli-
giose, con distinzione di poteri.
Una conseguenza dell'ordinamento orientale è
che la religione sarà soprattutto forma. Quando la
devozione che è l'essenza della legge morale diventa
legge positiva, è per lei più grande il pericolo che
11 trionfo. Per tutte le religioni questa sorte è stata
fatale. Lo stato-chiesa tradurrà la vita religiosa
in precetti; per esso la religiosità consisterà nel se-
guire le norme riguardanti il culto. Per la massa,
questa parte sensibile prenderà il sopravvento, co-
me sempre s'è visto: il peso della materia una volta
ancora incepperà lo spirito; Cristo dovrà vedere
un'altra generazione di Scribi e di Farisei abbarbi-
cati sulla sua stessa dottrina, un'altra volta la let-
tera spegnere il Verbo.
Perciò assistiamo alle stesse discussioni oziose,
sottili, alle esercitazioni mentali. Tanto più che
alcuni sono eredi di quel genio e abuso dialettico
che appare in certi momenti della filosofia greca,
come riecheggiamenti popolari delle dispute filo-
sofiche, e quasi confutazione naturale dei sistemi
arrivati all'assurdo, perchè spinti all'estremo da
logicizzatori senza discrezione.
Mentre gli occidentali stavano contenti alle idee
approssimative, e coltivavano della nuova reli-
gione lo spirito di moralità, in oriente si sottilizza
di « doppia e una natura », si scruta la Trinità, si
preparano le eresie e le lotte iconoclastiche. Le
controversie avevano un campo più vasto di quel
che supporremmo, uscivano dagli ambienti dotti
e correvano i mercati. Se ne lagna Gregorio di Nissa:
quando si domanda a qualcuno di cambiare del
denaro, vi regala una dissertazione sulla differenza
tra Padre e Piglio: se volete sapere il prezzo del
pane, il venditore vi risponde che il Padre è più
del Figlio, e quando vi informate se il bagno è
pronto, vi si annunzia che il Figlio è nato dal
nulla.1
D'altra parte vediamo sorgere in ( riente gli
ordini monacali, che sembrano proprio l'opposto
del libero esame, dell'intellettualismo. Ma l'oppo-
sizione non c'è, se ci si piega a interrogare l'anima
bizantina, e nell'interpretazione si unificano le
notizie che vari ricercatori del mondo bizantino
e del Cristianesimo primitivo hanno raccolto.2
Credere la civiltà bizantina razionalistica sa-
rebbe errato. 11 razionalismo è un prevalere del-
l'intelletto, che, uscendo dal puro conoscere, si fa
guida della vita pratica, acquista forza di senti-
mento. (>ui, tutto questo disputare è un gioco e un
semplice esercizio di una società raffinata e oziosa;
e nonché varcare i limiti dell'attività conoscitiva,
rispetta certi confini che vi trova, tanto che non si
arriva mai a posizioni negative.
La religione ha gran parte nell'animo del bizan-
tino, ma è « parte »; non è intesa come indirizzo di
tutta la vita, il valorizzamento della vita, il modo
di dar pregio eterno alle azioni, mostrando in tutte
la gloria di Dio. Perciò, mancata la religione alla
sua concreta realtà, quella di collegare la vita indi-
viduale coll'universale, ci saranno cose del mondo
in cui Dio si manifesta e altre dove è assente, atti
in cui l'uomo mostra la sua pietà religiosa, ed altri
indifferenti.
Oppure: la religione è tutto, ma a patto di cac-
ciar via ogni altra cosa; e quindi il monachesimo
che è pessimismo, biasimo dell'esistenza, e in fondo
anche mancanza di fede nella capacità del senti-
mento religioso a redimere e santificare tutti gli
atti della vita.
Mancò all'Oriente il genio morale: esso non co-
nobbe la grandezza dell'idea che si fa organizza-
trice di tutte le potenze dell'anima, e che trova il
suo trionfo nel loro pieno spiegamento; il suo pen-
siero, di conseguenza, rimase staccato dalla vita
pratica, impotente. Perciò non è più che gioco il
foggiare e limare concetti; perciò la necessità di
precisare e limitare la religione in qualche atto par-
ticolare, in precetti, in pratiche, che invece di es-
1 I). C. Hesseung, Essai sur la civilisation byzantine,
Paris, 1907, pag. 24.
2 Diehi., Justinien et la civilisation byzantine au VI siècle,
Paris, Leroux, 1901; Hesseling, Essai sur la civilisation
Byzantine, Paris, 1907; Nicola Turchi, La civiltà bizantina
Bocca, 1907; Raffaele Mariano, // Cristianesimo nei primi
secoli. Barbera, 1902; Harnack, La missione e la propaga-
zione del Cristianesimo nei primi tre secoli, Bocca, 1908;
Louis Bréhier, La querelle des images, Paris, 1901.