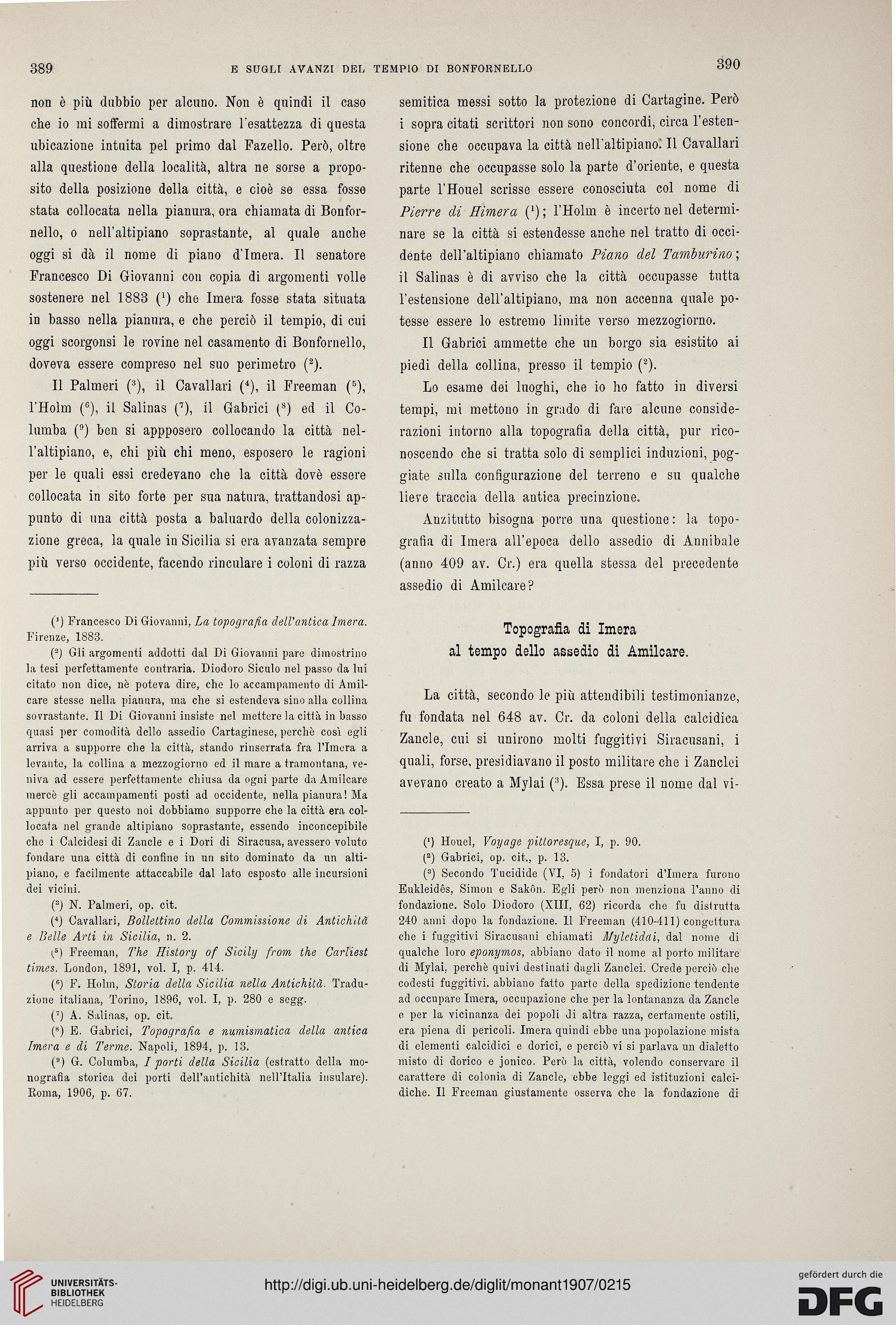389
K SUGLI AVANZI DEL TEMPIO DI BONFORNELLO
390
non è più dubbio per alcuno. Non è quindi il caso
che io mi soffermi a dimostrare l'esattezza di questa
ubicazione intuita pel primo dal Pazello. Però, oltre
alla questione della località, altra ne sorse a propo-
sito della posizione della città, e cioè se essa fosse
stata collocata nella pianura, ora chiamata di Bonfor-
nello, o nell'altipiano soprastante, al quale anche
oggi si dà il nome di piano d'Imera. Il senatore
Francesco Di Giovanni con copia di argomenti volle
sostenere nel 1883 (') che Imera fosse stata situata
in basso nella pianura, e che perciò il tempio, di cui
oggi scorgonsi le rovine nel casamento di Bonfornello,
doveva essere compreso nel suo perimetro (2).
Il Palmeri (:t), il Cavallari (4), il Freeman (5),
l'Holm (•), il Salinas (7), il Gabrici (s) ed il Co-
lumba (9) ben si appposero collocando la città nel-
l'altipiano, e, chi più chi meno, esposero le ragioni
per le quali essi credevano che la città dovè essere
collocata in sito forte per sua natura, trattandosi ap-
punto di una città posta a baluardo della colonizza-
zione greca, la quale in Sicilia si era avanzata sempre
più verso occidente, facendo rinculare i coloni di razza
(') Francesco Di Giovanni, La topografia dell'antica lmera.
Firenze, 1883.
(2) Gli argomenti addotti dal Di Giovanni pare dimostrino
la tesi perfettamente contraria. Diodoro Siculo nel passo da Ini
citato non dice, nè poteva dire, che lo accampamento di Amil-
care stesse nella pianura, ma che si estendeva sino alla collina
sovrastante. Il Di Giovanni insiste nel mettere la città in basso
quasi per comodità dello assedio Cartaginese, perchè cosi egli
arriva a supporre che la città, stando rinserrata fra rimerà a
levante, la collina a mezzogiorno ed il mare a tramontana, ve-
niva ad essere perfettamente chiusa da ogni parte da Amilcare
mercè gli accampamenti posti ad occidente, nella pianura! Ma
appunto per questo noi dobbiamo supporre che la città era col-
locata nel grande altipiano soprastante, essendo inconcepibile
che i Calcidesi di Zancle e i Dori di Siracusa, avessero voluto
fondare una città di confine in un sito dominato da un alti-
piano, e facilmente attaccabile dal lato esposto alle incursioni
dei vicini.
(3) N. Palmeri, op. cit.
(*) Cavallari, Bollettino della Commissione di Antichità
e Belle Arti in Sicilia, ri. 2.
i,6) Freeman, The Ilistory of Sicily front the Garliest
times. London, 1891, voi. I, p. 414.
(r') F, Holm, Storia della Sicilia nella Antichità. Tradu-
zione italiana, Torino, 1896, voi. I, p. 280 e segg.
(7) A. Salinas, op. cit.
(8) E. Gabrici, Topografia e numismatica della antica
Imera e di Terme. Napoli, 1894, p. 13.
(9) G. Columba, I porti della Sicilia (estratto della mo-
nografia storica dei porti dell'antichità nell'Italia insulare).
Roma, 1906, p. 67.
semitica messi sotto la protezione di Cartagine. Però
i sopra citati scrittori non sono concordi, circa l'esten-
sione che occupava la città nell'altipiano; Il Cavallari
ritenne che occupasse solo la parte d'oriente, e questa
parte l'Houel scrisse essere conosciuta col nome di
Pierre di Rimerà ('); l'Holm è incerto nel determi-
nare se la città si estendesse anche nel tratto di occi-
dente dell'altipiano chiamato Piano del Tamburino ;
il Salinas è di avviso che la città occupasse tutta
l'estensione dell'altipiano, ma non accenna quale po-
tesse essere lo estremo limite verso mezzogiorno.
Il Gabrici ammette che un borgo sia esistito ai
piedi della collina, presso il tempio (2).
Lo esame dei luoghi, che io ho fatto in diversi
tempi, mi mettono in grado di fare alcune conside-
razioni intorno alla topografìa della città, pur rico-
noscendo che si tratta solo di semplici induzioni, pog-
giate sulla configurazione del terreno e su qualche
lieve traccia della antica precinzione.
Anzitutto bisogna porre una questione : la topo-
grafìa di Imera all'epoca dello assedio di Annibale
(anno 409 av. Cr.) era quella stessa del precedente
assedio di Amilcare?
Topografia di Imera
al tempo dello assedio di Amilcare.
La città, secondo le più attendibili testimonianze,
fu fondata nel 648 av. Cr. da coloni della calcidica
Zancle, cui si unirono molti fuggitivi Siracusani, i
quali, forse, presidiavano il posto militare che i Zanclei
avevano creato a Mylai ('). Essa prese il nome dal vi-
(') Houel, Voyage pittoresque, I, p. 90.
(2) Gabrici, op. cit., p. 13.
(3) Secondo Tucidide (VI, 5) i fondatori d'Imera furono
Eukleidés, Simon e Sakón. Egli però non menziona l'anno di
fondazione. Solo Diodoro (XIII, 62) ricorda che fu distrutta
240 anni dopo la fondazione. 11 Freeman (410-411) congettura
che i fuggitivi Siracusani chiamati Mylctidai, dal nome di
qualche loro eponymos, abbiano dato il nome al porto militare
di Mylai. perchè quivi destinati dagli Zanclei. Crede perciò che
codesti fuggitivi, abbiano fatto parte della spedizione tendente
ad occupare Imera, occupazione che per la lontananza da Zancle
e per la vicinanza dei popoli di altra razza, certamente ostili,
era piena di pericoli. Imera quindi ebbe una popolazione mista
di elementi calcidici e dorici, e perciò vi si parlava un dialetto
misto di dorico e jonico. Però la città, volendo conservare il
carattere di colonia di Zancle, ebbe leggi ed istituzioni calci-
diche. Il Freeman giustamente osserva che la fondazione di
K SUGLI AVANZI DEL TEMPIO DI BONFORNELLO
390
non è più dubbio per alcuno. Non è quindi il caso
che io mi soffermi a dimostrare l'esattezza di questa
ubicazione intuita pel primo dal Pazello. Però, oltre
alla questione della località, altra ne sorse a propo-
sito della posizione della città, e cioè se essa fosse
stata collocata nella pianura, ora chiamata di Bonfor-
nello, o nell'altipiano soprastante, al quale anche
oggi si dà il nome di piano d'Imera. Il senatore
Francesco Di Giovanni con copia di argomenti volle
sostenere nel 1883 (') che Imera fosse stata situata
in basso nella pianura, e che perciò il tempio, di cui
oggi scorgonsi le rovine nel casamento di Bonfornello,
doveva essere compreso nel suo perimetro (2).
Il Palmeri (:t), il Cavallari (4), il Freeman (5),
l'Holm (•), il Salinas (7), il Gabrici (s) ed il Co-
lumba (9) ben si appposero collocando la città nel-
l'altipiano, e, chi più chi meno, esposero le ragioni
per le quali essi credevano che la città dovè essere
collocata in sito forte per sua natura, trattandosi ap-
punto di una città posta a baluardo della colonizza-
zione greca, la quale in Sicilia si era avanzata sempre
più verso occidente, facendo rinculare i coloni di razza
(') Francesco Di Giovanni, La topografia dell'antica lmera.
Firenze, 1883.
(2) Gli argomenti addotti dal Di Giovanni pare dimostrino
la tesi perfettamente contraria. Diodoro Siculo nel passo da Ini
citato non dice, nè poteva dire, che lo accampamento di Amil-
care stesse nella pianura, ma che si estendeva sino alla collina
sovrastante. Il Di Giovanni insiste nel mettere la città in basso
quasi per comodità dello assedio Cartaginese, perchè cosi egli
arriva a supporre che la città, stando rinserrata fra rimerà a
levante, la collina a mezzogiorno ed il mare a tramontana, ve-
niva ad essere perfettamente chiusa da ogni parte da Amilcare
mercè gli accampamenti posti ad occidente, nella pianura! Ma
appunto per questo noi dobbiamo supporre che la città era col-
locata nel grande altipiano soprastante, essendo inconcepibile
che i Calcidesi di Zancle e i Dori di Siracusa, avessero voluto
fondare una città di confine in un sito dominato da un alti-
piano, e facilmente attaccabile dal lato esposto alle incursioni
dei vicini.
(3) N. Palmeri, op. cit.
(*) Cavallari, Bollettino della Commissione di Antichità
e Belle Arti in Sicilia, ri. 2.
i,6) Freeman, The Ilistory of Sicily front the Garliest
times. London, 1891, voi. I, p. 414.
(r') F, Holm, Storia della Sicilia nella Antichità. Tradu-
zione italiana, Torino, 1896, voi. I, p. 280 e segg.
(7) A. Salinas, op. cit.
(8) E. Gabrici, Topografia e numismatica della antica
Imera e di Terme. Napoli, 1894, p. 13.
(9) G. Columba, I porti della Sicilia (estratto della mo-
nografia storica dei porti dell'antichità nell'Italia insulare).
Roma, 1906, p. 67.
semitica messi sotto la protezione di Cartagine. Però
i sopra citati scrittori non sono concordi, circa l'esten-
sione che occupava la città nell'altipiano; Il Cavallari
ritenne che occupasse solo la parte d'oriente, e questa
parte l'Houel scrisse essere conosciuta col nome di
Pierre di Rimerà ('); l'Holm è incerto nel determi-
nare se la città si estendesse anche nel tratto di occi-
dente dell'altipiano chiamato Piano del Tamburino ;
il Salinas è di avviso che la città occupasse tutta
l'estensione dell'altipiano, ma non accenna quale po-
tesse essere lo estremo limite verso mezzogiorno.
Il Gabrici ammette che un borgo sia esistito ai
piedi della collina, presso il tempio (2).
Lo esame dei luoghi, che io ho fatto in diversi
tempi, mi mettono in grado di fare alcune conside-
razioni intorno alla topografìa della città, pur rico-
noscendo che si tratta solo di semplici induzioni, pog-
giate sulla configurazione del terreno e su qualche
lieve traccia della antica precinzione.
Anzitutto bisogna porre una questione : la topo-
grafìa di Imera all'epoca dello assedio di Annibale
(anno 409 av. Cr.) era quella stessa del precedente
assedio di Amilcare?
Topografia di Imera
al tempo dello assedio di Amilcare.
La città, secondo le più attendibili testimonianze,
fu fondata nel 648 av. Cr. da coloni della calcidica
Zancle, cui si unirono molti fuggitivi Siracusani, i
quali, forse, presidiavano il posto militare che i Zanclei
avevano creato a Mylai ('). Essa prese il nome dal vi-
(') Houel, Voyage pittoresque, I, p. 90.
(2) Gabrici, op. cit., p. 13.
(3) Secondo Tucidide (VI, 5) i fondatori d'Imera furono
Eukleidés, Simon e Sakón. Egli però non menziona l'anno di
fondazione. Solo Diodoro (XIII, 62) ricorda che fu distrutta
240 anni dopo la fondazione. 11 Freeman (410-411) congettura
che i fuggitivi Siracusani chiamati Mylctidai, dal nome di
qualche loro eponymos, abbiano dato il nome al porto militare
di Mylai. perchè quivi destinati dagli Zanclei. Crede perciò che
codesti fuggitivi, abbiano fatto parte della spedizione tendente
ad occupare Imera, occupazione che per la lontananza da Zancle
e per la vicinanza dei popoli di altra razza, certamente ostili,
era piena di pericoli. Imera quindi ebbe una popolazione mista
di elementi calcidici e dorici, e perciò vi si parlava un dialetto
misto di dorico e jonico. Però la città, volendo conservare il
carattere di colonia di Zancle, ebbe leggi ed istituzioni calci-
diche. Il Freeman giustamente osserva che la fondazione di