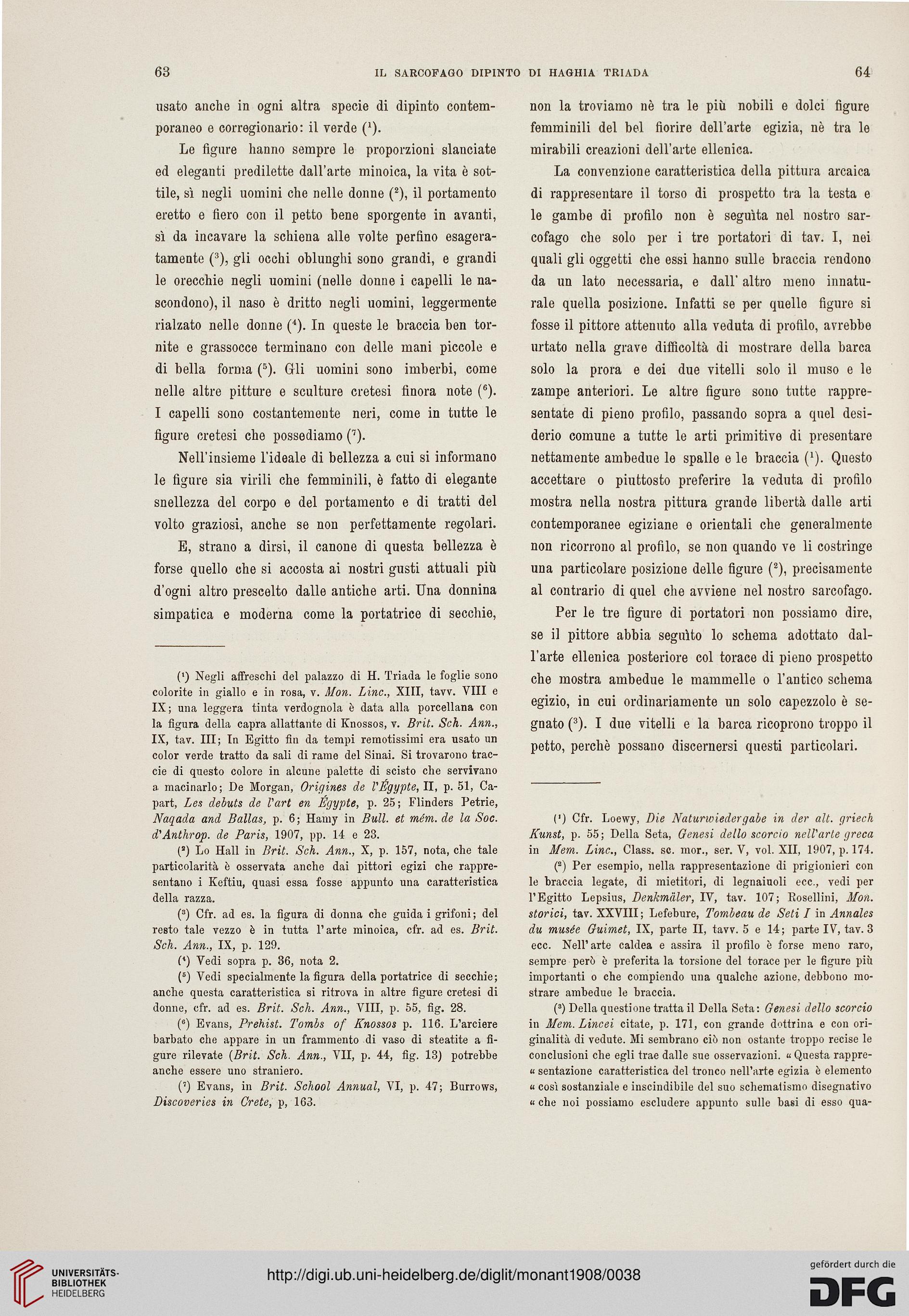63
IL SARCOFAGO DIPINTO DI HAGH1A TRIADA
64
usato anche in ogni altra specie di dipinto contem-
poraneo e corregionario: il verde (').
Le figure hanno sempre le proporzioni slanciate
ed eleganti predilette dall'arte minoica, la vita è sot-
tile, sì negli uomini che nelle donne (2), il portamento
eretto e fiero con il petto bene sporgente in avanti,
sì da incavare la schiena alle volte perfino esagera-
tamente (3), gli occhi oblunghi sono grandi, e grandi
le orecchie negli uomini (nelle donne i capelli le na-
scondono), il naso è dritto negli uomini, leggermente
rialzato nelle donne (4). In queste le braccia ben tor-
nite e grassocce terminano con delle mani piccole e
di bella forma (5). Gli uomini sono imberbi, come
nelle altre pitture e sculture cretesi finora note (6).
I capelli sono costantemente neri, come in tutte le
figure cretesi che possediamo (7).
Nell'insieme l'ideale di bellezza a cui si informano
le figure sia virili che femminili, è fatto di elegante
snellezza del corpo e del portamento e di tratti del
volto graziosi, anche se non perfettamente regolari.
E, strano a dirsi, il canone di questa bellezza è
forse quello che si accosta ai nostri gusti attuali più
d'ogni altro prescelto dalle antiche arti. Una donnina
simpatica e moderna come la portatrice di secchie,
(') Negli affreschi del palazzo di H. Triada le foglie sono
colorite in giallo e in rosa, v. Mon. Line, XIII, tavv. Vili e
IX; una leggera tinta verdognola è data alla porcellana con
la figura della capra allattante di Knossos, v. Bril. Sch. Ann.,
IX, tav. Ili; In Egitto fin da tempi remotissimi era usato un
color verde tratto da sali di rame del Sinai. Si trovarono trac-
eie di questo colore in alcune palette di scisto che servivano
a macinarlo; De Morgan, Oriqines de VEgypte, II, p. 51, Ca-
part, Les debuts de l'art en Egypte, p. 25; Flinders Petrie,
Naqada and Ballas, p. 6; Hamy in Bull, et mém. de la Soc.
d'Anthrop. de Paris, 1907, pp. 14 e 23.
(•) Lo Hall in Brit. Sch. Ann., X, p. 157, nota, che tale
particolarità è osservata anche dai pittori egizi che rappre-
sentano i Keftiu, quasi essa fosse appunto una caratteristica
della razza.
(3) Cfr. ad es. la figura di donna che guida i grifoni ; del
resto tale vezzo è in tutta l'arte minoica, cfr. ad es. Brit.
Sch. Ann., IX, p. 129.
(*) Vedi sopra p. 36, nota 2.
(6) Vedi specialmente la figura della portatrice di secchie;
anche questa caratteristica si ritrova in altre figure cretesi di
donne, cfr. ad es. Brit. Sch. Ann., VIII, p. 55, fig. 28.
(6) Evans, Prehist. Tombs of Knossos p. 116. L'arciere
barbato che appare in un frammento di vaso di steatite a fi-
gure rilevate {Brit. Sch. Ann., VII, p. 44, fig. 13) potrebbe
anche essere uno straniero.
(') Evans, in Brit. School Annual, VI, p. 47; Burrows,
Discover ics in Crete, p, 163.
non la troviamo nè tra le più nobili e dolci figure
femminili del bel fiorire dell'arte egizia, nè tra le
mirabili creazioni dell'arte ellenica.
La convenzione caratteristica della pittura arcaica
di rappresentare il torso di prospetto tra la testa e
le gambe di profilo non è seguita nel nostro sar-
cofago che solo per i tre portatori di tav. I, nei
quali gli oggetti che essi hanno sulle braccia rendono
da un lato necessaria, e dall' altro meno innatu-
rale quella posizione. Infatti se per quelle figure si
fosse il pittore attenuto alla veduta di profilo, avrebbe
urtato nella grave difficoltà di mostrare della barca
solo la prora e dei due vitelli solo il muso e le
zampe anteriori. Le altre figure sono tutte rappre-
sentate di pieno profilo, passando sopra a quel desi-
derio comune a tutte le arti primitive di presentare
nettamente ambedue le spalle e le braccia ('). Questo
accettare o piuttosto preferire la veduta di profilo
mostra nella nostra pittura grande libertà dalle arti
contemporanee egiziane e orientali che generalmente
non ricorrono al profilo, se non quando ve li costringe
una particolare posizione delle figure (2), precisamente
al contrario di quel che avviene nel nostro sarcofago.
Per le tre figure di portatori non possiamo dire,
se il pittore abbia seguito lo schema adottato dal-
l'arte ellenica posteriore col torace di pieno prospetto
che mostra ambedue le mammelle o l'antico schema
egizio, in cui ordinariamente un solo capezzolo è se-
gnato (3). I due vitelli e la barca ricoprono troppo il
petto, perchè possano discernersi questi particolari.
(') Cfr. Loewy, Die Naturwiedergale in der alt. griech
Kunst, p. 55; Della Seta, Genesi dello scorcio nell'arie greca
in Mem. Line, Class, se. mor., ser. V, voi. XII, 1907, p. 174.
(a) Per esempio, nella rappresentazione di prigionieri con
le braccia legate, di mietitori, di legnaiuoli ecc., vedi per
l'Egitto Lepsius, Denkmàler, IV, tav. 107; Rosellini, Mon.
storici, tav. XXVIII; Lefebure, Tombeau de Seti I in Annales
du musée Guimet, IX, parte II, tavv. 5 e 14; parte IV, tav. 3
ecc. Nell'arte caldea e assira il profilo è forse meno raro,
sempre però è preferita la torsione del torace per le figure più
importanti o che compiendo una qualche azione, debbono mo-
strare ambedue le braccia.
(8) Della questione tratta il Della Seta: Genesi dello scorcio
in Mem. Lincei citate, p. 171, con grande dottrina e con ori-
ginalità di vedute. Mi sembrano ciò non ostante troppo recise le
conclusioni che egli trae dalle sue osservazioni. « Questa rappre-
« sentazione caratteristica del tronco nell'arte egizia è elemento
« così sostanziale e inscindibile del suo schematismo disegnativo
u che noi possiamo escludere appunto sulle basi di esso qua-
IL SARCOFAGO DIPINTO DI HAGH1A TRIADA
64
usato anche in ogni altra specie di dipinto contem-
poraneo e corregionario: il verde (').
Le figure hanno sempre le proporzioni slanciate
ed eleganti predilette dall'arte minoica, la vita è sot-
tile, sì negli uomini che nelle donne (2), il portamento
eretto e fiero con il petto bene sporgente in avanti,
sì da incavare la schiena alle volte perfino esagera-
tamente (3), gli occhi oblunghi sono grandi, e grandi
le orecchie negli uomini (nelle donne i capelli le na-
scondono), il naso è dritto negli uomini, leggermente
rialzato nelle donne (4). In queste le braccia ben tor-
nite e grassocce terminano con delle mani piccole e
di bella forma (5). Gli uomini sono imberbi, come
nelle altre pitture e sculture cretesi finora note (6).
I capelli sono costantemente neri, come in tutte le
figure cretesi che possediamo (7).
Nell'insieme l'ideale di bellezza a cui si informano
le figure sia virili che femminili, è fatto di elegante
snellezza del corpo e del portamento e di tratti del
volto graziosi, anche se non perfettamente regolari.
E, strano a dirsi, il canone di questa bellezza è
forse quello che si accosta ai nostri gusti attuali più
d'ogni altro prescelto dalle antiche arti. Una donnina
simpatica e moderna come la portatrice di secchie,
(') Negli affreschi del palazzo di H. Triada le foglie sono
colorite in giallo e in rosa, v. Mon. Line, XIII, tavv. Vili e
IX; una leggera tinta verdognola è data alla porcellana con
la figura della capra allattante di Knossos, v. Bril. Sch. Ann.,
IX, tav. Ili; In Egitto fin da tempi remotissimi era usato un
color verde tratto da sali di rame del Sinai. Si trovarono trac-
eie di questo colore in alcune palette di scisto che servivano
a macinarlo; De Morgan, Oriqines de VEgypte, II, p. 51, Ca-
part, Les debuts de l'art en Egypte, p. 25; Flinders Petrie,
Naqada and Ballas, p. 6; Hamy in Bull, et mém. de la Soc.
d'Anthrop. de Paris, 1907, pp. 14 e 23.
(•) Lo Hall in Brit. Sch. Ann., X, p. 157, nota, che tale
particolarità è osservata anche dai pittori egizi che rappre-
sentano i Keftiu, quasi essa fosse appunto una caratteristica
della razza.
(3) Cfr. ad es. la figura di donna che guida i grifoni ; del
resto tale vezzo è in tutta l'arte minoica, cfr. ad es. Brit.
Sch. Ann., IX, p. 129.
(*) Vedi sopra p. 36, nota 2.
(6) Vedi specialmente la figura della portatrice di secchie;
anche questa caratteristica si ritrova in altre figure cretesi di
donne, cfr. ad es. Brit. Sch. Ann., VIII, p. 55, fig. 28.
(6) Evans, Prehist. Tombs of Knossos p. 116. L'arciere
barbato che appare in un frammento di vaso di steatite a fi-
gure rilevate {Brit. Sch. Ann., VII, p. 44, fig. 13) potrebbe
anche essere uno straniero.
(') Evans, in Brit. School Annual, VI, p. 47; Burrows,
Discover ics in Crete, p, 163.
non la troviamo nè tra le più nobili e dolci figure
femminili del bel fiorire dell'arte egizia, nè tra le
mirabili creazioni dell'arte ellenica.
La convenzione caratteristica della pittura arcaica
di rappresentare il torso di prospetto tra la testa e
le gambe di profilo non è seguita nel nostro sar-
cofago che solo per i tre portatori di tav. I, nei
quali gli oggetti che essi hanno sulle braccia rendono
da un lato necessaria, e dall' altro meno innatu-
rale quella posizione. Infatti se per quelle figure si
fosse il pittore attenuto alla veduta di profilo, avrebbe
urtato nella grave difficoltà di mostrare della barca
solo la prora e dei due vitelli solo il muso e le
zampe anteriori. Le altre figure sono tutte rappre-
sentate di pieno profilo, passando sopra a quel desi-
derio comune a tutte le arti primitive di presentare
nettamente ambedue le spalle e le braccia ('). Questo
accettare o piuttosto preferire la veduta di profilo
mostra nella nostra pittura grande libertà dalle arti
contemporanee egiziane e orientali che generalmente
non ricorrono al profilo, se non quando ve li costringe
una particolare posizione delle figure (2), precisamente
al contrario di quel che avviene nel nostro sarcofago.
Per le tre figure di portatori non possiamo dire,
se il pittore abbia seguito lo schema adottato dal-
l'arte ellenica posteriore col torace di pieno prospetto
che mostra ambedue le mammelle o l'antico schema
egizio, in cui ordinariamente un solo capezzolo è se-
gnato (3). I due vitelli e la barca ricoprono troppo il
petto, perchè possano discernersi questi particolari.
(') Cfr. Loewy, Die Naturwiedergale in der alt. griech
Kunst, p. 55; Della Seta, Genesi dello scorcio nell'arie greca
in Mem. Line, Class, se. mor., ser. V, voi. XII, 1907, p. 174.
(a) Per esempio, nella rappresentazione di prigionieri con
le braccia legate, di mietitori, di legnaiuoli ecc., vedi per
l'Egitto Lepsius, Denkmàler, IV, tav. 107; Rosellini, Mon.
storici, tav. XXVIII; Lefebure, Tombeau de Seti I in Annales
du musée Guimet, IX, parte II, tavv. 5 e 14; parte IV, tav. 3
ecc. Nell'arte caldea e assira il profilo è forse meno raro,
sempre però è preferita la torsione del torace per le figure più
importanti o che compiendo una qualche azione, debbono mo-
strare ambedue le braccia.
(8) Della questione tratta il Della Seta: Genesi dello scorcio
in Mem. Lincei citate, p. 171, con grande dottrina e con ori-
ginalità di vedute. Mi sembrano ciò non ostante troppo recise le
conclusioni che egli trae dalle sue osservazioni. « Questa rappre-
« sentazione caratteristica del tronco nell'arte egizia è elemento
« così sostanziale e inscindibile del suo schematismo disegnativo
u che noi possiamo escludere appunto sulle basi di esso qua-