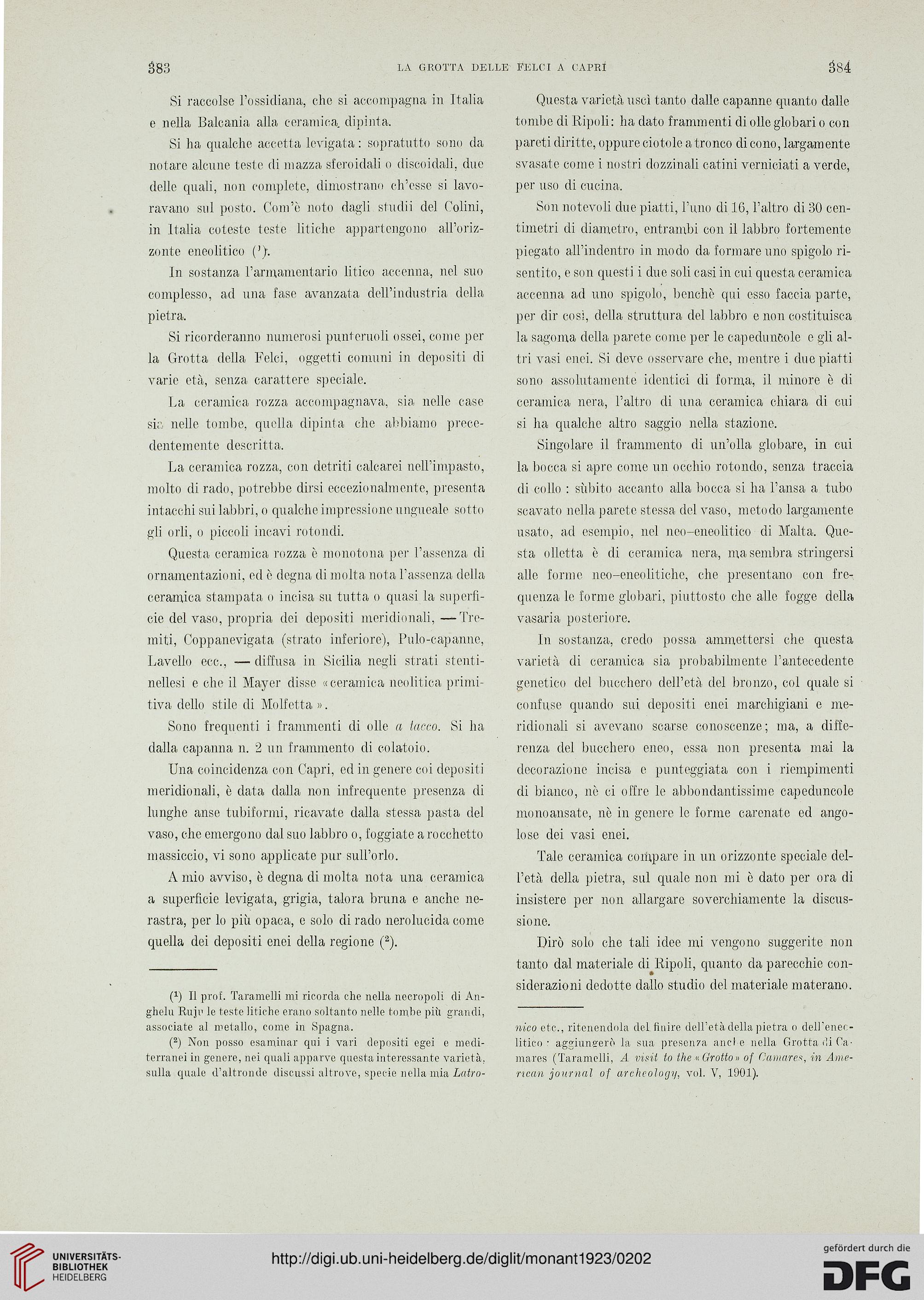383
LA GROTTA DELLE FELCI A CAPRI
384
Si raccolse l'ossidiana, che si accompagna in Italia
e nella Balcania alla ceramica dipinta.
Si ha qualche accetta levigata: sopratutto sono da
notare alcune teste di mazza sferoidali o discoidali, due
delle quali, non complete, dimostrano ch'esse si lavo-
ravano sul posto. Com'è noto dagli stridii del Colini,
in Italia cotesto teste litiche appartengono all'oriz-
zonte eneolitico ('}•
In sostanza l'armamentario litico accenna, nel suo
complesso, ad una fase avanzata dell'industria della
pietra.
Si ricorderanno numerosi punteruoli ossei, come per
la Grotta della Felci, oggetti comuni in depositi di
varie età, senza carattere speciale.
La ceramica rozza accompagnava, sia nelle case
si, nelle tombe, quella dipinta che abbiamo prece-
dentemente descritta.
La ceramica rozza, con detriti calcarei nell'impasto,
molto di rado, potrebbe dirsi eccezionalmente, presenta
intacchi sui labbri, o qualche impressione ungueale sotto
gli orli, o piccoli incavi rotondi.
Questa ceramica rozza è monotona pei' l'assenza di
ornamentazioni, ed e degna di molta nota l'assenza della
ceramica stampata o incisa su tutta o quasi la superfì-
cie del vaso, propria dei depositi meridionali, —Tre-
miti, Coppanevigata (strato inferiore), Pulo-capannc,
Lavello ecc., —diffusa in Sicilia negli strati stenti-
nellesi e che il Mayer disse «ceramica neolitica primi-
tiva dello stile di Molfctta ».
Sono frequenti i frammenti di olle a lacco. Si ha
dalla capanna n. 2 un frammento di colatoio.
Una coincidenza con Capri, ed in genere coi depositi
meridionali, è data dalla non infrequente presenza di
lunghe anse tubiformi, ricavate dalla stessa pasta del
vaso, che emergono dal suo labbro o, foggiate a rocchetto
massiccio, vi sono applicate pur sull'orlo.
A mio avviso, è degna di molta nota una ceramica
a superfìcie levigata, grigia, talora bruna e anche ne-
rastra, per lo più opaca, e solo di rado nerolucida come
quella dei depositi enei della regione (2).
(!) Il prof. Taramelli mi ricorda che nella necropoli di An-
ghelu Rujn le teste litiche erano soltanto nelle tombe più grandi,
associate al metallo, come in Spagna.
(2) Non posso esaminar qui i vari depositi egei e medi-
terranei in genere, nei quali apparve questa interessante varietà,
sulla quale d'altronde discussi altrove, specie nella mia Latro-
Questa varietà uscì tanto dalle capanne quanto dalle
tombe di Ripoli : ha dato frammenti di olle globali o con
pareti diritte, oppure ciotole a tronco di cono, largamente
svasate come i nostri dozzinali catini verniciati a verde,
per uso di cucina.
Son notevoli due piatti, l'uno di 16, l'altro di 30 cen-
timetri di diametro, entrambi con il labbro fortemente
piegato all'indentro in modo da formare uno spigolo ri-
sentito, e son questi i due soli casi in cui questa ceramica
accenna ad uno spigolo, benché qui esso faccia parte,
per dir cosi, della struttura del labbro e non costituisca
la sagoma della parete come per le capeduncole e gli al-
tri vasi enei. Si deve osservare che, mentre i due piatti
sono assolutamente identici di forma, il minore è di
ceramica nera, l'altro di una ceramica chiara di cui
si ha qualche altro saggio nella stazione.
Singolare il frammento di un'olla globare, in cui
la bocca si apre come un occhio rotondo, senza traccia
di collo : sùbito accanto alla bocca si ha l'ansa a tubo
scavato nella parete stessa del vaso, metodo largamente
usato, ad esempio, nel neo-eneolitico di Malta. Que-
sta olletta è di ceramica nera, ma sembra stringersi
alle forme neo-eneolitiche, che presentano con fre-
quenza le forme globari, piuttosto che allo fogge della
vasaria posteriore.
In sostanza, credo possa ammettersi che questa
varietà di ceramica sia probabilmente l'antecedente
genetico del bucchero dell'età del bronzo, col quale si
confuse quando sui depositi enei marchigiani e me-
ridionali si avevano scarse conoscenze; ma, a diffe-
renza del bucchero eneo, essa non presenta mai la
decorazione incisa e punteggiata con i riempimenti
di bianco, nò ci offre le abbondantissime capeduncole
monoansate, ne in genere le forme carenate ed ango-
lose dei vasi enei.
Tale ceramica compare in un orizzonte speciale del-
l'età della pietra, sul quale non mi e dato per ora di
insistere per non allargare soverchiamente la discus-
sione.
Dirò solo che tali idee mi vengono suggerite non
tanto dal materiale di Ripoli, quanto da parecchie con-
siderazioni dedotte dallo studio del materiale materano.
nico etc, ritenendola del fluire dell'età della pietra o dell'enee -
litico' aggiungerò la sua presenza anele nella Grotta di Ca-
mares (Taramelli, A visti io the «.Grotto» of Oamarès, in Ame-
rican journal of archeologi/, voi. V, 1901).
LA GROTTA DELLE FELCI A CAPRI
384
Si raccolse l'ossidiana, che si accompagna in Italia
e nella Balcania alla ceramica dipinta.
Si ha qualche accetta levigata: sopratutto sono da
notare alcune teste di mazza sferoidali o discoidali, due
delle quali, non complete, dimostrano ch'esse si lavo-
ravano sul posto. Com'è noto dagli stridii del Colini,
in Italia cotesto teste litiche appartengono all'oriz-
zonte eneolitico ('}•
In sostanza l'armamentario litico accenna, nel suo
complesso, ad una fase avanzata dell'industria della
pietra.
Si ricorderanno numerosi punteruoli ossei, come per
la Grotta della Felci, oggetti comuni in depositi di
varie età, senza carattere speciale.
La ceramica rozza accompagnava, sia nelle case
si, nelle tombe, quella dipinta che abbiamo prece-
dentemente descritta.
La ceramica rozza, con detriti calcarei nell'impasto,
molto di rado, potrebbe dirsi eccezionalmente, presenta
intacchi sui labbri, o qualche impressione ungueale sotto
gli orli, o piccoli incavi rotondi.
Questa ceramica rozza è monotona pei' l'assenza di
ornamentazioni, ed e degna di molta nota l'assenza della
ceramica stampata o incisa su tutta o quasi la superfì-
cie del vaso, propria dei depositi meridionali, —Tre-
miti, Coppanevigata (strato inferiore), Pulo-capannc,
Lavello ecc., —diffusa in Sicilia negli strati stenti-
nellesi e che il Mayer disse «ceramica neolitica primi-
tiva dello stile di Molfctta ».
Sono frequenti i frammenti di olle a lacco. Si ha
dalla capanna n. 2 un frammento di colatoio.
Una coincidenza con Capri, ed in genere coi depositi
meridionali, è data dalla non infrequente presenza di
lunghe anse tubiformi, ricavate dalla stessa pasta del
vaso, che emergono dal suo labbro o, foggiate a rocchetto
massiccio, vi sono applicate pur sull'orlo.
A mio avviso, è degna di molta nota una ceramica
a superfìcie levigata, grigia, talora bruna e anche ne-
rastra, per lo più opaca, e solo di rado nerolucida come
quella dei depositi enei della regione (2).
(!) Il prof. Taramelli mi ricorda che nella necropoli di An-
ghelu Rujn le teste litiche erano soltanto nelle tombe più grandi,
associate al metallo, come in Spagna.
(2) Non posso esaminar qui i vari depositi egei e medi-
terranei in genere, nei quali apparve questa interessante varietà,
sulla quale d'altronde discussi altrove, specie nella mia Latro-
Questa varietà uscì tanto dalle capanne quanto dalle
tombe di Ripoli : ha dato frammenti di olle globali o con
pareti diritte, oppure ciotole a tronco di cono, largamente
svasate come i nostri dozzinali catini verniciati a verde,
per uso di cucina.
Son notevoli due piatti, l'uno di 16, l'altro di 30 cen-
timetri di diametro, entrambi con il labbro fortemente
piegato all'indentro in modo da formare uno spigolo ri-
sentito, e son questi i due soli casi in cui questa ceramica
accenna ad uno spigolo, benché qui esso faccia parte,
per dir cosi, della struttura del labbro e non costituisca
la sagoma della parete come per le capeduncole e gli al-
tri vasi enei. Si deve osservare che, mentre i due piatti
sono assolutamente identici di forma, il minore è di
ceramica nera, l'altro di una ceramica chiara di cui
si ha qualche altro saggio nella stazione.
Singolare il frammento di un'olla globare, in cui
la bocca si apre come un occhio rotondo, senza traccia
di collo : sùbito accanto alla bocca si ha l'ansa a tubo
scavato nella parete stessa del vaso, metodo largamente
usato, ad esempio, nel neo-eneolitico di Malta. Que-
sta olletta è di ceramica nera, ma sembra stringersi
alle forme neo-eneolitiche, che presentano con fre-
quenza le forme globari, piuttosto che allo fogge della
vasaria posteriore.
In sostanza, credo possa ammettersi che questa
varietà di ceramica sia probabilmente l'antecedente
genetico del bucchero dell'età del bronzo, col quale si
confuse quando sui depositi enei marchigiani e me-
ridionali si avevano scarse conoscenze; ma, a diffe-
renza del bucchero eneo, essa non presenta mai la
decorazione incisa e punteggiata con i riempimenti
di bianco, nò ci offre le abbondantissime capeduncole
monoansate, ne in genere le forme carenate ed ango-
lose dei vasi enei.
Tale ceramica compare in un orizzonte speciale del-
l'età della pietra, sul quale non mi e dato per ora di
insistere per non allargare soverchiamente la discus-
sione.
Dirò solo che tali idee mi vengono suggerite non
tanto dal materiale di Ripoli, quanto da parecchie con-
siderazioni dedotte dallo studio del materiale materano.
nico etc, ritenendola del fluire dell'età della pietra o dell'enee -
litico' aggiungerò la sua presenza anele nella Grotta di Ca-
mares (Taramelli, A visti io the «.Grotto» of Oamarès, in Ame-
rican journal of archeologi/, voi. V, 1901).