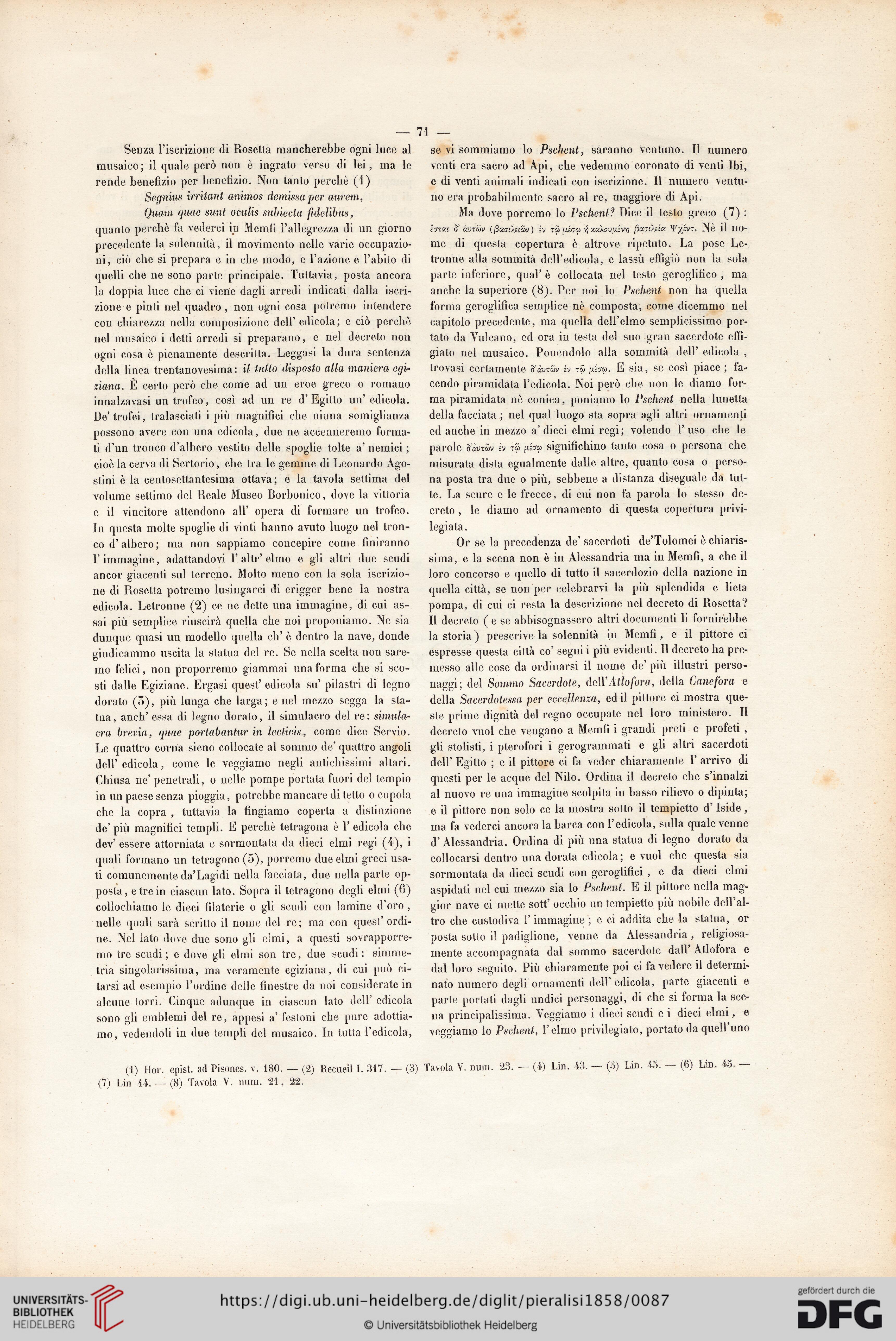Senza l’iscrizione di Rosetta mancherebbe ogni luce al
musaico ; il quale però non è ingrato verso di lei, ma le
rende benefìzio per benefizio. Non tanto perchè (1)
Segnius irritant animos demissaper aurem,
Quam quae sunt oculis subiecta fidelibus,
quanto perchè fa vederci in Memfi ì’allcgrezza di un giorno
precedente la solennità, il movimento nelle varie occupazio-
ni, ciò che si prepara e in che modo, e l’azione e l’abito di
quelli che ne sono parte principale. Tuttavia, posta ancora
la doppia luce che ci viene dagli arredi indicati dalla iscri-
zione e pinti nel quadro , non ogni cosa potremo intendere
con chiarezza nella composizione dell’edicola; e ciò perchè
nel musaico i detti arredi si preparano, e nel decreto non
ogni cosa è pienamente descritta. Leggasi la dura sentenza
della linea trentanovesima : il tutto disposto alla maniera egi-
ziana. È certo però che come ad un eroe greco o romano
innalzavasi un trofeo, così ad un re d’Egitto un’edicola.
De’trofei, tralasciati i più magnifici che niuna somiglianza
possono avere con una edicola, due ne accenneremo forma-
ti d’un tronco d’albero vestito delle spoglie tolte a’ nemici ;
cioè la cerva di Sertorio, che tra le gemme di Leonardo Ago-
stini è la centosettantesima ottava; e la tavola settima del
volume settimo del Reale Museo Rorbonico, dove la vittoria
e il vincitore attendono all’ opera di formare un trofeo.
In questa molte spoglie di vinti hanno avuto luogo nel tron-
co d’albero; ma non sappiamo concepire come finiranno
T immagine, adattandovi T altr’ elmo e gli altri due scudi
ancor giacenti sul terreno. Molto meno con la sola iscrizio-
ne di Rosetta potremo lusingarci di erigger bene la nostra
edicola. Letronne (2) ce ne dette una immagine, di cui as-
sai più semplice riuscirà quella che noi proponiamo. Ne sia
dunque quasi un modello quella eh’ è dentro la nave, donde
giudicammo uscita la statua del re. Se nella scelta non sare-
mo felici, non proporremo giammai una forma che si sco-
sti dalle Egiziane. Ergasi quest’ edicola su’ pilastri di legno
dorato (5), più lunga che larga ; e nel mezzo segga la sta-
tua , aneli’ essa di legno dorato, il simulacro del re : simula-
cro brevia, quae portabantur in lecticis, come dice Servio.
Le quattro corna sieno collocate al sommo de’ quattro angoli
dell’ edicola, come le veggiamo negli antichissimi altari.
Chiusa ne’ penetrali, o nelle pompe portata fuori del tempio
in un paese senza pioggia, potrebbe mancare di tetto o cupola
che la copra , tuttavia la fìngiamo coperta a distinzione
de’ più magnifici templi. E perchè tetragona è 1’ edicola che
dev’ essere attorniata e sormontata da dieci elmi regi (4), i
quali formano un tetragono (5), porremo due elmi greci usa-
ti comunemente da’Lagidi nella facciata, due nella parte op-
posta, e tre in ciascun lato. Sopra il tetragono degli elmi (6)
collochiamo le dieci filatene o gli scudi con lamine d’oro ,
nelle quali sarà scritto il nome del re; ma con quest’ordi-
ne. Nel lato dove due sono gli elmi, a questi sovrapporre-
mo tre scudi ; e dove gli elmi son tre, due scudi : simme-
tria singolarissima, ma veramente egiziana, di cui può ci-
tarsi ad esempio l’ordine delle finestre da noi considerate in
alcune torri. Cinque adunque in ciascun lato dell’ edicola
sono gli emblemi del re, appesi a’ festoni che pure adottia-
mo, vedendoli in due templi del musaico. In tutta l’edicola,
71 —
se vi sommiamo lo Pschent, saranno ventuno. Il numero
venti era sacro ad Api, che vedemmo coronato di venti Ibi,
e di venti animali indicati con iscrizione. Il numero ventu-
no era probabilmente sacro al re, maggiore di Api.
Ma dove porremo lo Pschent? Dice il testo greco (7) :
sitai 3’àurwv (fiaiiteia» ) sv r<a /xéaw -q xalovulvq fiaiiteia T/évr. Nè il no-
me di questa copertura è altrove ripetuto. La pose Le-
tronne alla sommità dell’edicola, e lassù effigiò non la sola
parte inferiore, qual’è collocata nel testo geroglifico, ma
anche la superiore (8). Per noi lo Pschent non ha quella
forma geroglifica semplice nè composta, come dicemmo nel
capitolo precedente, ma quella dell’elmo semplicissimo por-
tato da Vulcano, ed ora in testa del suo gran sacerdote effi-
giato nel musaico. Ponendolo alla sommità dell’ edicola ,
trovasi certamente 5’ Òvtgjv iv pila. E sia, se così piace ; fa-
cendo piramidata l’edicola. Noi però che non le diamo for-
ma piramidata nè conica, poniamo lo Pschent nella lunetta
della facciata ; nel qual luogo sta sopra agli altri ornamenti
ed anche in mezzo a’dieci elmi regi; volendo l’uso che le
parole 3’òvwv w p&a significhino tanto cosa o persona che
misurata dista egualmente dalle altre, quanto cosa o perso-
na posta tra due o più, sebbene a distanza diseguale da tut-
te. La scure e le frecce, di cui non fa parola lo stesso de-
creto , le diamo ad ornamento di questa copertura privi-
legiata.
Or se la precedenza de’ sacerdoti de’Tolomei è chiaris-
sima, e la scena non è in Alessandria ma in Memfi, a che il
loro concorso e quello di tutto il sacerdozio della nazione in
quella città, se non per celebrarvi la più splendida e lieta
pompa, di cui ci resta la descrizione nel decreto di Rosetta?
Il decreto ( e se abbisognassero altri documenti li fornirebbe
la storia ) prescrive la solennità in Memfi , e il pittore ci
espresse questa città co’ segni i più evidenti. Il decreto ha pre-
messo alle cose da ordinarsi il nome de’ più illustri perso-
naggi; del Sommo Sacerdote, dell’Atlofora, della Canefora e
della Sacerdotessa per eccellenza, ed il pittore ci mostra que-
ste prime dignità del regno occupate nel loro ministero. Il
decreto vuol che vengano a Memfi i grandi preti e profeti ,
gli stolisti, i pterofori i gerogrammati e gli altri sacerdoti
dell’ Egitto ; e il pittore ci fa veder chiaramente T arrivo di
questi per le acque del Nilo. Ordina il decreto che s’innalzi
al nuovo re una immagine scolpita in basso rilievo o dipinta;
e il pittore non solo ce la mostra sotto il tempietto d’Iside,
ma fa vederci ancora la barca con l’edicola, sulla quale venne
d’ Alessandria. Ordina di più una statua di legno dorato da
collocarsi dentro una dorata edicola ; e vuol che questa sia
sormontata da dieci scudi con geroglifici , e da dieci elmi
aspidati nel cui mezzo sia lo Pschent. E il pittore nella mag-
gior nave ci mette sott’ occhio un tempietto più nobile dell’al-
tro che custodiva 1’ immagine ; e ci addita che la statua, or
posta sotto il padiglione, venne da Alessandria , religiosa-
mente accompagnata dal sommo sacerdote dall’ Atlofora e
dal loro seguito. Più chiaramente poi ci fa vedere il determi-
nato numero degli ornamenti dell’ edicola, parte giacenti e
parte portati dagli undici personaggi, di che si forma la sce-
na principalissima. Veggiamo i dieci scudi e i dieci elmi, e
veggiamo lo Pschent, l’elmo privilegiato, portato da quell’uno
(1) Hor. episl. ad Pisones. v. 180. — (2) Recueil I. 317. — (3) Tavola V. num. 23. — (4) Lin. 43. — (3) Lin. 45. — (6) Lm. 43. —
(7) Lin 44. — (8) Tavola V. num. 21, 22.
musaico ; il quale però non è ingrato verso di lei, ma le
rende benefìzio per benefizio. Non tanto perchè (1)
Segnius irritant animos demissaper aurem,
Quam quae sunt oculis subiecta fidelibus,
quanto perchè fa vederci in Memfi ì’allcgrezza di un giorno
precedente la solennità, il movimento nelle varie occupazio-
ni, ciò che si prepara e in che modo, e l’azione e l’abito di
quelli che ne sono parte principale. Tuttavia, posta ancora
la doppia luce che ci viene dagli arredi indicati dalla iscri-
zione e pinti nel quadro , non ogni cosa potremo intendere
con chiarezza nella composizione dell’edicola; e ciò perchè
nel musaico i detti arredi si preparano, e nel decreto non
ogni cosa è pienamente descritta. Leggasi la dura sentenza
della linea trentanovesima : il tutto disposto alla maniera egi-
ziana. È certo però che come ad un eroe greco o romano
innalzavasi un trofeo, così ad un re d’Egitto un’edicola.
De’trofei, tralasciati i più magnifici che niuna somiglianza
possono avere con una edicola, due ne accenneremo forma-
ti d’un tronco d’albero vestito delle spoglie tolte a’ nemici ;
cioè la cerva di Sertorio, che tra le gemme di Leonardo Ago-
stini è la centosettantesima ottava; e la tavola settima del
volume settimo del Reale Museo Rorbonico, dove la vittoria
e il vincitore attendono all’ opera di formare un trofeo.
In questa molte spoglie di vinti hanno avuto luogo nel tron-
co d’albero; ma non sappiamo concepire come finiranno
T immagine, adattandovi T altr’ elmo e gli altri due scudi
ancor giacenti sul terreno. Molto meno con la sola iscrizio-
ne di Rosetta potremo lusingarci di erigger bene la nostra
edicola. Letronne (2) ce ne dette una immagine, di cui as-
sai più semplice riuscirà quella che noi proponiamo. Ne sia
dunque quasi un modello quella eh’ è dentro la nave, donde
giudicammo uscita la statua del re. Se nella scelta non sare-
mo felici, non proporremo giammai una forma che si sco-
sti dalle Egiziane. Ergasi quest’ edicola su’ pilastri di legno
dorato (5), più lunga che larga ; e nel mezzo segga la sta-
tua , aneli’ essa di legno dorato, il simulacro del re : simula-
cro brevia, quae portabantur in lecticis, come dice Servio.
Le quattro corna sieno collocate al sommo de’ quattro angoli
dell’ edicola, come le veggiamo negli antichissimi altari.
Chiusa ne’ penetrali, o nelle pompe portata fuori del tempio
in un paese senza pioggia, potrebbe mancare di tetto o cupola
che la copra , tuttavia la fìngiamo coperta a distinzione
de’ più magnifici templi. E perchè tetragona è 1’ edicola che
dev’ essere attorniata e sormontata da dieci elmi regi (4), i
quali formano un tetragono (5), porremo due elmi greci usa-
ti comunemente da’Lagidi nella facciata, due nella parte op-
posta, e tre in ciascun lato. Sopra il tetragono degli elmi (6)
collochiamo le dieci filatene o gli scudi con lamine d’oro ,
nelle quali sarà scritto il nome del re; ma con quest’ordi-
ne. Nel lato dove due sono gli elmi, a questi sovrapporre-
mo tre scudi ; e dove gli elmi son tre, due scudi : simme-
tria singolarissima, ma veramente egiziana, di cui può ci-
tarsi ad esempio l’ordine delle finestre da noi considerate in
alcune torri. Cinque adunque in ciascun lato dell’ edicola
sono gli emblemi del re, appesi a’ festoni che pure adottia-
mo, vedendoli in due templi del musaico. In tutta l’edicola,
71 —
se vi sommiamo lo Pschent, saranno ventuno. Il numero
venti era sacro ad Api, che vedemmo coronato di venti Ibi,
e di venti animali indicati con iscrizione. Il numero ventu-
no era probabilmente sacro al re, maggiore di Api.
Ma dove porremo lo Pschent? Dice il testo greco (7) :
sitai 3’àurwv (fiaiiteia» ) sv r<a /xéaw -q xalovulvq fiaiiteia T/évr. Nè il no-
me di questa copertura è altrove ripetuto. La pose Le-
tronne alla sommità dell’edicola, e lassù effigiò non la sola
parte inferiore, qual’è collocata nel testo geroglifico, ma
anche la superiore (8). Per noi lo Pschent non ha quella
forma geroglifica semplice nè composta, come dicemmo nel
capitolo precedente, ma quella dell’elmo semplicissimo por-
tato da Vulcano, ed ora in testa del suo gran sacerdote effi-
giato nel musaico. Ponendolo alla sommità dell’ edicola ,
trovasi certamente 5’ Òvtgjv iv pila. E sia, se così piace ; fa-
cendo piramidata l’edicola. Noi però che non le diamo for-
ma piramidata nè conica, poniamo lo Pschent nella lunetta
della facciata ; nel qual luogo sta sopra agli altri ornamenti
ed anche in mezzo a’dieci elmi regi; volendo l’uso che le
parole 3’òvwv w p&a significhino tanto cosa o persona che
misurata dista egualmente dalle altre, quanto cosa o perso-
na posta tra due o più, sebbene a distanza diseguale da tut-
te. La scure e le frecce, di cui non fa parola lo stesso de-
creto , le diamo ad ornamento di questa copertura privi-
legiata.
Or se la precedenza de’ sacerdoti de’Tolomei è chiaris-
sima, e la scena non è in Alessandria ma in Memfi, a che il
loro concorso e quello di tutto il sacerdozio della nazione in
quella città, se non per celebrarvi la più splendida e lieta
pompa, di cui ci resta la descrizione nel decreto di Rosetta?
Il decreto ( e se abbisognassero altri documenti li fornirebbe
la storia ) prescrive la solennità in Memfi , e il pittore ci
espresse questa città co’ segni i più evidenti. Il decreto ha pre-
messo alle cose da ordinarsi il nome de’ più illustri perso-
naggi; del Sommo Sacerdote, dell’Atlofora, della Canefora e
della Sacerdotessa per eccellenza, ed il pittore ci mostra que-
ste prime dignità del regno occupate nel loro ministero. Il
decreto vuol che vengano a Memfi i grandi preti e profeti ,
gli stolisti, i pterofori i gerogrammati e gli altri sacerdoti
dell’ Egitto ; e il pittore ci fa veder chiaramente T arrivo di
questi per le acque del Nilo. Ordina il decreto che s’innalzi
al nuovo re una immagine scolpita in basso rilievo o dipinta;
e il pittore non solo ce la mostra sotto il tempietto d’Iside,
ma fa vederci ancora la barca con l’edicola, sulla quale venne
d’ Alessandria. Ordina di più una statua di legno dorato da
collocarsi dentro una dorata edicola ; e vuol che questa sia
sormontata da dieci scudi con geroglifici , e da dieci elmi
aspidati nel cui mezzo sia lo Pschent. E il pittore nella mag-
gior nave ci mette sott’ occhio un tempietto più nobile dell’al-
tro che custodiva 1’ immagine ; e ci addita che la statua, or
posta sotto il padiglione, venne da Alessandria , religiosa-
mente accompagnata dal sommo sacerdote dall’ Atlofora e
dal loro seguito. Più chiaramente poi ci fa vedere il determi-
nato numero degli ornamenti dell’ edicola, parte giacenti e
parte portati dagli undici personaggi, di che si forma la sce-
na principalissima. Veggiamo i dieci scudi e i dieci elmi, e
veggiamo lo Pschent, l’elmo privilegiato, portato da quell’uno
(1) Hor. episl. ad Pisones. v. 180. — (2) Recueil I. 317. — (3) Tavola V. num. 23. — (4) Lin. 43. — (3) Lin. 45. — (6) Lm. 43. —
(7) Lin 44. — (8) Tavola V. num. 21, 22.