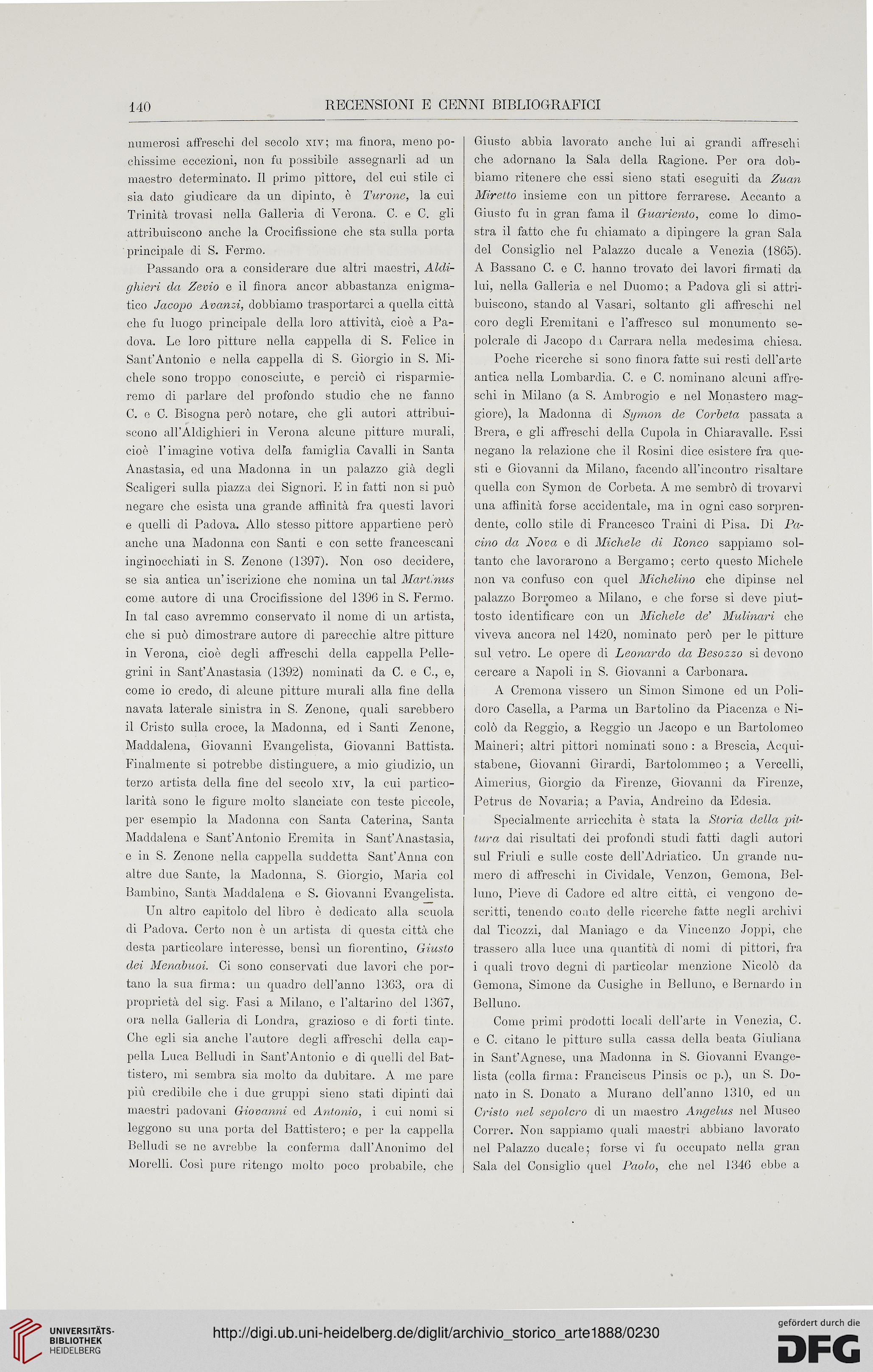140
RECENSIONI E CENNI BIBLIOGRAFICI
numerosi affreschi del secolo xiv; ma finora, meno po-
chissime eccezioni, non fu possibile assegnarli ad un
maestro determinato. Il primo pittore, del cui stile ci
sia dato giudicare da un dipinto, è Turone, la cui
Trinità trovasi nella Galleria di Verona. C. e C. gli
attribuiscono anche la Crocifissione che sta sulla porta
principale di S. Fermo.
Passando ora a considerare due altri maestri, Aldi-
ghieri da Zevio e il finora ancor abbastanza enigma-
tico Jacopo Avanzi, dobbiamo trasportarci a quella città
che fu luogo principale della loro attività, cioè a Pa-
dova. Le loro pitture nella cappella di S. Felice in
Sant'Antonio e nella cappella di S. Giorgio in S. Mi-
chele sono troppo conosciute, e perciò ci risparmie-
remo di parlare del profondo studio che ne fanno
C. e C. Bisogna però notare, che gli autori attribui-
scono all'Aldighieri in Verona alcune pitture murali,
cioè l'imagine votiva della famiglia Cavalli in Santa
Anastasia, ed una Madonna in un palazzo già degli
Scaligeri sulla piazza dei Signori. E in fatti non si può
negare che esista una grande affinità fra questi lavori
e quelli di Padova. Allo stesso pittore appartiene però
anche una Madonna con Santi e con sette francescani
inginocchiati in S. Zenone (1397). Non oso decidere,
se sia antica un'iscrizione che nomina un tal Martlnus
come autore di una Crocifissione del 1396 in S. Fermo.
In tal caso avremmo conservato il nome di un artista,
che si può dimostrare autore di parecchie altre pitture
in Verona, cioè degli affreschi della cappella Pelle-
grini in Sant'Anastasia (1392) nominati da C. e C, e,
come io credo, di alcune pitture murali alla fine della
navata laterale sinistra in S. Zenone, quali sarebbero
il Cristo sulla croce, la Madonna, ed i Santi Zenone,
Maddalena, Giovanni Evangelista, Giovanni Battista.
Finalmente si potrebbe distinguere, a mio giudizio, un
terzo artista della fine del secolo xiv, la cui partico-
larità sono le figure molto slanciate con toste piccole,
per esempio la Madonna con Santa Caterina, Santa
Maddalena e Sant'Antonio Eremita in Sant'Anastasia,
e in S. Zenone nella cappella suddetta Sant'Anna con
altre due Sante, la Madonna, S. Giorgio, Maria col
Bambino, Santa Maddalena e S. Giovanni Evangelista.
Un altro capitolo del libro è dedicato alla scuola
di Padova. Corto non è un artista di questa città che
desta particolare interesse, bensì un fiorentino, Giusto
dei Menabuoi. Ci sono conservati due lavori che por-
tano la sua firma: un quadro dell'anno 1363, ora di
proprietà del sig. Fasi a Milano, e l'altarino del 1367,
ora nella Galleria di Londra, grazioso e di forti tinte.
Che egli sia anche l'autore degli affreschi della cap-
pella Luca Belludi in Sant'Antonio e di quelli del Bat-
tistero, mi sembra sia molto da dubitare. A me pare
più credibile che i due gruppi sieno stati dipinti dai
maestri padovani Giovanni ed Antonio, i cui nomi si
leggono su una porta del Battistero; e per la cappella
Belludi so no avrebbe la conferma dall'Anonimo dol
Morelli. Così pure ritengo molto poco probabile, che
Giusto abbia lavorato anche lui ai grandi affreschi
che adornano la Sala della Ragione. Per ora dob-
biamo ritenere che essi sieno stati eseguiti da Zuan
Miretto insieme con un pittore ferrarese. Accanto a
Giusto fu in gran fama il Guariento, come lo dimo-
stra il fatto che fu chiamato a dipingere la gran Sala
del Consiglio nel Palazzo ducale a Venezia (1865).
A Bassano C. e C. hanno trovato dei lavori firmati da
lui, nella Galleria e nel Duomo; a Padova gli si attri-
buiscono, stando al Vasari, soltanto gli affreschi nel
coro degli Eremitani e l'affresco sul monumento se-
polcrale di Jacopo d i Carrara nella medesima chiesa.
Poche ricerche si sono finora fatte sui resti dell'arte
antica nella Lombardia. C. e C. nominano alcuni affre-
schi in Milano (a S. Ambrogio e nel Monastero mag-
gioro), la Madonna di Symon de Corbeta passata a
Brera, e gli affreschi della Cupola in Chiaravalle. Essi
negano la relazione che il Rosini dico esistere fra que-
sti e Giovanni da Milano, facendo all'incontro risaltare
quella con Symon de Corbeta. A me sembrò di trovarvi
una affinità forse accidentale, ma in ogni caso sorpren-
dente, collo stile di Francesco Traini di Pisa. Di Pa-
cino da Nova e di Michele di Ronco sappiamo sol-
tanto che lavorarono a Bergamo; certo questo Michele
non va confuso con quel Michelino che dipinse nel
palazzo Borromeo a Milano, e che forse si deve piut-
tosto identificare con un Michele de' Mulinavi che
viveva ancora nel 1420, nominato però per le pitture
sul vetro. Le opere di Leonardo da Besozzo si devono
cercare a Napoli in S. Giovanni a Carbonara.
A Cremona vissero un Simon Simone ed un Poli-
doro Casella, a Parma un Bartolino da Piacenza e Ni-
colò da Reggio, a Reggio un Jacopo e un Bartolomeo
Manieri; altri pittori nominati sono : a Brescia, Acqui-
stabile, Giovanni Girardi, Bartolommeo ; a Vercelli,
Aimorius, Giorgio da Firenze, Giovanni da Firenze,
Petrus do Novaria; a Pavia, Andrcino da Edesia.
Specialmente arricchita è stata la Storia della pit-
tura dai risultati dei profondi studi fatti dagli autori
sul Friuli e sulle coste dell'Adriatico. Un grande nu-
mero di affreschi in Cividale, Venzon, Gemona, Bel-
luno, Pieve di Cadore ed altro città, ci vengono de-
scritti, tenendo conto delle ricerche fatte negli archivi
dal Ticozzi, dal Maniago e da Vincenzo Joppi, che
trassero alla luce una quantità di nomi di pittori, fra
i quali trovo degni di particolar menzione Nicolò da
Gemona, Simone da Cusighe in Belluno, e Bernardo in
Belluno.
Come primi prodotti locali dell'arte in Venezia, C.
o C. citano le pitture sulla cassa della beata Giuliana
in Sant'Agnese, una Madonna in S. Giovanni Evange-
lista (colla firma: Franciscus Pinsis oc p.), un S. Do-
nato in S. Donato a Murano dell'anno 1310, ed un
Cristo nel sepolcro di un maestro Angelus nel Museo
Correr. Non sappiamo quali maestri abbiano lavorato
nel Palazzo ducale; forse vi fu occupato nella gran
Sala del Consiglio quel Paolo, che nel 1346 ebbe a
RECENSIONI E CENNI BIBLIOGRAFICI
numerosi affreschi del secolo xiv; ma finora, meno po-
chissime eccezioni, non fu possibile assegnarli ad un
maestro determinato. Il primo pittore, del cui stile ci
sia dato giudicare da un dipinto, è Turone, la cui
Trinità trovasi nella Galleria di Verona. C. e C. gli
attribuiscono anche la Crocifissione che sta sulla porta
principale di S. Fermo.
Passando ora a considerare due altri maestri, Aldi-
ghieri da Zevio e il finora ancor abbastanza enigma-
tico Jacopo Avanzi, dobbiamo trasportarci a quella città
che fu luogo principale della loro attività, cioè a Pa-
dova. Le loro pitture nella cappella di S. Felice in
Sant'Antonio e nella cappella di S. Giorgio in S. Mi-
chele sono troppo conosciute, e perciò ci risparmie-
remo di parlare del profondo studio che ne fanno
C. e C. Bisogna però notare, che gli autori attribui-
scono all'Aldighieri in Verona alcune pitture murali,
cioè l'imagine votiva della famiglia Cavalli in Santa
Anastasia, ed una Madonna in un palazzo già degli
Scaligeri sulla piazza dei Signori. E in fatti non si può
negare che esista una grande affinità fra questi lavori
e quelli di Padova. Allo stesso pittore appartiene però
anche una Madonna con Santi e con sette francescani
inginocchiati in S. Zenone (1397). Non oso decidere,
se sia antica un'iscrizione che nomina un tal Martlnus
come autore di una Crocifissione del 1396 in S. Fermo.
In tal caso avremmo conservato il nome di un artista,
che si può dimostrare autore di parecchie altre pitture
in Verona, cioè degli affreschi della cappella Pelle-
grini in Sant'Anastasia (1392) nominati da C. e C, e,
come io credo, di alcune pitture murali alla fine della
navata laterale sinistra in S. Zenone, quali sarebbero
il Cristo sulla croce, la Madonna, ed i Santi Zenone,
Maddalena, Giovanni Evangelista, Giovanni Battista.
Finalmente si potrebbe distinguere, a mio giudizio, un
terzo artista della fine del secolo xiv, la cui partico-
larità sono le figure molto slanciate con toste piccole,
per esempio la Madonna con Santa Caterina, Santa
Maddalena e Sant'Antonio Eremita in Sant'Anastasia,
e in S. Zenone nella cappella suddetta Sant'Anna con
altre due Sante, la Madonna, S. Giorgio, Maria col
Bambino, Santa Maddalena e S. Giovanni Evangelista.
Un altro capitolo del libro è dedicato alla scuola
di Padova. Corto non è un artista di questa città che
desta particolare interesse, bensì un fiorentino, Giusto
dei Menabuoi. Ci sono conservati due lavori che por-
tano la sua firma: un quadro dell'anno 1363, ora di
proprietà del sig. Fasi a Milano, e l'altarino del 1367,
ora nella Galleria di Londra, grazioso e di forti tinte.
Che egli sia anche l'autore degli affreschi della cap-
pella Luca Belludi in Sant'Antonio e di quelli del Bat-
tistero, mi sembra sia molto da dubitare. A me pare
più credibile che i due gruppi sieno stati dipinti dai
maestri padovani Giovanni ed Antonio, i cui nomi si
leggono su una porta del Battistero; e per la cappella
Belludi so no avrebbe la conferma dall'Anonimo dol
Morelli. Così pure ritengo molto poco probabile, che
Giusto abbia lavorato anche lui ai grandi affreschi
che adornano la Sala della Ragione. Per ora dob-
biamo ritenere che essi sieno stati eseguiti da Zuan
Miretto insieme con un pittore ferrarese. Accanto a
Giusto fu in gran fama il Guariento, come lo dimo-
stra il fatto che fu chiamato a dipingere la gran Sala
del Consiglio nel Palazzo ducale a Venezia (1865).
A Bassano C. e C. hanno trovato dei lavori firmati da
lui, nella Galleria e nel Duomo; a Padova gli si attri-
buiscono, stando al Vasari, soltanto gli affreschi nel
coro degli Eremitani e l'affresco sul monumento se-
polcrale di Jacopo d i Carrara nella medesima chiesa.
Poche ricerche si sono finora fatte sui resti dell'arte
antica nella Lombardia. C. e C. nominano alcuni affre-
schi in Milano (a S. Ambrogio e nel Monastero mag-
gioro), la Madonna di Symon de Corbeta passata a
Brera, e gli affreschi della Cupola in Chiaravalle. Essi
negano la relazione che il Rosini dico esistere fra que-
sti e Giovanni da Milano, facendo all'incontro risaltare
quella con Symon de Corbeta. A me sembrò di trovarvi
una affinità forse accidentale, ma in ogni caso sorpren-
dente, collo stile di Francesco Traini di Pisa. Di Pa-
cino da Nova e di Michele di Ronco sappiamo sol-
tanto che lavorarono a Bergamo; certo questo Michele
non va confuso con quel Michelino che dipinse nel
palazzo Borromeo a Milano, e che forse si deve piut-
tosto identificare con un Michele de' Mulinavi che
viveva ancora nel 1420, nominato però per le pitture
sul vetro. Le opere di Leonardo da Besozzo si devono
cercare a Napoli in S. Giovanni a Carbonara.
A Cremona vissero un Simon Simone ed un Poli-
doro Casella, a Parma un Bartolino da Piacenza e Ni-
colò da Reggio, a Reggio un Jacopo e un Bartolomeo
Manieri; altri pittori nominati sono : a Brescia, Acqui-
stabile, Giovanni Girardi, Bartolommeo ; a Vercelli,
Aimorius, Giorgio da Firenze, Giovanni da Firenze,
Petrus do Novaria; a Pavia, Andrcino da Edesia.
Specialmente arricchita è stata la Storia della pit-
tura dai risultati dei profondi studi fatti dagli autori
sul Friuli e sulle coste dell'Adriatico. Un grande nu-
mero di affreschi in Cividale, Venzon, Gemona, Bel-
luno, Pieve di Cadore ed altro città, ci vengono de-
scritti, tenendo conto delle ricerche fatte negli archivi
dal Ticozzi, dal Maniago e da Vincenzo Joppi, che
trassero alla luce una quantità di nomi di pittori, fra
i quali trovo degni di particolar menzione Nicolò da
Gemona, Simone da Cusighe in Belluno, e Bernardo in
Belluno.
Come primi prodotti locali dell'arte in Venezia, C.
o C. citano le pitture sulla cassa della beata Giuliana
in Sant'Agnese, una Madonna in S. Giovanni Evange-
lista (colla firma: Franciscus Pinsis oc p.), un S. Do-
nato in S. Donato a Murano dell'anno 1310, ed un
Cristo nel sepolcro di un maestro Angelus nel Museo
Correr. Non sappiamo quali maestri abbiano lavorato
nel Palazzo ducale; forse vi fu occupato nella gran
Sala del Consiglio quel Paolo, che nel 1346 ebbe a