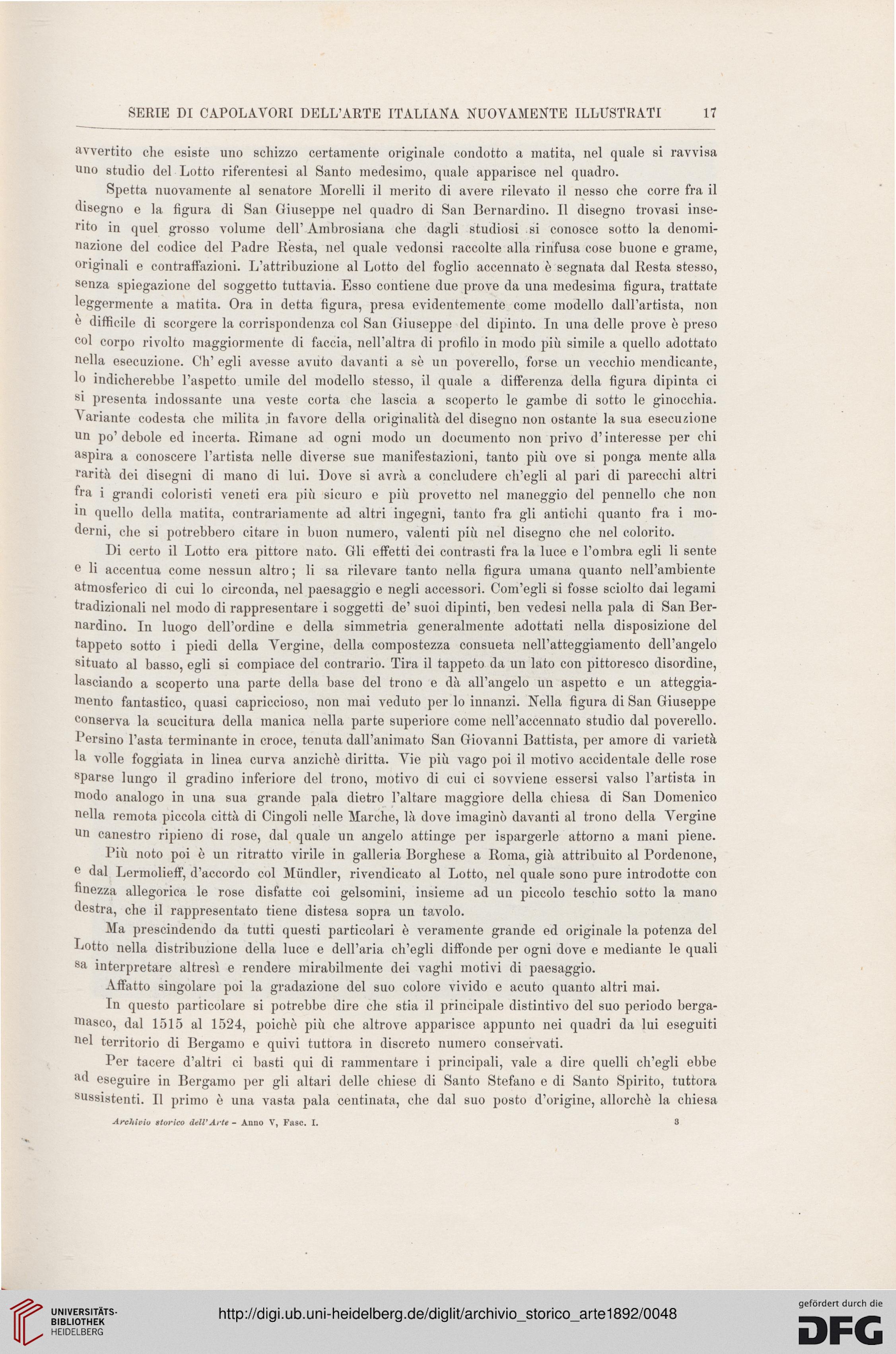SERIE DI CAPOLAVORI DELL'ARTE ITALIANA NUOVAMENTE ILLUSTRATI
IT
avvertito che esiste uno schizzo certamente originale condotto a matita, nel quale si ravvisa
uno studio del Lotto riferentesi al Santo medesimo, quale apparisce nel quadro.
Spetta nuovamente al senatore Morelli il merito di avere rilevato il nesso che corre fra il
disegno e la figura di San Giuseppe nel quadro di San Bernardino. Il disegno trovasi inse-
rito in quel grosso volume dell' Ambrosiana che dagli studiosi si conosce sotto la denomi-
nazione del codice del Padre Resta, nel quale vedonsi raccolte alla rinfusa cose buone e grame,
originali e contraffazioni. L'attribuzione al Lotto del foglio accennato è segnata dal Resta stesso,
senza spiegazione del soggetto tuttavia. Esso contiene due prove da una medesima figura, trattate
leggermente a matita. Ora in detta figura, presa evidentemente come modello dall'artista, non
e difficile di scorgere la corrispondenza col San Giuseppe del dipinto. In una delle prove ò preso
col corpo rivolto maggiormente di faccia, nell'altra di profilo in modo più simile a quello adottato
nella esecuzione. Ch' egli avesse avuto davanti a sò un poverello, forse un vecchio mendicante,
lo indicherebbe l'aspetto umile del modello stesso, il quale a differenza della figura dipinta ci
si presenta indossante una veste corta che lascia a scoperto le gambe di sotto le ginocchia.
Variante codesta che milita .in favore della originalità del disegno non ostante la sua esecuzione
un po' debole ed incerta. Rimane ad ogni modo un documento non privo d'interesse per chi
aspira a conoscere l'artista nelle diverse sue manifestazioni, tanto più ove si ponga mente alla
rarità dei disegni di mano di lui. Dove si avrà a concludere ch'egli al pari di parecchi altri
fra i grandi coloristi veneti era più sicuro e più provetto nel maneggio del pennello che non
in quello della matita, contrariamente ad altri ingegni, tanto fra gli antichi quanto fra i mo-
derni, che si potrebbero citare in buon numero, valenti più nel disegno che nel colorito.
Di certo il Lotto era pittore nato. Gli effetti dei contrasti fra la luce e l'ombra egli li sente
e li accentua come nessun altro ; li sa rilevare tanto nella figura umana quanto nell'ambiente
atmosferico di cui lo circonda, nel paesaggio e negli accessori. Com'egli si fosse sciolto dai legami
tradizionali nel modo di rappresentare i soggetti de' suoi dipinti, ben vedesi nella pala di San Ber-
nardino. In luogo dell'ordine e della simmetria generalmente adottati nella disposizione del
tappeto sotto i piedi della Vergine, della compostezza consueta nell'atteggiamento dell'angelo
situato al basso, egli si compiace del contrario. Tira il tappeto da un lato con pittoresco disordine,
lasciando a scoperto una parte della base del trono e dà all'angelo un aspetto e un atteggia-
mento fantastico, quasi capriccioso, non mai veduto per lo innanzi. Nella figura di San Giuseppe
conserva la scucitura della manica nella parte superiore come nell'accennato studio dal poverello.
Persino l'asta terminante in croce, tenuta dall'animato San Giovanni Battista, per amore di varietà
la volle foggiata in linea curva anziché diritta. Vie più vago poi il motivo accidentale delle rose
sparse lungo il gradino inferiore del trono, motivo di cui ci sovviene essersi valso l'artista in
modo analogo in una sua grande pala dietro l'altare maggiore della chiesa di San Domenico
nella remota piccola città di Cingoli nelle Marche, là dove imaginò davanti al trono della Vergine
un canestro ripieno di rose, dal quale un angelo attinge per ispargerle attorno a mani piene.
Più noto poi è un ritratto virile in galleria Borghese a Roma, già attribuito al Pordenone,
e dal Lermolieff, d'accordo col Mùndler, rivendicato al Lotto, nel quale sono pure introdotte con
finezza allegorica le rose disfatte coi gelsomini, insieme ad un piccolo teschio sotto la mano
destra, che il rappresentato tiene distesa sopra un tavolo.
Ma prescindendo da tutti questi particolari è veramente grande ed originale la potenza del
Lotto nella distribuzione della luce e dell'aria ch'egli diffonde per ogni dove e mediante le quali
sa interpretare altresì e rendere mirabilmente dei vaghi motivi di paesaggio.
Affatto singolare poi la gradazione del suo colore vivido e acuto quanto altri mai.
In questo particolare si potrebbe dire che stia il principale distintivo del suo periodo berga-
masco, dal 1515 al 1524, poiché più che altrove apparisce appunto nei quadri da lui eseguiti
nel territorio di Bergamo e quivi tuttora in discreto numero conservati.
Per tacere d'altri ci basti qui di rammentare i principali, vale a dire quelli ch'egli ebbe
ad eseguire in Bergamo per gli altari delle chiese di Santo Stefano e di Santo Spirito, tuttora
sussistenti. 11 primo è una vasta pala centinata, che dal suo posto d'origine, allorché la chiesa
Archivio storico dell' Arte - Anno V, Fase. I. 3
IT
avvertito che esiste uno schizzo certamente originale condotto a matita, nel quale si ravvisa
uno studio del Lotto riferentesi al Santo medesimo, quale apparisce nel quadro.
Spetta nuovamente al senatore Morelli il merito di avere rilevato il nesso che corre fra il
disegno e la figura di San Giuseppe nel quadro di San Bernardino. Il disegno trovasi inse-
rito in quel grosso volume dell' Ambrosiana che dagli studiosi si conosce sotto la denomi-
nazione del codice del Padre Resta, nel quale vedonsi raccolte alla rinfusa cose buone e grame,
originali e contraffazioni. L'attribuzione al Lotto del foglio accennato è segnata dal Resta stesso,
senza spiegazione del soggetto tuttavia. Esso contiene due prove da una medesima figura, trattate
leggermente a matita. Ora in detta figura, presa evidentemente come modello dall'artista, non
e difficile di scorgere la corrispondenza col San Giuseppe del dipinto. In una delle prove ò preso
col corpo rivolto maggiormente di faccia, nell'altra di profilo in modo più simile a quello adottato
nella esecuzione. Ch' egli avesse avuto davanti a sò un poverello, forse un vecchio mendicante,
lo indicherebbe l'aspetto umile del modello stesso, il quale a differenza della figura dipinta ci
si presenta indossante una veste corta che lascia a scoperto le gambe di sotto le ginocchia.
Variante codesta che milita .in favore della originalità del disegno non ostante la sua esecuzione
un po' debole ed incerta. Rimane ad ogni modo un documento non privo d'interesse per chi
aspira a conoscere l'artista nelle diverse sue manifestazioni, tanto più ove si ponga mente alla
rarità dei disegni di mano di lui. Dove si avrà a concludere ch'egli al pari di parecchi altri
fra i grandi coloristi veneti era più sicuro e più provetto nel maneggio del pennello che non
in quello della matita, contrariamente ad altri ingegni, tanto fra gli antichi quanto fra i mo-
derni, che si potrebbero citare in buon numero, valenti più nel disegno che nel colorito.
Di certo il Lotto era pittore nato. Gli effetti dei contrasti fra la luce e l'ombra egli li sente
e li accentua come nessun altro ; li sa rilevare tanto nella figura umana quanto nell'ambiente
atmosferico di cui lo circonda, nel paesaggio e negli accessori. Com'egli si fosse sciolto dai legami
tradizionali nel modo di rappresentare i soggetti de' suoi dipinti, ben vedesi nella pala di San Ber-
nardino. In luogo dell'ordine e della simmetria generalmente adottati nella disposizione del
tappeto sotto i piedi della Vergine, della compostezza consueta nell'atteggiamento dell'angelo
situato al basso, egli si compiace del contrario. Tira il tappeto da un lato con pittoresco disordine,
lasciando a scoperto una parte della base del trono e dà all'angelo un aspetto e un atteggia-
mento fantastico, quasi capriccioso, non mai veduto per lo innanzi. Nella figura di San Giuseppe
conserva la scucitura della manica nella parte superiore come nell'accennato studio dal poverello.
Persino l'asta terminante in croce, tenuta dall'animato San Giovanni Battista, per amore di varietà
la volle foggiata in linea curva anziché diritta. Vie più vago poi il motivo accidentale delle rose
sparse lungo il gradino inferiore del trono, motivo di cui ci sovviene essersi valso l'artista in
modo analogo in una sua grande pala dietro l'altare maggiore della chiesa di San Domenico
nella remota piccola città di Cingoli nelle Marche, là dove imaginò davanti al trono della Vergine
un canestro ripieno di rose, dal quale un angelo attinge per ispargerle attorno a mani piene.
Più noto poi è un ritratto virile in galleria Borghese a Roma, già attribuito al Pordenone,
e dal Lermolieff, d'accordo col Mùndler, rivendicato al Lotto, nel quale sono pure introdotte con
finezza allegorica le rose disfatte coi gelsomini, insieme ad un piccolo teschio sotto la mano
destra, che il rappresentato tiene distesa sopra un tavolo.
Ma prescindendo da tutti questi particolari è veramente grande ed originale la potenza del
Lotto nella distribuzione della luce e dell'aria ch'egli diffonde per ogni dove e mediante le quali
sa interpretare altresì e rendere mirabilmente dei vaghi motivi di paesaggio.
Affatto singolare poi la gradazione del suo colore vivido e acuto quanto altri mai.
In questo particolare si potrebbe dire che stia il principale distintivo del suo periodo berga-
masco, dal 1515 al 1524, poiché più che altrove apparisce appunto nei quadri da lui eseguiti
nel territorio di Bergamo e quivi tuttora in discreto numero conservati.
Per tacere d'altri ci basti qui di rammentare i principali, vale a dire quelli ch'egli ebbe
ad eseguire in Bergamo per gli altari delle chiese di Santo Stefano e di Santo Spirito, tuttora
sussistenti. 11 primo è una vasta pala centinata, che dal suo posto d'origine, allorché la chiesa
Archivio storico dell' Arte - Anno V, Fase. I. 3