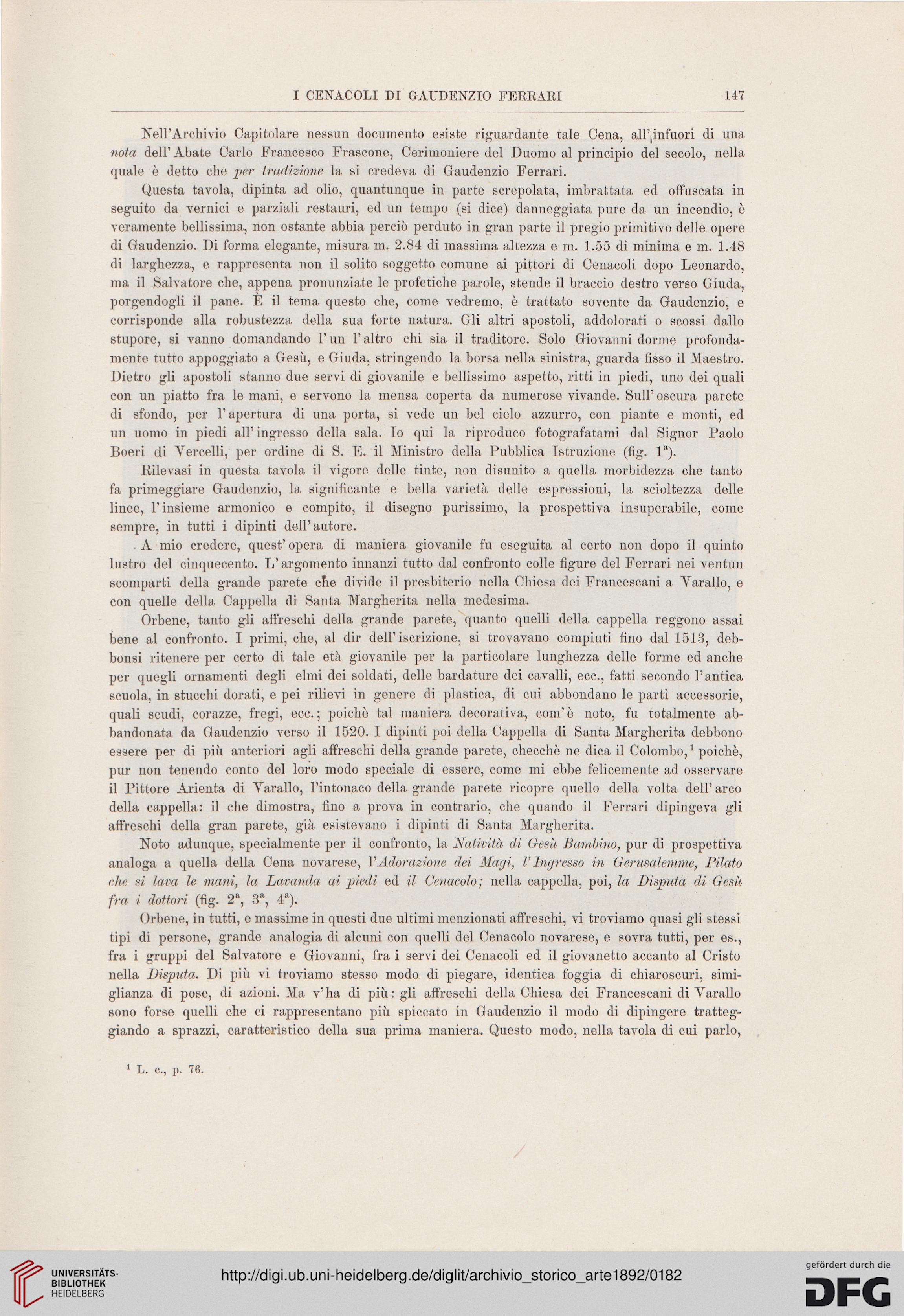I CENACOLI Df GAUDENZIO FERRARI
147
Nell'Archivio Capitolare nessun documento esiste riguardante tale Cena, alPinfuori di una
unta dell'Abate Carlo Francesco Frascone, Cerimoniere del Duomo al principio del secolo, nella
quale è detto che per tradizione la si credeva di Gaudenzio Ferrari.
Questa tavola, dipinta ad olio, quantunque in parte screpolata, imbrattata ed offuscata in
seguito da vernici e parziali restauri, ed un tempo (si dice) danneggiata pure da un incendio, è
veramente bellissima, non ostante abbia perciò perduto in gran parte il pregio primitivo delle opere
di Gaudenzio. Di forma elegante, misura m. 2.84 di massima altezza e m. 1.55 di minima e m. 1.48
di larghezza, e rappresenta non il solito soggetto comune ai pittori di Cenacoli dopo Leonardo,
ma il Salvatore che, appena pronunziate le profetiche parole, stende il braccio destro verso Giuda,
porgendogli il pane. E il tema questo che, come vedremo, è trattato sovente da Gaudenzio, e
corrisponde alla robustezza della sua forte natura. Gli altri apostoli, addolorati o scossi dallo
stupore, si vanno domandando l'un l'altro chi sia il traditore. Solo Giovanni dorme profonda-
mente tutto appoggiato a Gesù, e Giuda, stringendo la borsa nella sinistra, guarda fisso il Maestro.
Dietro gli apostoli stanno due servi di giovanile e bellissimo aspetto, ritti in piedi, uno dei quali
con un piatto fra le mani, e servono la mensa coperta da numerose vivande. Sull' oscura parete
di sfondo, per l'apertura di una porta, si vede un bel cielo azzurro, con piante e monti, ed
un uomo in piedi all'ingresso della sala. Io qui la riproduco fotografatami dal Signor Paolo
Boeri di Vercelli, per ordine di S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione (fig. 1").
Rilevasi in questa tavola il vigore delle tinte, non disunito a quella morbidezza che tanto
fa primeggiare Gaudenzio, la significante e bella varietà desile espressioni, la scioltezza delle
linee, l'insieme armonico e compito, il disegno purissimo, la prospettiva insuperabile, come
sempre, in tutti i dipinti dell'autore.
. A mio credere, quest' opera di maniera giovanile fu eseguita al certo non dopo il quinto
lustro del cinquecento. L'argomento innanzi tutto dal confronto colle figure del Ferrari nei ventun
scomparti della grande parete cfie divide il presbiterio nella Chiesa dei Francescani a Varallo, e
con quelle della Cappella di Santa Margherita nella medesima.
Orbene, tanto gli affreschi della grande parete, quanto quelli della cappella reggono assai
bene al confronto. I primi, che, al dir dell'iscrizione, si trovavano compiuti fino dal 1513, deb-
bonsi ritenere per certo di tale età giovanile per la particolare lunghezza delle forme ed anche
per quegli ornamenti degli elmi dei soldati, delle bardature dei cavalli, ecc., fatti secondo l'antica
scuola, in stucchi dorati, e pei rilievi in genere di plastica, di cui abbondano le parti accessorie,
quali scudi, corazze, fregi, ecc. ; poiché tal maniera decorativa, com' è noto, fu totalmente ab-
bandonata da Gaudenzio verso il 1520. I dipinti poi della Cappella di Santa Margherita debbono
essere per di più anteriori agli affreschi della grande parete, checché ne dica il Colombo,1 poiché,
pur non tenendo conto del loro modo speciale di essere, come mi ebbe felicemente ad osservare
il Pittore Arienta di Varallo, l'intonaco della grande parete ricopre quello della volta dell' arco
della cappella: il che dimostra, fino a prova in contrario, che quando il Ferrari dipingeva gli
affreschi della gran parete, già esistevano i dipinti di Santa Margherita.
Noto adunque, specialmente per il confronto, la Natività di Gesù Bambino, pur di prospettiva
analoga a quella della Cena novarese, l'Adorazione dei Magi, l'Ingresso in Gerusalemme, Pilato
che si Inni le, mani, la Lavanda ai piedi ed il Cenacoli); nella cappella, poi, la Disputa di Gesù
fra i dottori (fig. 2a, 3a, 4tt).
Orbene, in tutti, e massime in questi due ultimi menzionati affreschi, vi troviamo quasi gli stessi
tipi di persone, grande analogia di alcuni con quelli del Cenacolo novarese, e sovra tutti, per es.,
fra i gruppi del Salvatore e Giovanni, fra i servi dei Cenacoli ed il giovanetto accanto al Cristo
nella Disputa. Di più vi troviamo stesso modo di piegare, identica foggia di chiaroscuri, simi-
glianza di pose, di azioni. Ma v'ha di più: gli affreschi della Chiesa dei Francescani di Varallo
sono forse quelli che ci rappresentano più spiccato in Gaudenzio il modo di dipingere tratteg-
giando a sprazzi, caratteristico della sua prima maniera. Questo modo, nella tavola di cui parlo,
1 L. e, p. 76.
147
Nell'Archivio Capitolare nessun documento esiste riguardante tale Cena, alPinfuori di una
unta dell'Abate Carlo Francesco Frascone, Cerimoniere del Duomo al principio del secolo, nella
quale è detto che per tradizione la si credeva di Gaudenzio Ferrari.
Questa tavola, dipinta ad olio, quantunque in parte screpolata, imbrattata ed offuscata in
seguito da vernici e parziali restauri, ed un tempo (si dice) danneggiata pure da un incendio, è
veramente bellissima, non ostante abbia perciò perduto in gran parte il pregio primitivo delle opere
di Gaudenzio. Di forma elegante, misura m. 2.84 di massima altezza e m. 1.55 di minima e m. 1.48
di larghezza, e rappresenta non il solito soggetto comune ai pittori di Cenacoli dopo Leonardo,
ma il Salvatore che, appena pronunziate le profetiche parole, stende il braccio destro verso Giuda,
porgendogli il pane. E il tema questo che, come vedremo, è trattato sovente da Gaudenzio, e
corrisponde alla robustezza della sua forte natura. Gli altri apostoli, addolorati o scossi dallo
stupore, si vanno domandando l'un l'altro chi sia il traditore. Solo Giovanni dorme profonda-
mente tutto appoggiato a Gesù, e Giuda, stringendo la borsa nella sinistra, guarda fisso il Maestro.
Dietro gli apostoli stanno due servi di giovanile e bellissimo aspetto, ritti in piedi, uno dei quali
con un piatto fra le mani, e servono la mensa coperta da numerose vivande. Sull' oscura parete
di sfondo, per l'apertura di una porta, si vede un bel cielo azzurro, con piante e monti, ed
un uomo in piedi all'ingresso della sala. Io qui la riproduco fotografatami dal Signor Paolo
Boeri di Vercelli, per ordine di S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione (fig. 1").
Rilevasi in questa tavola il vigore delle tinte, non disunito a quella morbidezza che tanto
fa primeggiare Gaudenzio, la significante e bella varietà desile espressioni, la scioltezza delle
linee, l'insieme armonico e compito, il disegno purissimo, la prospettiva insuperabile, come
sempre, in tutti i dipinti dell'autore.
. A mio credere, quest' opera di maniera giovanile fu eseguita al certo non dopo il quinto
lustro del cinquecento. L'argomento innanzi tutto dal confronto colle figure del Ferrari nei ventun
scomparti della grande parete cfie divide il presbiterio nella Chiesa dei Francescani a Varallo, e
con quelle della Cappella di Santa Margherita nella medesima.
Orbene, tanto gli affreschi della grande parete, quanto quelli della cappella reggono assai
bene al confronto. I primi, che, al dir dell'iscrizione, si trovavano compiuti fino dal 1513, deb-
bonsi ritenere per certo di tale età giovanile per la particolare lunghezza delle forme ed anche
per quegli ornamenti degli elmi dei soldati, delle bardature dei cavalli, ecc., fatti secondo l'antica
scuola, in stucchi dorati, e pei rilievi in genere di plastica, di cui abbondano le parti accessorie,
quali scudi, corazze, fregi, ecc. ; poiché tal maniera decorativa, com' è noto, fu totalmente ab-
bandonata da Gaudenzio verso il 1520. I dipinti poi della Cappella di Santa Margherita debbono
essere per di più anteriori agli affreschi della grande parete, checché ne dica il Colombo,1 poiché,
pur non tenendo conto del loro modo speciale di essere, come mi ebbe felicemente ad osservare
il Pittore Arienta di Varallo, l'intonaco della grande parete ricopre quello della volta dell' arco
della cappella: il che dimostra, fino a prova in contrario, che quando il Ferrari dipingeva gli
affreschi della gran parete, già esistevano i dipinti di Santa Margherita.
Noto adunque, specialmente per il confronto, la Natività di Gesù Bambino, pur di prospettiva
analoga a quella della Cena novarese, l'Adorazione dei Magi, l'Ingresso in Gerusalemme, Pilato
che si Inni le, mani, la Lavanda ai piedi ed il Cenacoli); nella cappella, poi, la Disputa di Gesù
fra i dottori (fig. 2a, 3a, 4tt).
Orbene, in tutti, e massime in questi due ultimi menzionati affreschi, vi troviamo quasi gli stessi
tipi di persone, grande analogia di alcuni con quelli del Cenacolo novarese, e sovra tutti, per es.,
fra i gruppi del Salvatore e Giovanni, fra i servi dei Cenacoli ed il giovanetto accanto al Cristo
nella Disputa. Di più vi troviamo stesso modo di piegare, identica foggia di chiaroscuri, simi-
glianza di pose, di azioni. Ma v'ha di più: gli affreschi della Chiesa dei Francescani di Varallo
sono forse quelli che ci rappresentano più spiccato in Gaudenzio il modo di dipingere tratteg-
giando a sprazzi, caratteristico della sua prima maniera. Questo modo, nella tavola di cui parlo,
1 L. e, p. 76.