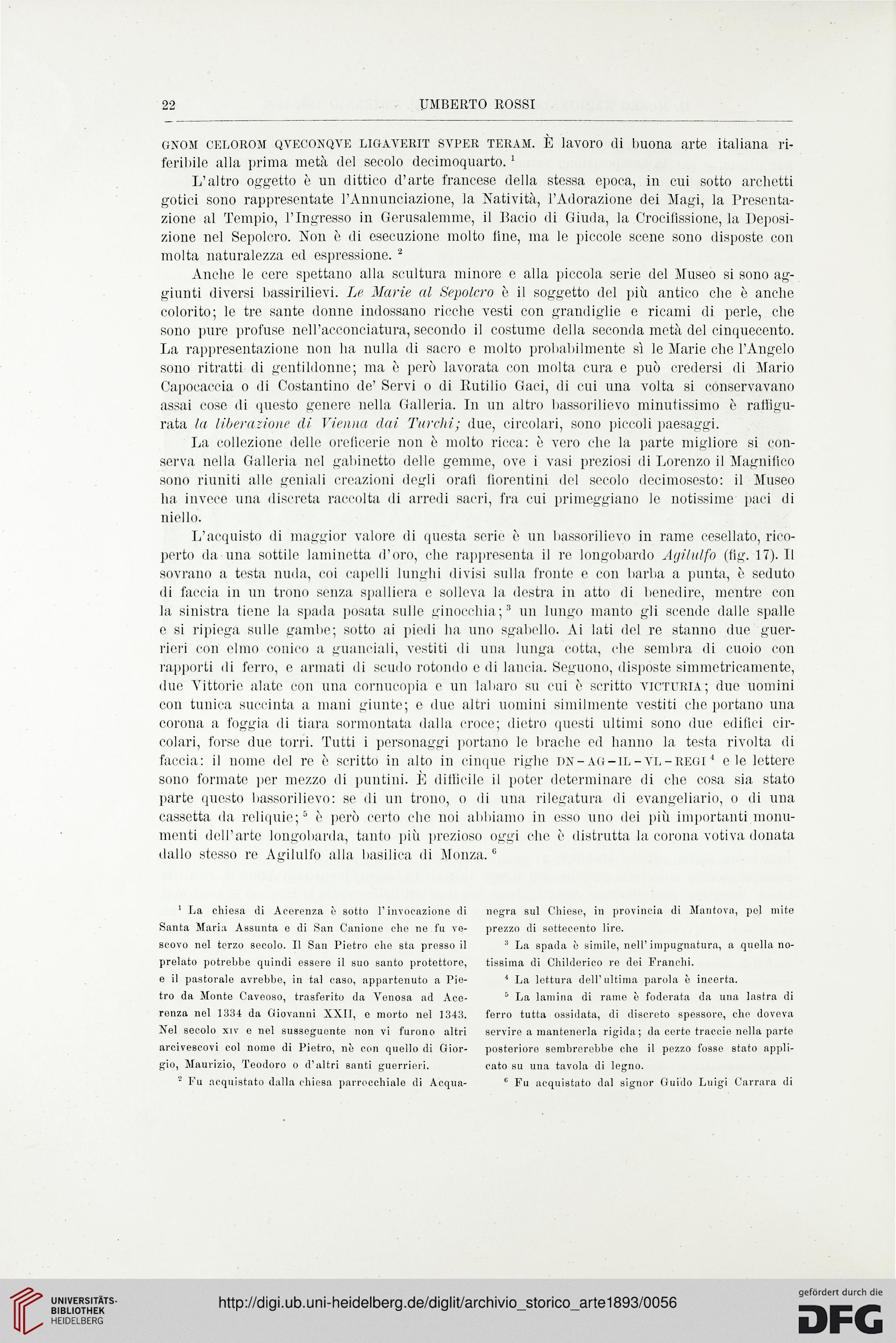22
UMBERTO ROSSI
gnom celorom qveconqve ligaverit svper teram. E lavoro di buona arte italiana ri-
feribile alla prima metà del secolo decimoquarto.1
L'altro oggetto è un dittico d'arte francese della stessa epoca, in cui sotto archetti
gotici sono rappresentate l'Annunciazione, la Natività, l'Adorazione dei Magi, la Presenta-
zione al Tempio, l'Ingresso in Gerusalemme, il Bacio di Giuda, la Crocifissione, la Deposi-
zione nel Sepolcro. Non è di esecuzione molto fine, ma le piccole scene sono disposte con
molta naturalezza ed espressione. 2
Anche le cere spettano alla scultura minore e alla piccola serie del Museo si sono ag-
giunti diversi bassirilievi. Le Marie al Sepolcro è il soggetto del più antico che è anche
colorito; le tre sante donne indossano ricche vesti con grandiglie e ricami di perle, che
sono pure profuse nell'acconciatura, secondo il costume della seconda metà del cinquecento.
La rappresentazione non ha nulla di sacro e molto probabilmente sì le Marie che l'Angelo
sono ritratti di gentildonne; ma è però lavorata con molta cura e può credersi di Mario
Capocaccia o di Costantino de' Servi o di Rutilio Gaei, di cui una volta si conservavano
assai cose di questo genere nella Galleria. In un altro bassorilievo minutissimo è rafiigu-
rata la liberazione di Vienna dai Turriti ; due, circolari, sono piccoli paesaggi.
La collezione delle oreficerie non è molto ricca: è vero che la parte migliore si con-
serva nella Galleria nel gabinetto delle gemme, ove i vasi preziosi di Lorenzo il Magnifico
sono riuniti alle geniali creazioni degli orafi fiorentini del secolo decimosesto: il Museo
ha invece una discreta raccolta di arredi sacri, fra cui primeggiano le notissime paci di
niello.
L'acquisto di maggior valore di questa serie è un bassorilievo in rame cesellato, rico-
perto da una sottile laminetta d'oro, che rappresenta il re longobardo Agilulfo (fig. 17). Il
sovrano a testa nuda, eoi capelli lunghi divisi sulla fronte e con barba a punta, è seduto
di faccia in tra trono senza spalliera e solleva la destra in atto di benedire, mentre con
là sinistra tiene la spada posata sulle ginocchia;3 un lungo manto gli scende dalle spalle
e si ripiega sulle gambe; sotto ai piedi ha uno sgabello. Ai lati del re stanno due guer-
rieri con elmo conico a guanciali, vestiti di una lunga cotta, che sembra di cuoio con
rapporti di ferro, e armati di scudo rotondo e di lancia. Seguono, disposte simmetricamente,
due Vittorie alate con una cornucopia e un labaro su cui è scritto VICTORIA; due uomini
con tunica succinta a mani giunte; e due altri uomini similmente vestiti che portano una
corona a foggia di tiara sormontata dalla croce; dietro questi ultimi sono due edifici cir-
colari, forse due torri. Tutti i personaggi portano le brache ed hanno la testa rivolta di
faccia: il nome del re è scritto in alto in cinque righe dn-AG-IL-yl-REGI4 e ie lettere
sono formate per mezzo di puntini. È diffìcile il poter determinare di che cosa sia stato
parte questo bassorilievo: se di un trono, o di una rilegatura di evangeliario, o di una
cassetta da reliquie;5 è però certo che noi abbiamo in esso uno dei più importanti monu-
menti dell'arte longobarda, tanto più prezioso oggi che è distrutta la corona votiva donata
dallo stesso re Agilulfo alla basilica di .Monza. G
1 La chiesa di Acerenza è sotto l'invocazione di
Santa Maria Assunta e di San Canione che ne i'u ve-
scovo nel terzo secolo. Il San Pietro che sta presso il
prelato potrebbe quindi essere il suo santo protettore,
e il pastorale avrebbe, in tal caso, appartenuto a Pie-
tro da Monte Caveoso, trasferito da Venosa ad Ace-
renza nel 1334 da Giovanni XXII, e morto nel 1343.
Nel secolo xiv e nel susseguente non vi furono altri
arcivescovi col nome di Pietro, nò con quello di Gior-
gio, Maurizio, Teodoro o d'altri santi guerrieri.
8 Fu acquistato dalla chiesa parrocchiale di Acqua-
negra sul Chiese, in provincia di Mantova, pel mite
prezzo di settecento lire.
3 La spada è simile, nell'impugnatura, a quella no-
tissima di Childerico re dei Franchi.
4 La lettura dell'ultima parola è incerta.
& La lamina di rame è foderata da una lastra di
ferro tutta ossidata, di discreto spessore, che doveva
servire a mantenerla rigida; da certe traccio nella parte
posteriore sembrerebbe che il pezzo fosse stato appli-
cato su una tavola di legno.
f' Fu acquistato dal signor Guido Luigi Carrara di
UMBERTO ROSSI
gnom celorom qveconqve ligaverit svper teram. E lavoro di buona arte italiana ri-
feribile alla prima metà del secolo decimoquarto.1
L'altro oggetto è un dittico d'arte francese della stessa epoca, in cui sotto archetti
gotici sono rappresentate l'Annunciazione, la Natività, l'Adorazione dei Magi, la Presenta-
zione al Tempio, l'Ingresso in Gerusalemme, il Bacio di Giuda, la Crocifissione, la Deposi-
zione nel Sepolcro. Non è di esecuzione molto fine, ma le piccole scene sono disposte con
molta naturalezza ed espressione. 2
Anche le cere spettano alla scultura minore e alla piccola serie del Museo si sono ag-
giunti diversi bassirilievi. Le Marie al Sepolcro è il soggetto del più antico che è anche
colorito; le tre sante donne indossano ricche vesti con grandiglie e ricami di perle, che
sono pure profuse nell'acconciatura, secondo il costume della seconda metà del cinquecento.
La rappresentazione non ha nulla di sacro e molto probabilmente sì le Marie che l'Angelo
sono ritratti di gentildonne; ma è però lavorata con molta cura e può credersi di Mario
Capocaccia o di Costantino de' Servi o di Rutilio Gaei, di cui una volta si conservavano
assai cose di questo genere nella Galleria. In un altro bassorilievo minutissimo è rafiigu-
rata la liberazione di Vienna dai Turriti ; due, circolari, sono piccoli paesaggi.
La collezione delle oreficerie non è molto ricca: è vero che la parte migliore si con-
serva nella Galleria nel gabinetto delle gemme, ove i vasi preziosi di Lorenzo il Magnifico
sono riuniti alle geniali creazioni degli orafi fiorentini del secolo decimosesto: il Museo
ha invece una discreta raccolta di arredi sacri, fra cui primeggiano le notissime paci di
niello.
L'acquisto di maggior valore di questa serie è un bassorilievo in rame cesellato, rico-
perto da una sottile laminetta d'oro, che rappresenta il re longobardo Agilulfo (fig. 17). Il
sovrano a testa nuda, eoi capelli lunghi divisi sulla fronte e con barba a punta, è seduto
di faccia in tra trono senza spalliera e solleva la destra in atto di benedire, mentre con
là sinistra tiene la spada posata sulle ginocchia;3 un lungo manto gli scende dalle spalle
e si ripiega sulle gambe; sotto ai piedi ha uno sgabello. Ai lati del re stanno due guer-
rieri con elmo conico a guanciali, vestiti di una lunga cotta, che sembra di cuoio con
rapporti di ferro, e armati di scudo rotondo e di lancia. Seguono, disposte simmetricamente,
due Vittorie alate con una cornucopia e un labaro su cui è scritto VICTORIA; due uomini
con tunica succinta a mani giunte; e due altri uomini similmente vestiti che portano una
corona a foggia di tiara sormontata dalla croce; dietro questi ultimi sono due edifici cir-
colari, forse due torri. Tutti i personaggi portano le brache ed hanno la testa rivolta di
faccia: il nome del re è scritto in alto in cinque righe dn-AG-IL-yl-REGI4 e ie lettere
sono formate per mezzo di puntini. È diffìcile il poter determinare di che cosa sia stato
parte questo bassorilievo: se di un trono, o di una rilegatura di evangeliario, o di una
cassetta da reliquie;5 è però certo che noi abbiamo in esso uno dei più importanti monu-
menti dell'arte longobarda, tanto più prezioso oggi che è distrutta la corona votiva donata
dallo stesso re Agilulfo alla basilica di .Monza. G
1 La chiesa di Acerenza è sotto l'invocazione di
Santa Maria Assunta e di San Canione che ne i'u ve-
scovo nel terzo secolo. Il San Pietro che sta presso il
prelato potrebbe quindi essere il suo santo protettore,
e il pastorale avrebbe, in tal caso, appartenuto a Pie-
tro da Monte Caveoso, trasferito da Venosa ad Ace-
renza nel 1334 da Giovanni XXII, e morto nel 1343.
Nel secolo xiv e nel susseguente non vi furono altri
arcivescovi col nome di Pietro, nò con quello di Gior-
gio, Maurizio, Teodoro o d'altri santi guerrieri.
8 Fu acquistato dalla chiesa parrocchiale di Acqua-
negra sul Chiese, in provincia di Mantova, pel mite
prezzo di settecento lire.
3 La spada è simile, nell'impugnatura, a quella no-
tissima di Childerico re dei Franchi.
4 La lettura dell'ultima parola è incerta.
& La lamina di rame è foderata da una lastra di
ferro tutta ossidata, di discreto spessore, che doveva
servire a mantenerla rigida; da certe traccio nella parte
posteriore sembrerebbe che il pezzo fosse stato appli-
cato su una tavola di legno.
f' Fu acquistato dal signor Guido Luigi Carrara di