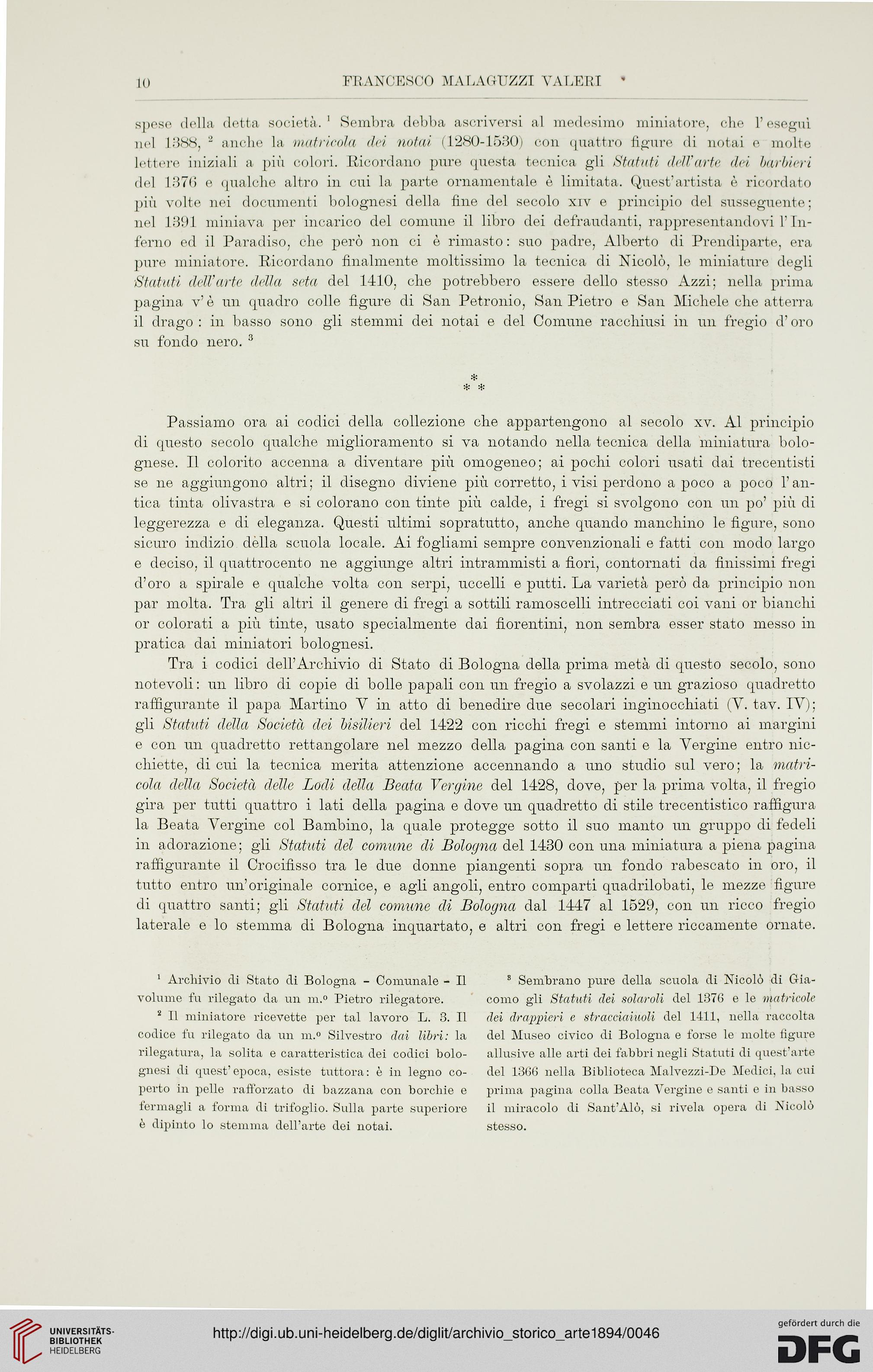10
FRANCESCO MALAGUZZ1 VALERI *
spese della detta società.1 Sembra debba ascriversi al medesimo miniatore, che L'eseguì
nel L388, J anche La matricola dei no/ni (1280-1530 con quattro figure di notai e molte
lettere iniziali a più colori. Ricordano pure questa tecnica gli Statuti dell'arte dei barbieri
de] L376 e qualche altro in cui la parte ornamentale è limitata. Quest'artista è ricordato
più volte nei documenti bolognesi della fine del secolo xiv e principio del susseguente;
nel L391 miniava per incarico del comune il libro dei defraudanti, rappresentandovi 1* In-
ferno ed il Paradiso, che però non ci è rimasto: suo padre, Alberto di Prendiparte, era
pure miniatore. Ricordano finalmente moltissimo la tecnica di Nicolò, le miniature degli
Statuii dell'arte della seta del 1410, che potrebbero essere dello stesso Azzi; nella prima
pagina v'è un quadro colle figure di San Petronio, San Pietro e San Michele che atterra
il drago: in basso sono gli stemmi dei notai e del Comune racchiusi in un fregio d'oro
su fondo nero. 3
*
* *
Passiamo ora ai codici della collezione che appartengono al secolo xv. Al principio
di questo secolo qualche miglioramento si va notando nella tecnica della miniatura bolo-
gnese. Il colorito accenna a diventare più omogeneo; ai pochi colori usati dai trecentisti
se ne aggiungono altri; il disegno diviene più corretto, i visi perdono a poco a poco l'an-
tica tinta olivastra e si colorano con tinte più calde, i fregi si svolgono con un po' più di
leggerezza e di eleganza. Questi ultimi sopratutto, anche quando manchino le figure, sono
sicuro indizio dèlia scuola locale. Ai fogliami sempre convenzionali e fatti con modo largo
e deciso, il quattrocento ne aggiunge altri intrammisti a fiori, contornati da finissimi fregi
d'oro a spirale e qualche volta con serpi, uccelli e putti. La varietà però da principio non
par molta. Tra gli altri il genere di fregi a sottili ramoscelli intrecciati coi vani or bianchi
or colorati a più tinte, usato specialmente dai fiorentini, non sembra esser stato messo in
pratica dai miniatori bolognesi.
Tra i codici dell'Archivio di Stato di Bologna della prima metà di questo secolo, sono
notevoli : un libro di copie di bolle papali con un fregio a svolazzi e un grazioso quadretto
raffigurante il papa Martino V in atto di benedire due secolari inginocchiati (V. tav. IV);
gli Statuti della Società dei bisilieri del 1422 con ricchi fregi e stemmi intorno ai margini
e con un quadretto rettangolare nel mezzo della pagina con santi e la Vergine entro nic-
chiette, di cui la tecnica merita attenzione accennando a uno studio sul vero; la matri-
cola della Società delle Lodi della Beata Vergine del 1428, dove, per la prima volta, il fregio
gira per tutti quattro i lati della pagina e dove un quadretto di stile trecentistico raffigura
la Beata Vergine col Bambino, la quale protegge sotto il suo manto un gruppo di fedeli
in adorazione ; gli Statuti del comune di Bologna del 1430 con una miniatura a piena pagina
raffigurante il Crocifìsso tra le due donne piangenti sopra un fondo rabescato in oro, il
tutto entro un'originale cornice, e agli angoli, entro comparti quadrilobati, le mezze figure
di quattro santi; gli Statuti del comune di Bologna dal 1447 al 1529, con un ricco fregio
laterale e lo stemma di Bologna inquartato, e altri con fregi e lettere riccamente ornate.
1 Archivio di Stato di Bologna - Comunale - Il
volume fu rilegato da un m.° Pietro rilegatore.
2 II miniatore ricevette per tal lavoro L. 3. Il
codice fu rilegato da un m.° Silvestro dai libri: la
rilegatura, la solita e caratteristica dei codici bolo-
gnesi di quest'epoca, esiste tuttora: è in legno co-
perto in pelle rafforzato di bazzana con borchie e
fermagli a forma di trifoglio. Sulla parte superiore
è dipinto lo stemma dell'arte dei notai.
8 Sembrano pure della scuola di Nicolò di Gia-
como gli Statuti dei solaroli del 137G e le rkatricóle
dei drappieri e stracciaiuoli del 1411, nella raccolta
del Mtiseo civico di Bologna e forse le molte figure
allusive alle arti dei fabbri negli Statuti di quest'arte
del 13GG nella Biblioteca Malvezzi-De Medici, la cui
prima pagina colla Beata Vergine e santi e in basso
il miracolo di Sant'Aio, si rivela opera di Nicolò
stesso.
FRANCESCO MALAGUZZ1 VALERI *
spese della detta società.1 Sembra debba ascriversi al medesimo miniatore, che L'eseguì
nel L388, J anche La matricola dei no/ni (1280-1530 con quattro figure di notai e molte
lettere iniziali a più colori. Ricordano pure questa tecnica gli Statuti dell'arte dei barbieri
de] L376 e qualche altro in cui la parte ornamentale è limitata. Quest'artista è ricordato
più volte nei documenti bolognesi della fine del secolo xiv e principio del susseguente;
nel L391 miniava per incarico del comune il libro dei defraudanti, rappresentandovi 1* In-
ferno ed il Paradiso, che però non ci è rimasto: suo padre, Alberto di Prendiparte, era
pure miniatore. Ricordano finalmente moltissimo la tecnica di Nicolò, le miniature degli
Statuii dell'arte della seta del 1410, che potrebbero essere dello stesso Azzi; nella prima
pagina v'è un quadro colle figure di San Petronio, San Pietro e San Michele che atterra
il drago: in basso sono gli stemmi dei notai e del Comune racchiusi in un fregio d'oro
su fondo nero. 3
*
* *
Passiamo ora ai codici della collezione che appartengono al secolo xv. Al principio
di questo secolo qualche miglioramento si va notando nella tecnica della miniatura bolo-
gnese. Il colorito accenna a diventare più omogeneo; ai pochi colori usati dai trecentisti
se ne aggiungono altri; il disegno diviene più corretto, i visi perdono a poco a poco l'an-
tica tinta olivastra e si colorano con tinte più calde, i fregi si svolgono con un po' più di
leggerezza e di eleganza. Questi ultimi sopratutto, anche quando manchino le figure, sono
sicuro indizio dèlia scuola locale. Ai fogliami sempre convenzionali e fatti con modo largo
e deciso, il quattrocento ne aggiunge altri intrammisti a fiori, contornati da finissimi fregi
d'oro a spirale e qualche volta con serpi, uccelli e putti. La varietà però da principio non
par molta. Tra gli altri il genere di fregi a sottili ramoscelli intrecciati coi vani or bianchi
or colorati a più tinte, usato specialmente dai fiorentini, non sembra esser stato messo in
pratica dai miniatori bolognesi.
Tra i codici dell'Archivio di Stato di Bologna della prima metà di questo secolo, sono
notevoli : un libro di copie di bolle papali con un fregio a svolazzi e un grazioso quadretto
raffigurante il papa Martino V in atto di benedire due secolari inginocchiati (V. tav. IV);
gli Statuti della Società dei bisilieri del 1422 con ricchi fregi e stemmi intorno ai margini
e con un quadretto rettangolare nel mezzo della pagina con santi e la Vergine entro nic-
chiette, di cui la tecnica merita attenzione accennando a uno studio sul vero; la matri-
cola della Società delle Lodi della Beata Vergine del 1428, dove, per la prima volta, il fregio
gira per tutti quattro i lati della pagina e dove un quadretto di stile trecentistico raffigura
la Beata Vergine col Bambino, la quale protegge sotto il suo manto un gruppo di fedeli
in adorazione ; gli Statuti del comune di Bologna del 1430 con una miniatura a piena pagina
raffigurante il Crocifìsso tra le due donne piangenti sopra un fondo rabescato in oro, il
tutto entro un'originale cornice, e agli angoli, entro comparti quadrilobati, le mezze figure
di quattro santi; gli Statuti del comune di Bologna dal 1447 al 1529, con un ricco fregio
laterale e lo stemma di Bologna inquartato, e altri con fregi e lettere riccamente ornate.
1 Archivio di Stato di Bologna - Comunale - Il
volume fu rilegato da un m.° Pietro rilegatore.
2 II miniatore ricevette per tal lavoro L. 3. Il
codice fu rilegato da un m.° Silvestro dai libri: la
rilegatura, la solita e caratteristica dei codici bolo-
gnesi di quest'epoca, esiste tuttora: è in legno co-
perto in pelle rafforzato di bazzana con borchie e
fermagli a forma di trifoglio. Sulla parte superiore
è dipinto lo stemma dell'arte dei notai.
8 Sembrano pure della scuola di Nicolò di Gia-
como gli Statuti dei solaroli del 137G e le rkatricóle
dei drappieri e stracciaiuoli del 1411, nella raccolta
del Mtiseo civico di Bologna e forse le molte figure
allusive alle arti dei fabbri negli Statuti di quest'arte
del 13GG nella Biblioteca Malvezzi-De Medici, la cui
prima pagina colla Beata Vergine e santi e in basso
il miracolo di Sant'Aio, si rivela opera di Nicolò
stesso.