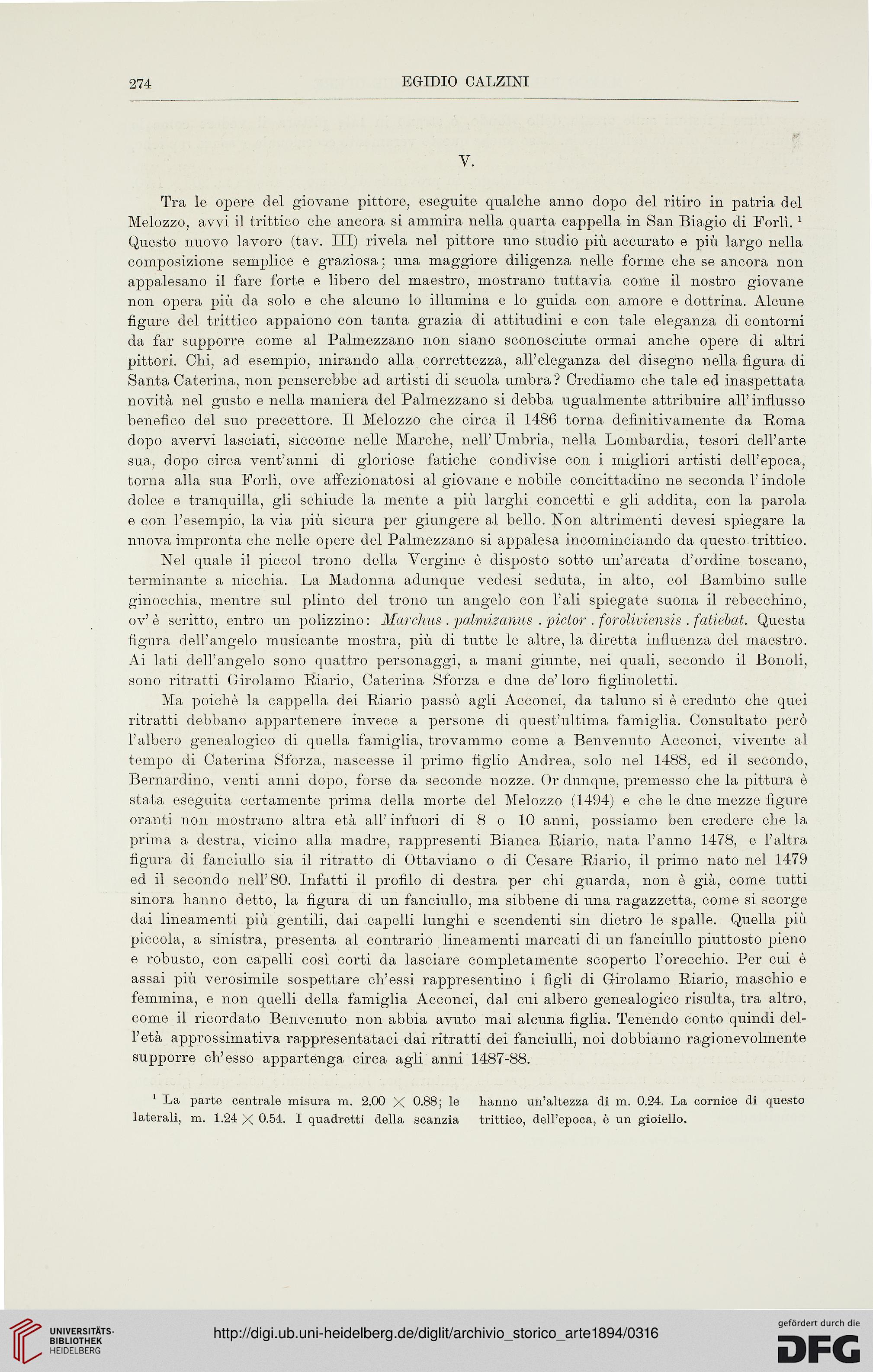274
EGIDIO CALZINI
V.
Tra le opere del giovane pittore, eseguite qualche anno dopo del ritiro in patria del
Melozzo, avvi il trittico che ancora si ammira nella quarta cappella in San Biagio di Forlì. 1
Questo nuovo lavoro (tav. III) rivela nel pittore uno studio più accurato e più largo nella
composizione semplice e graziosa ; una maggiore diligenza nelle forme che se ancora non
appalesano il fare forte e libero del maestro, mostrano tuttavia come il nostro giovane
non opera più da solo e che alcuno lo illumina e lo guida con amore e dottrina. Alcune
figure del trittico appaiono con tanta grazia di attitudini e con tale eleganza di contorni
da far supporre come al Palmezzano non siano sconosciute ormai anche opere di altri
pittori. Chi, ad esempio, mirando alla correttezza, all'eleganza del disegno nella figura di
Santa Caterina, non penserebbe ad artisti di scuola umbra? Crediamo che tale ed inaspettata
novità nel gusto e nella maniera del Palmezzano si debba ugualmente attribuire all' influsso
benefico del suo precettore. Il Melozzo che circa il 1486 torna definitivamente da Roma
dopo avervi lasciati, siccome nelle Marche, nell'Umbria, nella Lombardia, tesori dell'arte
sua, dopo circa vent'anni di gloriose fatiche condivise con i migliori artisti dell'epoca,
torna alla sua Forlì, ove affezionatosi al giovane e nobile concittadino ne seconda l'indole
dolce e tranquilla, gli schiude la mente a più larghi concetti e gli addita, con la parola
e con l'esempio, la via più sicura per giungere al bello. Non altrimenti devesi spiegare la
nuova impronta che nelle opere del Palmezzano si appalesa incominciando da questo trittico.
Nel quale il piccol trono della Vergine è disposto sotto un'arcata d'ordine toscano,
terminante a nicchia. La Madonna adunque vedesi seduta, in alto, col Bambino sulle
ginocchia, mentre sul plinto del trono un angelo con l'ali spiegate suona il rebecchino,
ov' è scritto, entro un polizzino : Marchus . palmizanus . pictor . foroliviensis . fatiebat. Questa
figura dell'angelo musicante mostra, più di tutte le altre, la diretta influenza del maestro.
Ai Lati dell'angelo sono quattro personaggi, a mani giunte, nei quali, secondo il Bonoli,
sono ritratti Girolamo Riario, Caterina Sforza e due de' loro figliuoletti.
Ma poiché la cappella dei Riario passò agli Acconci, da taluno si è creduto che quei
ritratti debbano appartenere invece a persone di quest'ultima famiglia. Consultato però
l'albero genealogico di quella famiglia, trovammo come a Benvenuto Acconci, vivente al
tempo di Caterina Sforza, nascesse il primo figlio Andrea, solo nel 1488, ed il secondo,
Bernardino, venti anni dopo, forse da seconde nozze. Or dunque, premesso che la pittura è
stata eseguita certamente prima della morte del Melozzo (1494) e che le due mezze figure
oranti non mostrano altra età all' infuori di 8 o 10 anni, possiamo ben credere che la
prima a destra, vicino alla madre, rappresenti Bianca Riario, nata l'anno 1478, e l'altra
figura di fanciullo sia il ritratto di Ottaviano o di Cesare Riario, il primo nato nel 1479
ed il secondo nell'80. Infatti il profilo di destra per chi guarda, non è già, come tutti
sinora hanno detto, la figura di un fanciullo, ma sibbene di una ragazzetta, come si scorge
dai lineamenti più gentili, dai capelli lunghi e scendenti sin dietro le spalle. Quella più
piccola, a sinistra, presenta al contrario lineamenti marcati di un fanciullo piuttosto pieno
e robusto, con capelli così corti da lasciare completamente scoperto l'orecchio. Per cui è
assai più verosimile sospettare ch'essi rappresentino i figli di Girolamo Riario, maschio e
femmina, e non quelli della famiglia Acconci, dal cui albero genealogico risulta, tra altro,
come il ricordato Benvenuto non abbia avuto mai alcuna figlia. Tenendo conto quindi del-
l'età approssimativa rappresentataci dai ritratti dei fanciulli, noi dobbiamo ragionevolmente
supporre ch'esso appartenga circa agli anni 1487-88.
1 La parte centrale misura m. 2.00 X 0.88; le hanno un'altezza di m. 0.24. La cornice di questo
laterali, m. 1.24 X 0.54. I quadretti della scanzia trittico, dell'epoca, è un gioiello.
EGIDIO CALZINI
V.
Tra le opere del giovane pittore, eseguite qualche anno dopo del ritiro in patria del
Melozzo, avvi il trittico che ancora si ammira nella quarta cappella in San Biagio di Forlì. 1
Questo nuovo lavoro (tav. III) rivela nel pittore uno studio più accurato e più largo nella
composizione semplice e graziosa ; una maggiore diligenza nelle forme che se ancora non
appalesano il fare forte e libero del maestro, mostrano tuttavia come il nostro giovane
non opera più da solo e che alcuno lo illumina e lo guida con amore e dottrina. Alcune
figure del trittico appaiono con tanta grazia di attitudini e con tale eleganza di contorni
da far supporre come al Palmezzano non siano sconosciute ormai anche opere di altri
pittori. Chi, ad esempio, mirando alla correttezza, all'eleganza del disegno nella figura di
Santa Caterina, non penserebbe ad artisti di scuola umbra? Crediamo che tale ed inaspettata
novità nel gusto e nella maniera del Palmezzano si debba ugualmente attribuire all' influsso
benefico del suo precettore. Il Melozzo che circa il 1486 torna definitivamente da Roma
dopo avervi lasciati, siccome nelle Marche, nell'Umbria, nella Lombardia, tesori dell'arte
sua, dopo circa vent'anni di gloriose fatiche condivise con i migliori artisti dell'epoca,
torna alla sua Forlì, ove affezionatosi al giovane e nobile concittadino ne seconda l'indole
dolce e tranquilla, gli schiude la mente a più larghi concetti e gli addita, con la parola
e con l'esempio, la via più sicura per giungere al bello. Non altrimenti devesi spiegare la
nuova impronta che nelle opere del Palmezzano si appalesa incominciando da questo trittico.
Nel quale il piccol trono della Vergine è disposto sotto un'arcata d'ordine toscano,
terminante a nicchia. La Madonna adunque vedesi seduta, in alto, col Bambino sulle
ginocchia, mentre sul plinto del trono un angelo con l'ali spiegate suona il rebecchino,
ov' è scritto, entro un polizzino : Marchus . palmizanus . pictor . foroliviensis . fatiebat. Questa
figura dell'angelo musicante mostra, più di tutte le altre, la diretta influenza del maestro.
Ai Lati dell'angelo sono quattro personaggi, a mani giunte, nei quali, secondo il Bonoli,
sono ritratti Girolamo Riario, Caterina Sforza e due de' loro figliuoletti.
Ma poiché la cappella dei Riario passò agli Acconci, da taluno si è creduto che quei
ritratti debbano appartenere invece a persone di quest'ultima famiglia. Consultato però
l'albero genealogico di quella famiglia, trovammo come a Benvenuto Acconci, vivente al
tempo di Caterina Sforza, nascesse il primo figlio Andrea, solo nel 1488, ed il secondo,
Bernardino, venti anni dopo, forse da seconde nozze. Or dunque, premesso che la pittura è
stata eseguita certamente prima della morte del Melozzo (1494) e che le due mezze figure
oranti non mostrano altra età all' infuori di 8 o 10 anni, possiamo ben credere che la
prima a destra, vicino alla madre, rappresenti Bianca Riario, nata l'anno 1478, e l'altra
figura di fanciullo sia il ritratto di Ottaviano o di Cesare Riario, il primo nato nel 1479
ed il secondo nell'80. Infatti il profilo di destra per chi guarda, non è già, come tutti
sinora hanno detto, la figura di un fanciullo, ma sibbene di una ragazzetta, come si scorge
dai lineamenti più gentili, dai capelli lunghi e scendenti sin dietro le spalle. Quella più
piccola, a sinistra, presenta al contrario lineamenti marcati di un fanciullo piuttosto pieno
e robusto, con capelli così corti da lasciare completamente scoperto l'orecchio. Per cui è
assai più verosimile sospettare ch'essi rappresentino i figli di Girolamo Riario, maschio e
femmina, e non quelli della famiglia Acconci, dal cui albero genealogico risulta, tra altro,
come il ricordato Benvenuto non abbia avuto mai alcuna figlia. Tenendo conto quindi del-
l'età approssimativa rappresentataci dai ritratti dei fanciulli, noi dobbiamo ragionevolmente
supporre ch'esso appartenga circa agli anni 1487-88.
1 La parte centrale misura m. 2.00 X 0.88; le hanno un'altezza di m. 0.24. La cornice di questo
laterali, m. 1.24 X 0.54. I quadretti della scanzia trittico, dell'epoca, è un gioiello.