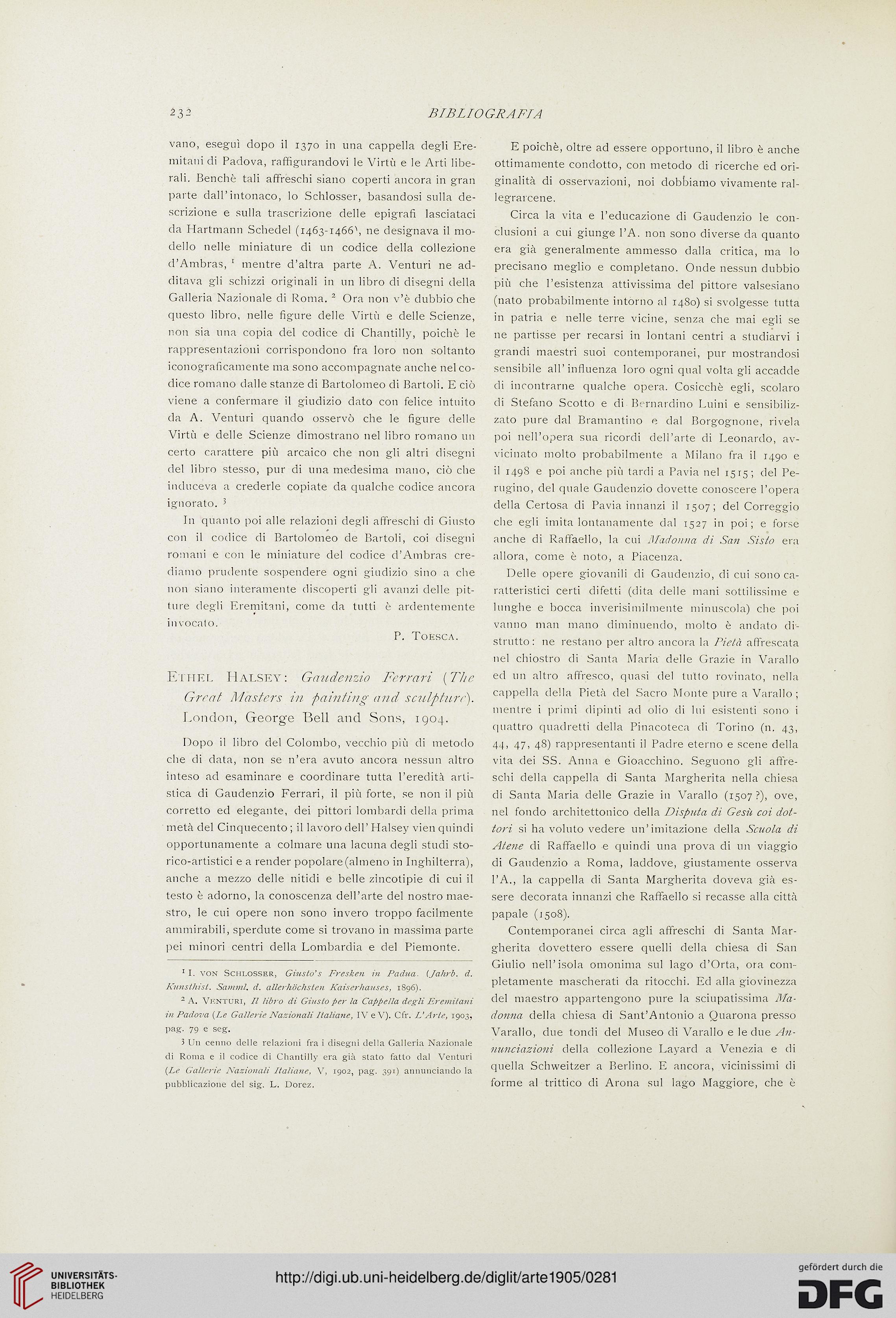BIBLIOGRAFI A
23:2
vano, eseguì dopo il 1370 in una cappella degli Ere-
mitani di Padova, raffigurandovi le Virtù e le Arti libe-
rali. Benché tali affreschi siano coperti ancora in gran
parte dall’intonaco, lo Schlosser, basandosi sulla de-
scrizione e sulla trascrizione delle epigrafi lasciataci
da Hartmann Schedel (1463-1466', ne designava il mo-
dello nelle miniature di un codice della collezione
d’Ambras, 1 mentre d’altra parte A. Venturi ne ad-
ditava gli schizzi originali in un libro di disegni della
Galleria Nazionale di Roma. 2 Ora non v’è dubbio che
questo libro, nelle figure delle Virtù e delle Scienze,
non sia una copia del codice di Chantilly, poiché le
rappresentazioni corrispondono fra loro non soltanto
iconograficamente ma sono accompagnate anche nel co-
dice romano dalle stanze di Bartolomeo di Bartoli. E ciò
viene a confermare il giudizio dato con felice intuito
da A. Venturi quando osservò che le figure delle
Virtù e delle Scienze dimostrano nel libro romano un
certo carattere più arcaico che non gli altri disegni
del libro stesso, pur di una medesima mano, ciò che
induceva a crederle copiate da qualche codice ancora
ignorato. 3
In quanto poi alle relazioni degli affreschi di Giusto
con il codice di Bartolomeo de Bartoli, coi disegni
romani e con le miniature del codice d’Ambras cre-
diamo prudente sospendere ogni giudizio sino a che
non siano interamente discoperti gli avanzi delle pit-
ture degli Eremitani, come da tutti è ardentemente
invocato.
P. Toesca.
Ett-tel Halsey: Gaudenzio Ferrari (77/e
Grrat Alasters in painting and sculjbture).
London, George Bell and Sons, 1904.
Dopo il libro del Colombo, vecchio più di metodo
che di data, non se n’era avuto ancora nessun altro
inteso ad esaminare e coordinare tutta l’eredità arti-
stica di Gaudenzio Ferrari, il più forte, se non il più
corretto ed elegante, dei pittori lombardi della prima
metà del Cinquecento ; il lavoro dell’ Halsey vien quindi
opportunamente a colmare una lacuna degli studi sto-
rico-artistici e a render popolare (almeno in Inghilterra),
anche a mezzo delle nitidi e belle zincotlpie di cui il
testo è adorno, la conoscenza dell’arte del nostro mae-
stro, le cui opere non sono invero troppo facilmente
ammirabili, sperdute come si trovano in massima parte
pei minori centri della Lombardia e del Piemonte.
1 I. von Schlosser, Giusto’s Fresken in Padua. (Jahrb. d.
Kunsthist. Sanimi, d. allerhochsten Kaiserhauses, 1896).
2 A. Venturi, Il libro dì Giusto per la Cappella degli Eremitani
in Padova (Le Gallerie Nazionali Italiane, IV eV). Cfr. L'Arte, 1903,
pag. 79 e seg.
3 Un cenno delle relazioni fra i disegni della Galleria Nazionale
di Roma e il codice di Chantilly era già stato fatto dal Venturi
{Le Gallerie Nazionali Italiane, V, 1902, pag. 391) annunciando la
pubblicazione del sig. L. Dorez.
E poiché, oltre ad essere opportuno, il libro è anche
ottimamente condotto, con metodo di ricerche ed ori-
ginalità di osservazioni, noi dobbiamo vivamente ral-
legrarcene.
Circa la vita e l’educazione di Gaudenzio le con-
clusioni a cui giunge l’A. non sono diverse da quanto
era già generalmente ammesso dalla critica, ma lo
precisano meglio e completano. Onde nessun dubbio
più che l’esistenza attivissima del pittore valsesiano
(nato probabilmente intorno al 1480) si svolgesse tutta
in patria e nelle terre vicine, senza che mai egli se
ne partisse per recarsi in lontani centri a studiarvi i
grandi maestri suoi contemporanei, pur mostrandosi
sensibile all’influenza loro ogni qual volta gli accadde
di incontrarne qualche opera. Cosicché egli, scolaro
di Stefano Scotto e di Bernardino Luini e sensibiliz-
zato pure dal Bramantino e dal Borgognone, rivela
poi nell’opera sua ricordi dell’arte di Leonardo, av-
vicinato molto probabilmente a Milano fra il 1490 e
il 1498 e poi anche più tardi a Pavia nel 1515; del Pe-
rugino, del quale Gaudenzio dovette conoscere l’opera
della Certosa di Pavia innanzi il 1507; del Correggio
che egli imita lontanamente dal 1527 in poi; e forse
anche di Raffaello, la cui Madonna di San Sisto era
allora, come è noto, a Piacenza.
Delle opere giovanili di Gaudenzio, di cui sono ca-
ratteristici certi difetti (dita delle mani sottilissime e
lunghe e bocca inverisimilmente minuscola) che poi
vanno man mano diminuendo, molto è andato di-
strutto: ne restano per altro ancora la Pietà affrescata
nel chiostro di Santa Maria delle Grazie in Varallo
ed un altro affresco, quasi del tutto rovinato, nella
cappella della Pietà del Sacro Monte pure a Varallo ;
mentre i primi dipinti ad olio di lui esistenti sono i
quattro quadretti della Pinacoteca di Torino (n. 43,
44, 47, 48) rappresentanti il Padre eterno e scene della
vita dei SS. Anna e Gioacchino. Seguono gli affre-
schi della cappella di Santa Margherita nella chiesa
di Santa Maria delle Grazie in Varallo (1507 ?), ove,
nel fondo architettonico della Disputa di Gesù coi dot-
tori si ha voluto vedere un’imitazione della Scuola di
Atene di Raffaello e quindi una prova di un viaggio
di Gaudenzio a Roma, laddove, giustamente osserva
l’A., la cappella di Santa Margherita doveva già es-
sere decorata innanzi che Raffaello si recasse alla città
papale (1508).
Contemporanei circa agli affreschi di Santa Mar-
gherita dovettero essere quelli della chiesa di San
Giulio nell’isola omonima sul lago d’Orta, ora com-
pletamente mascherati da ritocchi. Ed alla giovinezza
del maestro appartengono pure la sciupatissima Ma-
donna della chiesa di Sant’Antonio a Quarona presso
Varallo, due tondi del Museo di Varallo e le due An-
nunciazioni della collezione Layard a Venezia e di
quella Schweitzer a Berlino. E ancora, vicinissimi di
forme al trittico di Arona sul lago Maggiore, che è
23:2
vano, eseguì dopo il 1370 in una cappella degli Ere-
mitani di Padova, raffigurandovi le Virtù e le Arti libe-
rali. Benché tali affreschi siano coperti ancora in gran
parte dall’intonaco, lo Schlosser, basandosi sulla de-
scrizione e sulla trascrizione delle epigrafi lasciataci
da Hartmann Schedel (1463-1466', ne designava il mo-
dello nelle miniature di un codice della collezione
d’Ambras, 1 mentre d’altra parte A. Venturi ne ad-
ditava gli schizzi originali in un libro di disegni della
Galleria Nazionale di Roma. 2 Ora non v’è dubbio che
questo libro, nelle figure delle Virtù e delle Scienze,
non sia una copia del codice di Chantilly, poiché le
rappresentazioni corrispondono fra loro non soltanto
iconograficamente ma sono accompagnate anche nel co-
dice romano dalle stanze di Bartolomeo di Bartoli. E ciò
viene a confermare il giudizio dato con felice intuito
da A. Venturi quando osservò che le figure delle
Virtù e delle Scienze dimostrano nel libro romano un
certo carattere più arcaico che non gli altri disegni
del libro stesso, pur di una medesima mano, ciò che
induceva a crederle copiate da qualche codice ancora
ignorato. 3
In quanto poi alle relazioni degli affreschi di Giusto
con il codice di Bartolomeo de Bartoli, coi disegni
romani e con le miniature del codice d’Ambras cre-
diamo prudente sospendere ogni giudizio sino a che
non siano interamente discoperti gli avanzi delle pit-
ture degli Eremitani, come da tutti è ardentemente
invocato.
P. Toesca.
Ett-tel Halsey: Gaudenzio Ferrari (77/e
Grrat Alasters in painting and sculjbture).
London, George Bell and Sons, 1904.
Dopo il libro del Colombo, vecchio più di metodo
che di data, non se n’era avuto ancora nessun altro
inteso ad esaminare e coordinare tutta l’eredità arti-
stica di Gaudenzio Ferrari, il più forte, se non il più
corretto ed elegante, dei pittori lombardi della prima
metà del Cinquecento ; il lavoro dell’ Halsey vien quindi
opportunamente a colmare una lacuna degli studi sto-
rico-artistici e a render popolare (almeno in Inghilterra),
anche a mezzo delle nitidi e belle zincotlpie di cui il
testo è adorno, la conoscenza dell’arte del nostro mae-
stro, le cui opere non sono invero troppo facilmente
ammirabili, sperdute come si trovano in massima parte
pei minori centri della Lombardia e del Piemonte.
1 I. von Schlosser, Giusto’s Fresken in Padua. (Jahrb. d.
Kunsthist. Sanimi, d. allerhochsten Kaiserhauses, 1896).
2 A. Venturi, Il libro dì Giusto per la Cappella degli Eremitani
in Padova (Le Gallerie Nazionali Italiane, IV eV). Cfr. L'Arte, 1903,
pag. 79 e seg.
3 Un cenno delle relazioni fra i disegni della Galleria Nazionale
di Roma e il codice di Chantilly era già stato fatto dal Venturi
{Le Gallerie Nazionali Italiane, V, 1902, pag. 391) annunciando la
pubblicazione del sig. L. Dorez.
E poiché, oltre ad essere opportuno, il libro è anche
ottimamente condotto, con metodo di ricerche ed ori-
ginalità di osservazioni, noi dobbiamo vivamente ral-
legrarcene.
Circa la vita e l’educazione di Gaudenzio le con-
clusioni a cui giunge l’A. non sono diverse da quanto
era già generalmente ammesso dalla critica, ma lo
precisano meglio e completano. Onde nessun dubbio
più che l’esistenza attivissima del pittore valsesiano
(nato probabilmente intorno al 1480) si svolgesse tutta
in patria e nelle terre vicine, senza che mai egli se
ne partisse per recarsi in lontani centri a studiarvi i
grandi maestri suoi contemporanei, pur mostrandosi
sensibile all’influenza loro ogni qual volta gli accadde
di incontrarne qualche opera. Cosicché egli, scolaro
di Stefano Scotto e di Bernardino Luini e sensibiliz-
zato pure dal Bramantino e dal Borgognone, rivela
poi nell’opera sua ricordi dell’arte di Leonardo, av-
vicinato molto probabilmente a Milano fra il 1490 e
il 1498 e poi anche più tardi a Pavia nel 1515; del Pe-
rugino, del quale Gaudenzio dovette conoscere l’opera
della Certosa di Pavia innanzi il 1507; del Correggio
che egli imita lontanamente dal 1527 in poi; e forse
anche di Raffaello, la cui Madonna di San Sisto era
allora, come è noto, a Piacenza.
Delle opere giovanili di Gaudenzio, di cui sono ca-
ratteristici certi difetti (dita delle mani sottilissime e
lunghe e bocca inverisimilmente minuscola) che poi
vanno man mano diminuendo, molto è andato di-
strutto: ne restano per altro ancora la Pietà affrescata
nel chiostro di Santa Maria delle Grazie in Varallo
ed un altro affresco, quasi del tutto rovinato, nella
cappella della Pietà del Sacro Monte pure a Varallo ;
mentre i primi dipinti ad olio di lui esistenti sono i
quattro quadretti della Pinacoteca di Torino (n. 43,
44, 47, 48) rappresentanti il Padre eterno e scene della
vita dei SS. Anna e Gioacchino. Seguono gli affre-
schi della cappella di Santa Margherita nella chiesa
di Santa Maria delle Grazie in Varallo (1507 ?), ove,
nel fondo architettonico della Disputa di Gesù coi dot-
tori si ha voluto vedere un’imitazione della Scuola di
Atene di Raffaello e quindi una prova di un viaggio
di Gaudenzio a Roma, laddove, giustamente osserva
l’A., la cappella di Santa Margherita doveva già es-
sere decorata innanzi che Raffaello si recasse alla città
papale (1508).
Contemporanei circa agli affreschi di Santa Mar-
gherita dovettero essere quelli della chiesa di San
Giulio nell’isola omonima sul lago d’Orta, ora com-
pletamente mascherati da ritocchi. Ed alla giovinezza
del maestro appartengono pure la sciupatissima Ma-
donna della chiesa di Sant’Antonio a Quarona presso
Varallo, due tondi del Museo di Varallo e le due An-
nunciazioni della collezione Layard a Venezia e di
quella Schweitzer a Berlino. E ancora, vicinissimi di
forme al trittico di Arona sul lago Maggiore, che è