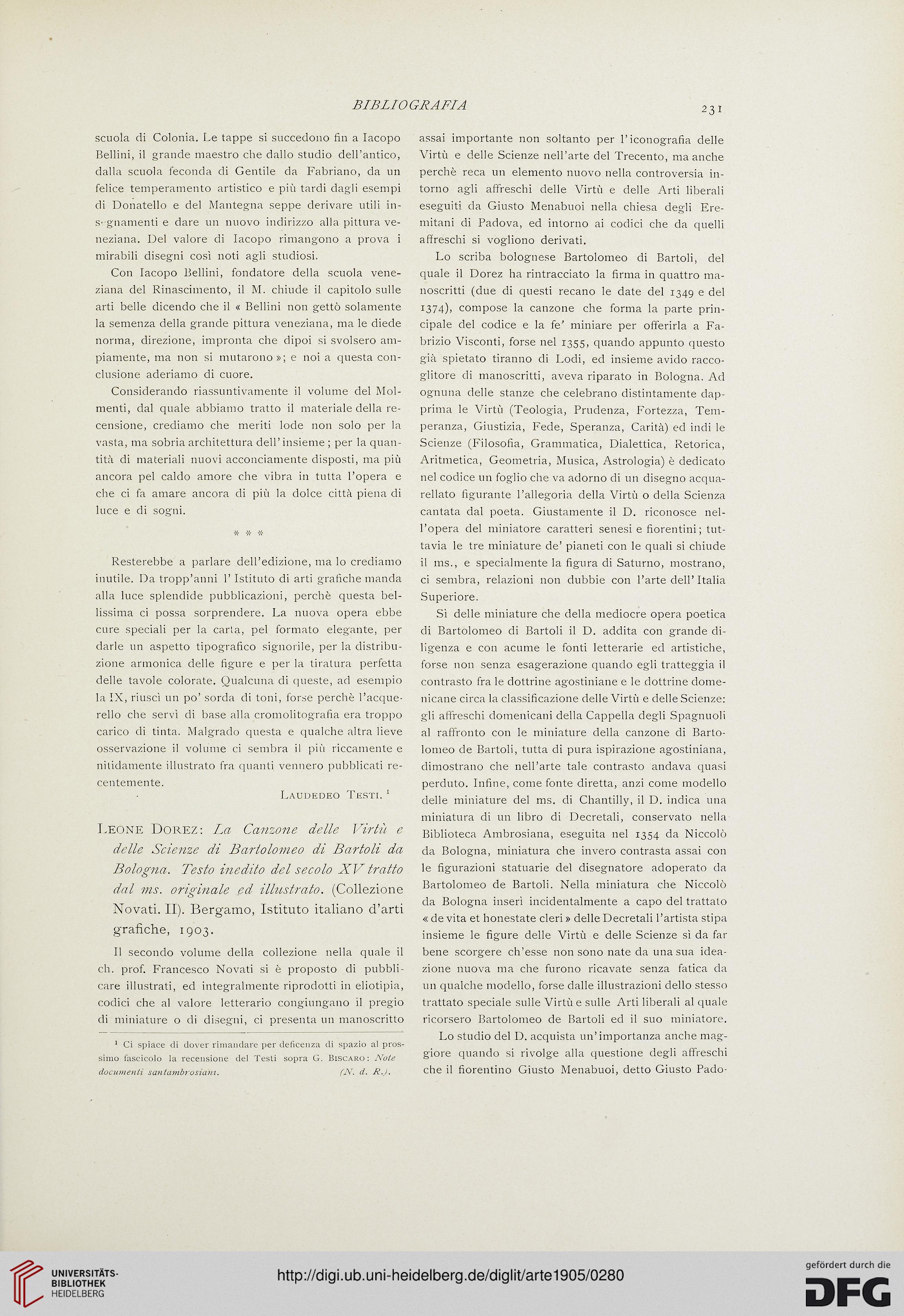BIBLIOGRAFIA
231
scuola di Colonia. Le tappe si succedono fin a Iacopo
Bellini, il grande maestro che dallo studio dell’antico,
dalla scuola feconda di Gentile da Fabriano, da un
felice temperamento artistico e più tardi dagli esempi
di Donatello e del Mantegna seppe derivare utili in-
segnamenti e dare un nuovo indirizzo alla pittura ve-
neziana. Del valore di Iacopo rimangono a prova i
mirabili disegni così noti agli studiosi.
Con Iacopo Bellini, fondatore della scuola vene-
ziana del Rinascimento, il M. chiude il capitolo sulle
arti belle dicendo che il « Bellini non gettò solamente
la semenza della grande pittura veneziana, ma le diede
norma, direzione, impronta che dipoi si svolsero am-
piamente, ma non si mutarono»; e noi a questa con-
clusione aderiamo di cuore.
Considerando riassuntivamente il volume del Mol-
menti, dal quale abbiamo tratto il materiale della re-
censione, crediamo che meriti lode non solo per la
vasta, ma sobria architettura dell’ insieme ; per la quan-
tità di materiali nuovi acconciamente disposti, ma più
ancora pel caldo amore che vibra in tutta l’opera e
che ci fa amare ancora di più la dolce città piena di
luce e di sogni.
* * *
Resterebbe a parlare dell’edizione, ma lo crediamo
inutile. Da tropp’anni 1’ Istituto di arti grafiche manda
alla luce splendide pubblicazioni, perchè questa bel-
lissima ci possa sorprendere. La nuova opera ebbe
cure speciali per la carta, pel formato elegante, per
darle un aspetto tipografico signorile, per la distribu-
zione armonica delle figure e per la tiratura perfetta
delle tavole colorate. Qualcuna di queste, ad esempio
la IX, riuscì un po’ sorda di toni, forse perchè l’acque-
rello che servì di base alla cromolitografia era troppo
carico di tinta. Malgrado questa e qualche altra lieve
osservazione il volume ci sembra il più riccamente e
nitidamente illustrato fra quanti vennero pubblicati re-
centemente.
Laudedeo Testi. 1
Leone Dorez: la Canzone delle Virtù e
delle Scienze di Bartolomeo di Bartoli da
Bologna. Testo inedito del secolo XJ" tratto
dal ms. originale ed illustrato. (Collezione
Novati. II). Bergamo, Istituto italiano d’arti
grafiche, 1903.
Il secondo volume della collezione nella quale il
eh. prof. Francesco Novati si è proposto di pubbli-
care illustrati, ed integralmente riprodotti in eliotipia,
codici che al valore letterario congiungano il pregio
di miniature o di disegni, ci presenta un manoscritto
1 Ci spiace di dover rimandare per deficenza di spazio al pros-
simo fascicolo la recensione del Testi sopra G. Biscaro : Note
documenti santambrosiani. (N. d. R.J.
assai importante non soltanto per l’iconografia delle
Virtù e delle Scienze nell’arte del Trecento, ma anche
perchè reca un elemento nuovo nella controversia in-
torno agli affreschi delle Virtù e delle Arti liberali
eseguiti da Giusto Menabuoi nella chiesa degli Ere-
mitani di Padova, ed intorno ai codici che da quelli
affreschi si vogliono derivati.
Lo scriba bolognese Bartolomeo di Bartoli, del
quale il Dorez ha rintracciato la firma in quattro ma-
noscritti (due di questi recano le date del 1349 e del
1374), compose la canzone che forma la parte prin-
cipale del codice e la fe’ miniare per offerirla a Fa-
brizio Visconti, forse nel 1355, quando appunto questo
già spietato tiranno di Lodi, ed insieme avido racco-
glitore di manoscritti, aveva riparato in Bologna. Ad
ognuna delle stanze che celebrano distintamente dap-
prima le Virtù (Teologia, Prudenza, Fortezza, Tem-
peranza, Giustizia, Fede, Speranza, Carità) ed indi le
Scienze (Filosofia, Grammatica, Dialettica, Retorica,
Aritmetica, Geometria, Musica, Astrologia) è dedicato
nel codice un foglio che va adorno di un disegno acqua-
rellato figurante l’allegoria della Virtù o della Scienza
cantata dal poeta. Giustamente il D. riconosce nel-
l’opera del miniatore caratteri senesi e fiorentini; tut-
tavia le tre miniature de’ pianeti con le quali si chiude
il ms., e specialmente la figura di Saturno, mostrano,
ci sembra, relazioni non dubbie con l’arte dell’Italia
Superiore.
Sì delle miniature che della mediocre opera poetica
di Bartolomeo di Bartoli il D. addita con grande di-
ligenza e con acume le fonti letterarie ed artistiche,
forse non senza esagerazione quando egli tratteggia il
contrasto fra le dottrine agostiniane e le dottrine dome-
nicane circa la classificazione delle Virtù e delle Scienze:
gli affreschi domenicani della Cappella degli Spagnuoli
al raffronto con le miniature della canzone di Barto-
lomeo de Bartoli, tutta di pura ispirazione agostiniana,
dimostrano che nell’arte tale contrasto andava quasi
perduto. Infine, come fonte diretta, anzi come modello
delle miniature del ms. di Chantilly, il D. indica una
miniatura di un libro di Decretali, conservato nella
Biblioteca Ambrosiana, eseguita nel 1354 da Niccolò
da Bologna, miniatura che invero contrasta assai con
le figurazioni statuarie del disegnatore adoperato da
Bartolomeo de Bartoli. Nella miniatura che Niccolò
da Bologna inserì incidentalmente a capo del trattato
« de vita et honestate cleri » delle Decretali l’artista stipa
insieme le figure delle Virtù e delle Scienze sì da far
bene scorgere ch’esse non sono nate da una sua idea-
zione nuova ma che furono ricavate senza fatica da
un qualche modello, forse dalle illustrazioni dello stesso
trattato speciale sulle Virtù e sulle Arti liberali al quale
ricorsero Bartolomeo de Bartoli ed il suo miniatore.
Lo studio del D. acquista un’importanza anche mag-
giore quando si rivolge alla questione degli affreschi
che il fiorentino Giusto Menabuoi, detto Giusto Pado-
231
scuola di Colonia. Le tappe si succedono fin a Iacopo
Bellini, il grande maestro che dallo studio dell’antico,
dalla scuola feconda di Gentile da Fabriano, da un
felice temperamento artistico e più tardi dagli esempi
di Donatello e del Mantegna seppe derivare utili in-
segnamenti e dare un nuovo indirizzo alla pittura ve-
neziana. Del valore di Iacopo rimangono a prova i
mirabili disegni così noti agli studiosi.
Con Iacopo Bellini, fondatore della scuola vene-
ziana del Rinascimento, il M. chiude il capitolo sulle
arti belle dicendo che il « Bellini non gettò solamente
la semenza della grande pittura veneziana, ma le diede
norma, direzione, impronta che dipoi si svolsero am-
piamente, ma non si mutarono»; e noi a questa con-
clusione aderiamo di cuore.
Considerando riassuntivamente il volume del Mol-
menti, dal quale abbiamo tratto il materiale della re-
censione, crediamo che meriti lode non solo per la
vasta, ma sobria architettura dell’ insieme ; per la quan-
tità di materiali nuovi acconciamente disposti, ma più
ancora pel caldo amore che vibra in tutta l’opera e
che ci fa amare ancora di più la dolce città piena di
luce e di sogni.
* * *
Resterebbe a parlare dell’edizione, ma lo crediamo
inutile. Da tropp’anni 1’ Istituto di arti grafiche manda
alla luce splendide pubblicazioni, perchè questa bel-
lissima ci possa sorprendere. La nuova opera ebbe
cure speciali per la carta, pel formato elegante, per
darle un aspetto tipografico signorile, per la distribu-
zione armonica delle figure e per la tiratura perfetta
delle tavole colorate. Qualcuna di queste, ad esempio
la IX, riuscì un po’ sorda di toni, forse perchè l’acque-
rello che servì di base alla cromolitografia era troppo
carico di tinta. Malgrado questa e qualche altra lieve
osservazione il volume ci sembra il più riccamente e
nitidamente illustrato fra quanti vennero pubblicati re-
centemente.
Laudedeo Testi. 1
Leone Dorez: la Canzone delle Virtù e
delle Scienze di Bartolomeo di Bartoli da
Bologna. Testo inedito del secolo XJ" tratto
dal ms. originale ed illustrato. (Collezione
Novati. II). Bergamo, Istituto italiano d’arti
grafiche, 1903.
Il secondo volume della collezione nella quale il
eh. prof. Francesco Novati si è proposto di pubbli-
care illustrati, ed integralmente riprodotti in eliotipia,
codici che al valore letterario congiungano il pregio
di miniature o di disegni, ci presenta un manoscritto
1 Ci spiace di dover rimandare per deficenza di spazio al pros-
simo fascicolo la recensione del Testi sopra G. Biscaro : Note
documenti santambrosiani. (N. d. R.J.
assai importante non soltanto per l’iconografia delle
Virtù e delle Scienze nell’arte del Trecento, ma anche
perchè reca un elemento nuovo nella controversia in-
torno agli affreschi delle Virtù e delle Arti liberali
eseguiti da Giusto Menabuoi nella chiesa degli Ere-
mitani di Padova, ed intorno ai codici che da quelli
affreschi si vogliono derivati.
Lo scriba bolognese Bartolomeo di Bartoli, del
quale il Dorez ha rintracciato la firma in quattro ma-
noscritti (due di questi recano le date del 1349 e del
1374), compose la canzone che forma la parte prin-
cipale del codice e la fe’ miniare per offerirla a Fa-
brizio Visconti, forse nel 1355, quando appunto questo
già spietato tiranno di Lodi, ed insieme avido racco-
glitore di manoscritti, aveva riparato in Bologna. Ad
ognuna delle stanze che celebrano distintamente dap-
prima le Virtù (Teologia, Prudenza, Fortezza, Tem-
peranza, Giustizia, Fede, Speranza, Carità) ed indi le
Scienze (Filosofia, Grammatica, Dialettica, Retorica,
Aritmetica, Geometria, Musica, Astrologia) è dedicato
nel codice un foglio che va adorno di un disegno acqua-
rellato figurante l’allegoria della Virtù o della Scienza
cantata dal poeta. Giustamente il D. riconosce nel-
l’opera del miniatore caratteri senesi e fiorentini; tut-
tavia le tre miniature de’ pianeti con le quali si chiude
il ms., e specialmente la figura di Saturno, mostrano,
ci sembra, relazioni non dubbie con l’arte dell’Italia
Superiore.
Sì delle miniature che della mediocre opera poetica
di Bartolomeo di Bartoli il D. addita con grande di-
ligenza e con acume le fonti letterarie ed artistiche,
forse non senza esagerazione quando egli tratteggia il
contrasto fra le dottrine agostiniane e le dottrine dome-
nicane circa la classificazione delle Virtù e delle Scienze:
gli affreschi domenicani della Cappella degli Spagnuoli
al raffronto con le miniature della canzone di Barto-
lomeo de Bartoli, tutta di pura ispirazione agostiniana,
dimostrano che nell’arte tale contrasto andava quasi
perduto. Infine, come fonte diretta, anzi come modello
delle miniature del ms. di Chantilly, il D. indica una
miniatura di un libro di Decretali, conservato nella
Biblioteca Ambrosiana, eseguita nel 1354 da Niccolò
da Bologna, miniatura che invero contrasta assai con
le figurazioni statuarie del disegnatore adoperato da
Bartolomeo de Bartoli. Nella miniatura che Niccolò
da Bologna inserì incidentalmente a capo del trattato
« de vita et honestate cleri » delle Decretali l’artista stipa
insieme le figure delle Virtù e delle Scienze sì da far
bene scorgere ch’esse non sono nate da una sua idea-
zione nuova ma che furono ricavate senza fatica da
un qualche modello, forse dalle illustrazioni dello stesso
trattato speciale sulle Virtù e sulle Arti liberali al quale
ricorsero Bartolomeo de Bartoli ed il suo miniatore.
Lo studio del D. acquista un’importanza anche mag-
giore quando si rivolge alla questione degli affreschi
che il fiorentino Giusto Menabuoi, detto Giusto Pado-