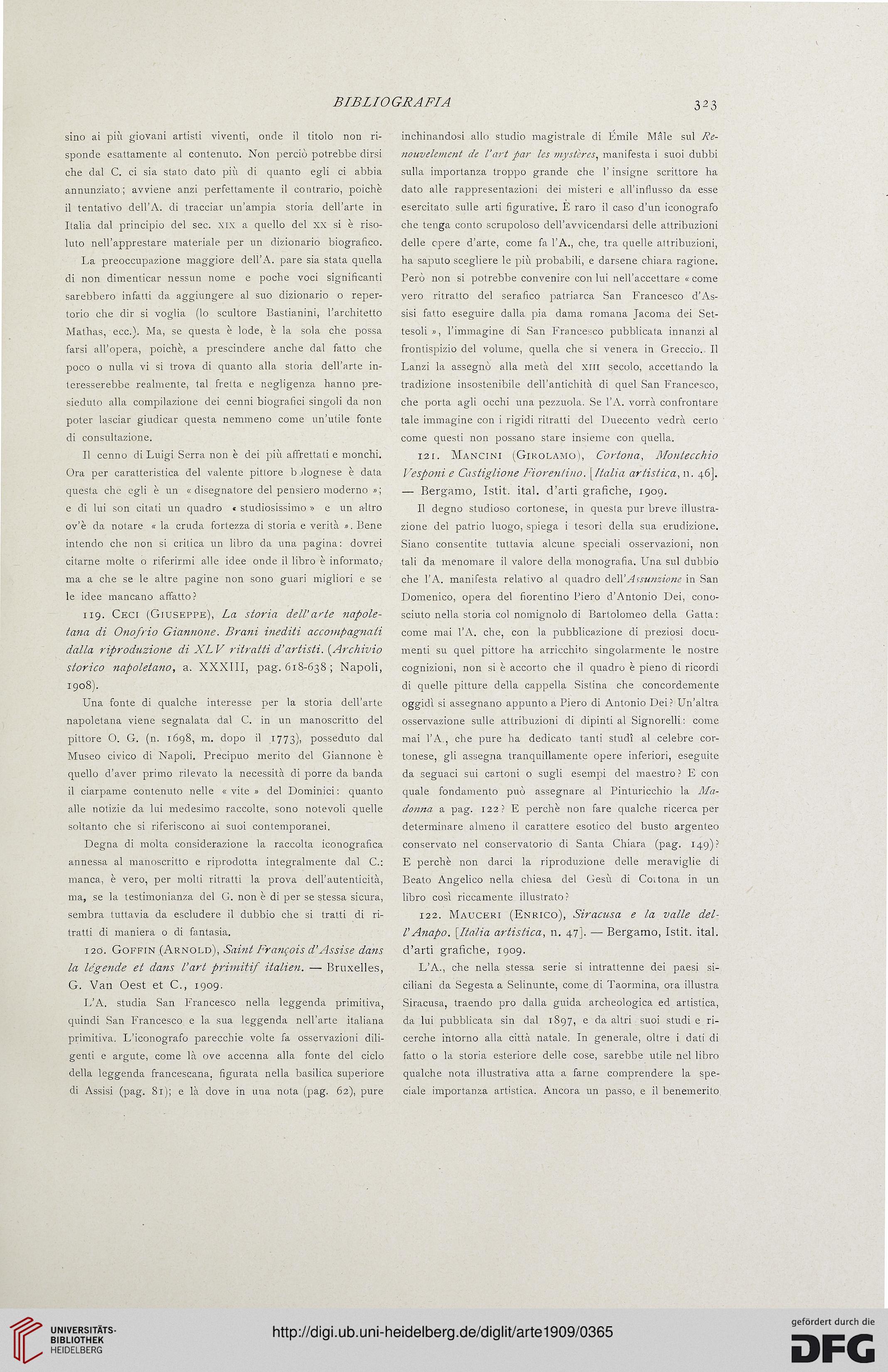BIBLIOGRAFIA
323
sino ai più giovani artisti viventi, onde il titolo non ri-
sponde esattamente al contenuto. Non perciò potrebbe dirsi
che dal C. ci sia stato dato più di quanto egli ci abbia
annunziato; avviene anzi perfettamente il contrario, poiché
il tentativo dell’A. di tracciar un’ampia storia dell’arte in
Italia dal principio del sec. xix a quello del xx si è riso-
luto nell’apprestare materiale per un dizionario biografico.
La preoccupazione maggiore dell’A. pare sia stata quella
di non dimenticar nessun nome e poche voci significanti
sarebbero infatti da aggiungere al suo dizionario o reper-
torio che dir si voglia (lo scultore Bastianini, l’architetto
Mathas, ' ecc.). Ma, se questa è lode, è la sola che possa
farsi all’opera, poiché, a prescindere anche dal fatto che
poco o nulla vi si trova di quanto alla storia dell’arte in-
teresserebbe realmente, tal fretta e negligenza hanno pre-
sieduto alla compilazione dei cenni biografici singoli da non
poter lasciar giudicar questa nemmeno come un’utile fonte
di consultazione.
Il cenno di Luigi Serra non è dei più affrettali e monchi.
Ora per caratteristica del valente pittore bolognese è data
questa che egli è un « disegnatore del pensiero moderno » ;
e di lui son citati un quadro * studiosissimo » e un altro
ov’è da notare « la cruda fortezza di storia e verità ». Bene
intendo che non si critica un libro da una pagina: dovrei
citarne molte o riferirmi alle idee onde il libro é informato,-
ma a che se le altre pagine non sono guari migliori e se
le idee mancano affatto?
119. Ceci (Giuseppe), la storia dell’arte napole-
tana di Onofrio Giannone. Brani inediti accompagnati
dalla riproduzione di XL V ritratti d’artisti. (Archivio
storico napoletano, a. XXXIII, pag. 618-638; Napoli,
1908).
Una fonte di qualche interesse per la storia dell’arte
napoletana viene segnalata dal C. in un manoscritto del
pittore O. G. (n. 1698, m. dopo il 1773), posseduto dal
Museo civico di Napoli. Precipuo merito del Giannone è
quello d’aver primo rilevato la necessità di porre da banda
il ciarpame contenuto nelle « vite » del Dominici : quanto
alle notizie da lui medesimo raccolte, sono notevoli quelle
soltanto che si riferiscono ai suoi contemporanei.
Degna di molta considerazione la raccolta iconografica
annessa al manoscritto e riprodotta integralmente dal C.:
manca, è vero, per molti ritratti la prova dell’autenticità,
ma, se la testimonianza del G. non è di per se stessa sicura,
sembra tuttavia da escludere il dubbio che si tratti di ri-
tratti di maniera o di fantasia.
120. Goffin (Arnold), Saint Francois d’Assise dans
la legende et dans l’art primìtìf ìtalìen. — Bruxelles,
G. Van Oest et C., 1909.
L’A. studia San Francesco nella leggenda primitiva,
quindi San Francesco e la sua leggenda nell’arte italiana
primitiva. L’iconografo parecchie volte fa osservazioni dili-
genti e argute, come là ove accenna alla fonte del ciclo
della leggenda francescana, figurata nella basilica superiore
di Assisi (pag. 81); e là dove in una nota (pag. 62), pure
inchinandosi allo studio magistrale di Émile Male sul Re-
nouvelement de Vart par les mysteres, manifesta i suoi dubbi
sulla importanza troppo grande che l’insigne scrittore ha
dato alle rappresentazioni dei misteri e all’influsso da esse
esercitato sulle arti figurative. E raro il caso d’un iconografo
che tenga conto scrupoloso dell’avvicendarsi delle attribuzioni
delle opere d’arte, come fa 1 ’A., che, tra quelle attribuzioni,
ha saputo scegliere le più probabili, e darsene chiara ragione.
Però non si potrebbe convenire con lui nell’accettare « come
vero ritratto del serafico patriarca San Francesco d’As-
sisi fatto eseguire dalla pia dama romana Jacoma dei Set-
tesoli», l’immagine di San Francesco pubblicata innanzi al
frontispizio del volume, quella che si venera in Greccio. Il
Lanzi la assegnò alla metà del xm secolo, accettando la
tradizione insostenibile dell’antichità di quel San Francesco,
che porta agli occhi una pezzuola. Se l’A. vorrà confrontare
tale immagine con i rigidi ritratti del Duecento vedrà certo
come questi non possano stare insieme con quella.
121. Mancini (Girolamo), Cortona, Montecchio
Vesponi e Castiglione Fiorentino. [Italia artistica, n. 46].
— Bergamo, Istit. ital. d’arti grafiche, 1909.
Il degno studioso cortonese, in questa pur breve illustra-
zione del patrio luogo, spiega i tesori della sua erudizione.
Siano consentite tuttavia alcune speciali osservazioni, non
tali da menomare il valore della monografia. Una sul dubbio
che l’A. manifesta relativo al quadro àeWAssunzione in San
Domenico, opera del fiorentino Piero d’Antonio Dei, cono-
sciuto nella storia col nomignolo di Bartolomeo della Gatta:
come mai l’A. che, con la pubblicazione di preziosi docu-
menti su quel pittore ha arricchito singolarmente le nostre
cognizioni, non si é accorto che il quadro è pieno di ricordi
di quelle pitture della cappella Sistina che concordemente
oggidì si assegnano appunto a Piero di Antonio Dei? Un’altra
osservazione sulle attribuzioni di dipinti al Signorelli : come
mai l’A., che pure ha dedicato tanti studi al celebre cor-
tonese, gli assegna tranquillamente opere inferiori, eseguite
da seguaci sui cartoni o sugli esempi del maestro? E con
quale fondamento può assegnare al Pinturicchio la Ma-
donna a pag. 122? E perchè non fare qualche ricerca per
determinare almeno il carattere esotico del busto argenteo
conservato nel conservatorio di Santa Chiara (pag. 149)?
E perchè non darci la riproduzione delle meraviglie di
Beato Angelico nella chiesa del Gesù di Cortona in un
libro così riccamente illustrato ?
122. Mauceri (Enrico), Siracusa e la valle del-
VAnapo. [Italia artistica, n. 47]. — Bergamo, Istit. ital.
d’arti grafiche, 1909.
L’A., che nella stessa serie si intrattenne dei paesi si-
ciliani da Segesta a Selinunte, come di Taormina, ora illustra
Siracusa, traendo prò dalla guida archeologica ed artistica,
da lui pubblicata sin dal 1897, e da altri suoi studi e ri-
cerche intorno alla città natale. In generale, oltre i dati di
fatto o la storia esteriore delle cose, sarebbe utile nel libro
qualche nota illustrativa atta a farne comprendere la spe-
ciale importanza artistica. Ancora un passo, e il benemerito
323
sino ai più giovani artisti viventi, onde il titolo non ri-
sponde esattamente al contenuto. Non perciò potrebbe dirsi
che dal C. ci sia stato dato più di quanto egli ci abbia
annunziato; avviene anzi perfettamente il contrario, poiché
il tentativo dell’A. di tracciar un’ampia storia dell’arte in
Italia dal principio del sec. xix a quello del xx si è riso-
luto nell’apprestare materiale per un dizionario biografico.
La preoccupazione maggiore dell’A. pare sia stata quella
di non dimenticar nessun nome e poche voci significanti
sarebbero infatti da aggiungere al suo dizionario o reper-
torio che dir si voglia (lo scultore Bastianini, l’architetto
Mathas, ' ecc.). Ma, se questa è lode, è la sola che possa
farsi all’opera, poiché, a prescindere anche dal fatto che
poco o nulla vi si trova di quanto alla storia dell’arte in-
teresserebbe realmente, tal fretta e negligenza hanno pre-
sieduto alla compilazione dei cenni biografici singoli da non
poter lasciar giudicar questa nemmeno come un’utile fonte
di consultazione.
Il cenno di Luigi Serra non è dei più affrettali e monchi.
Ora per caratteristica del valente pittore bolognese è data
questa che egli è un « disegnatore del pensiero moderno » ;
e di lui son citati un quadro * studiosissimo » e un altro
ov’è da notare « la cruda fortezza di storia e verità ». Bene
intendo che non si critica un libro da una pagina: dovrei
citarne molte o riferirmi alle idee onde il libro é informato,-
ma a che se le altre pagine non sono guari migliori e se
le idee mancano affatto?
119. Ceci (Giuseppe), la storia dell’arte napole-
tana di Onofrio Giannone. Brani inediti accompagnati
dalla riproduzione di XL V ritratti d’artisti. (Archivio
storico napoletano, a. XXXIII, pag. 618-638; Napoli,
1908).
Una fonte di qualche interesse per la storia dell’arte
napoletana viene segnalata dal C. in un manoscritto del
pittore O. G. (n. 1698, m. dopo il 1773), posseduto dal
Museo civico di Napoli. Precipuo merito del Giannone è
quello d’aver primo rilevato la necessità di porre da banda
il ciarpame contenuto nelle « vite » del Dominici : quanto
alle notizie da lui medesimo raccolte, sono notevoli quelle
soltanto che si riferiscono ai suoi contemporanei.
Degna di molta considerazione la raccolta iconografica
annessa al manoscritto e riprodotta integralmente dal C.:
manca, è vero, per molti ritratti la prova dell’autenticità,
ma, se la testimonianza del G. non è di per se stessa sicura,
sembra tuttavia da escludere il dubbio che si tratti di ri-
tratti di maniera o di fantasia.
120. Goffin (Arnold), Saint Francois d’Assise dans
la legende et dans l’art primìtìf ìtalìen. — Bruxelles,
G. Van Oest et C., 1909.
L’A. studia San Francesco nella leggenda primitiva,
quindi San Francesco e la sua leggenda nell’arte italiana
primitiva. L’iconografo parecchie volte fa osservazioni dili-
genti e argute, come là ove accenna alla fonte del ciclo
della leggenda francescana, figurata nella basilica superiore
di Assisi (pag. 81); e là dove in una nota (pag. 62), pure
inchinandosi allo studio magistrale di Émile Male sul Re-
nouvelement de Vart par les mysteres, manifesta i suoi dubbi
sulla importanza troppo grande che l’insigne scrittore ha
dato alle rappresentazioni dei misteri e all’influsso da esse
esercitato sulle arti figurative. E raro il caso d’un iconografo
che tenga conto scrupoloso dell’avvicendarsi delle attribuzioni
delle opere d’arte, come fa 1 ’A., che, tra quelle attribuzioni,
ha saputo scegliere le più probabili, e darsene chiara ragione.
Però non si potrebbe convenire con lui nell’accettare « come
vero ritratto del serafico patriarca San Francesco d’As-
sisi fatto eseguire dalla pia dama romana Jacoma dei Set-
tesoli», l’immagine di San Francesco pubblicata innanzi al
frontispizio del volume, quella che si venera in Greccio. Il
Lanzi la assegnò alla metà del xm secolo, accettando la
tradizione insostenibile dell’antichità di quel San Francesco,
che porta agli occhi una pezzuola. Se l’A. vorrà confrontare
tale immagine con i rigidi ritratti del Duecento vedrà certo
come questi non possano stare insieme con quella.
121. Mancini (Girolamo), Cortona, Montecchio
Vesponi e Castiglione Fiorentino. [Italia artistica, n. 46].
— Bergamo, Istit. ital. d’arti grafiche, 1909.
Il degno studioso cortonese, in questa pur breve illustra-
zione del patrio luogo, spiega i tesori della sua erudizione.
Siano consentite tuttavia alcune speciali osservazioni, non
tali da menomare il valore della monografia. Una sul dubbio
che l’A. manifesta relativo al quadro àeWAssunzione in San
Domenico, opera del fiorentino Piero d’Antonio Dei, cono-
sciuto nella storia col nomignolo di Bartolomeo della Gatta:
come mai l’A. che, con la pubblicazione di preziosi docu-
menti su quel pittore ha arricchito singolarmente le nostre
cognizioni, non si é accorto che il quadro è pieno di ricordi
di quelle pitture della cappella Sistina che concordemente
oggidì si assegnano appunto a Piero di Antonio Dei? Un’altra
osservazione sulle attribuzioni di dipinti al Signorelli : come
mai l’A., che pure ha dedicato tanti studi al celebre cor-
tonese, gli assegna tranquillamente opere inferiori, eseguite
da seguaci sui cartoni o sugli esempi del maestro? E con
quale fondamento può assegnare al Pinturicchio la Ma-
donna a pag. 122? E perchè non fare qualche ricerca per
determinare almeno il carattere esotico del busto argenteo
conservato nel conservatorio di Santa Chiara (pag. 149)?
E perchè non darci la riproduzione delle meraviglie di
Beato Angelico nella chiesa del Gesù di Cortona in un
libro così riccamente illustrato ?
122. Mauceri (Enrico), Siracusa e la valle del-
VAnapo. [Italia artistica, n. 47]. — Bergamo, Istit. ital.
d’arti grafiche, 1909.
L’A., che nella stessa serie si intrattenne dei paesi si-
ciliani da Segesta a Selinunte, come di Taormina, ora illustra
Siracusa, traendo prò dalla guida archeologica ed artistica,
da lui pubblicata sin dal 1897, e da altri suoi studi e ri-
cerche intorno alla città natale. In generale, oltre i dati di
fatto o la storia esteriore delle cose, sarebbe utile nel libro
qualche nota illustrativa atta a farne comprendere la spe-
ciale importanza artistica. Ancora un passo, e il benemerito