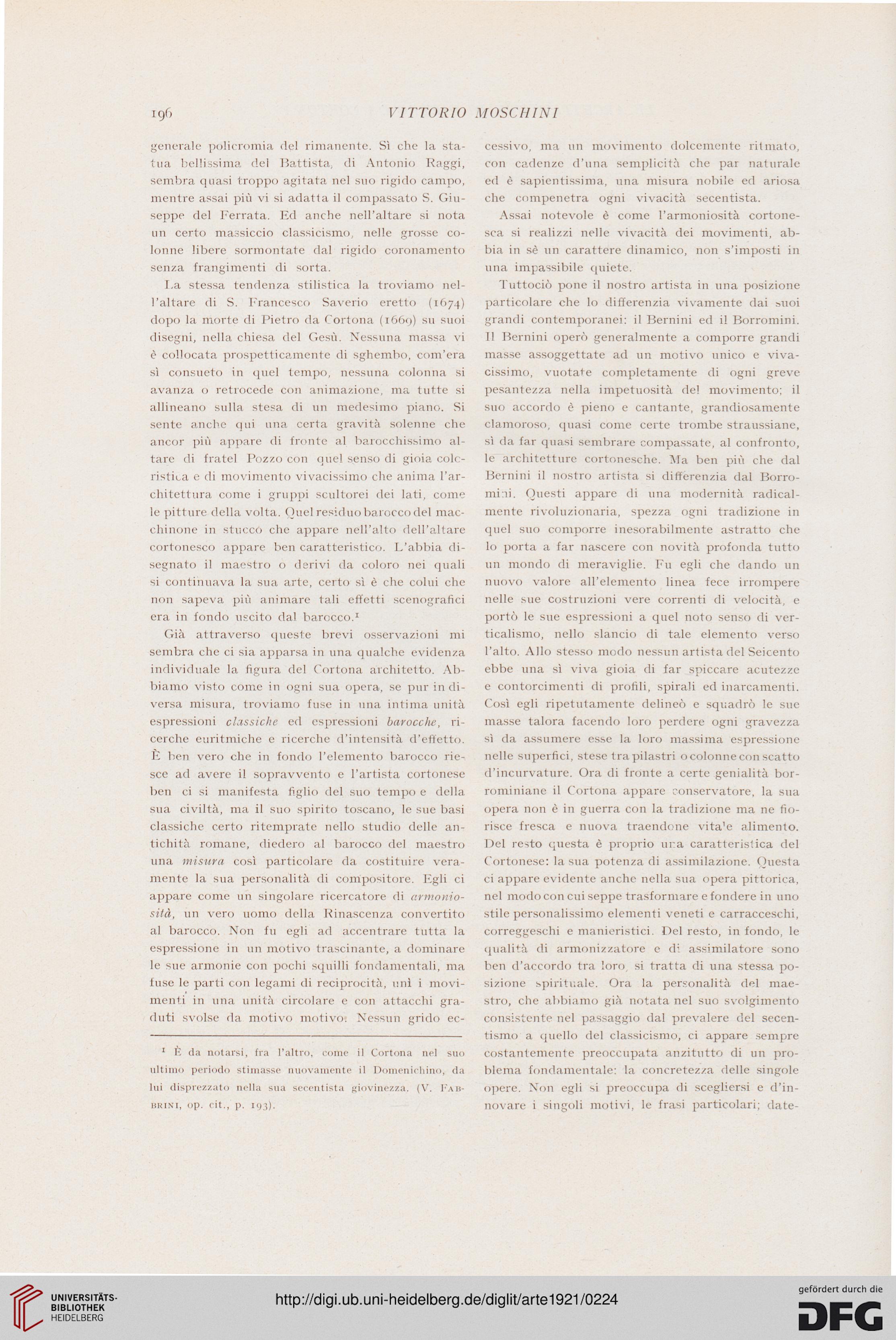VITTORIO MOS( IIIXI
generale policromia del rimanente. Sì che la sta-
tua bellissima del Battista, di Antonio Raggi,
sembra quasi troppo agitata nel suo rigido campo,
mentre assai più vi si adatta il compassato S. Giu-
seppe del Ferrata. Ed anche nell'altare si nota
un certo massiccio classicismo, nelle grosse co-
lonne libere sormontate dal rigido coronamento
senza frangimenti di sorta.
La stessa tendenza stilistica la troviamo nel-
l'altare di S. Francesco Saverio eretto (1074)
dopo la morte di Pietro da Cortona (1660) su suoi
disegni, nella chiesa del Gesù. Nessuna massa vi
è collocata prospetticamente di sghembo, com'era
sì consueto in cpiel tempo, nessuna colonna si
avanza 0 retrocede con animazione, ma tutte si
allineano sulla stesa di un medesimo piano. Si
sente anche qui una certa gravità solenne che
ancor più appare di fronte al barocchissimo al-
tare di fratel Pozzo con quel senso di gioia colc-
ristica e di movimento vivacissimo che anima l'ar-
chitettura come i gruppi scultorei dei lati, come
le pitture della volta. Quel residuo bai occo del mac-
chinone in stucco che appare nell'alto dell'altare
cortonesco appare ben caratteristico. L'abbia di-
segnato il maestro o derivi da coloro nei quali
si continuava la sua arte, certo sì è che colui che
non sapeva più animare tali effetti scenografici
era in fondo uscito dal barocco.1
Già attraverso queste brevi osservazioni mi
sembra che ci sia apparsa in una qualche evidenza
individuale la figura del Cortona architetto. Ab-
biamo visto come in ogni sua opera, se pur in di-
versa misura, troviamo fuse in una intima unità
espressioni classiche ed espressioni barocche, ri-
cerche euritmiche e ricerche d'intensità d'effetto,
li ben vero che in fondo l'elemento barocco rie-
sce ad avere il sopravvento e l'artista cortonese
ben ci si manifesta figlio del suo tempo e della
sua civiltà, ma il suo spirito toscano, le sue basi
classiche certo ritemprate nello studio delle an-
tichità romane, diedero al barocco del maestro
una misura così particolare da costituire vera-
mente la sua personalità di compositore. Kgli ci
appare come un singolare ricercatore di armonio-
sità, un vero uomo della Rinascenza convertito
al barocco. Non fu egli ad accentrare tutta la
espressione in un motivo trascinante, a dominare
le sue armonie con pochi squilli fondamentali, ma
fuse le parti con legami di reciprocità, uni i movi-
menti in una unità circolare e con attacchi gra-
duti svolse da motivo motivo. Nessun grido ec-
1 B (la notarsi, fra l'altro, come il Cortona nel suo
ultimo periodo stimasse nuovamente il Domenirhino, da
lui disprezzato nella sua secentista giovinezza. (V. I'au-
hkini, op. cit., p. 193).
cessivo, ma un movimento dolcemente ritmato,
con cadenze d'una semplicità che par naturale
ed è sapientissima, una misura nobile ed ariosa
che compenetra ogni vivacità secentista.
Assai notevole è come l'armoniosità cortone-
sca si realizzi nelle vivacità dei movimenti, ab-
bia in sè un carattere dinamico, non s'imposti in
una impassibile quiete.
Tuttociò pone il nostro artista in una posizione
particolare che lo differenzia vivamente dai suoi
grandi contemporanei: il Bernini ed il Borromini.
11 Bernini operò generalmente a comporre grandi
masse assoggettate ad un motivo unico e viva-
cissimo, vuotate completamente di ogni greve
pesantezza nella impetuosità de! movimento; il
suo accordo è pieno e cantante, grandiosamente
clamoroso, (piasi come certe trombe straussiane,
si da far quasi sembrare compassate, al confronto,
le architetture cortonesche. Ma ben più che dal
Bernini il nostro artista si differenzia dal Borro-
mini. Onesti appare di una modernità radical-
mente rivoluzionaria, spezza ogni tradizione in
quel suo comporre inesorabilmente astratto che
lo porta a far nascere con novità profonda tutto
un mondo di meraviglie. Fu egli che dando un
nuovo valore all'elemento linea fece irrompere
nelle sue costruzioni vere correnti di velocità, e
portò le sue espressioni a quel noto senso di ver-
ticalismo, nello slancio di tale elemento verso
l'alto. Allo stesso modo nessun artista del Seicento
ebbe una sì viva gioia di far spiccare acutezze
e contorcimenti di profili, spirali ed inarcamenti.
Così egli ripetutamente delineo e squadrò le sue
masse talora facendo loro perdere ogni gravezza
sì da assumere esse la loro massima espressione
nelle superfici, stese tra pilastri ocolonne con scatto
d'incurvature. Ora di fronte a certe genialità bor-
rominiane il Cortona appare conservatore, la sua
opera non è in guerra con la tradizione ma ne fio-
risce fresca e nuova traendone vita'e alimento,
liei resto questa è proprio una caratteristica del
Cortonese: la sua potenza di assimilazione. Onesta
ci appare evidente anche nella sua opera pittorica,
nel modo con cui seppe trasformare e fondere in uno
stile personalissimo elementi veneti e carracceschi,
correggeschi e manieristici. Del resto, in fondo, le
qualità di armonizzatore e di assimilatole sono
ben d'accordo tra loro si tratta di una stessa po-
sizione spirituale. Ora la personalità del mae-
stro, che abbiamo già notata nel suo svolgimento
consistente nel passaggio dal prevalere del secen-
tismo a quello del classicismo, ci appare sempre
costantemente preoccupata anzitutto di un pro-
blema fondamentale: la concretezza delle singole
Opere, Non egli si preoccupa di scegliersi e d'in-
novare i singoli motivi, le frasi particolari; date-
generale policromia del rimanente. Sì che la sta-
tua bellissima del Battista, di Antonio Raggi,
sembra quasi troppo agitata nel suo rigido campo,
mentre assai più vi si adatta il compassato S. Giu-
seppe del Ferrata. Ed anche nell'altare si nota
un certo massiccio classicismo, nelle grosse co-
lonne libere sormontate dal rigido coronamento
senza frangimenti di sorta.
La stessa tendenza stilistica la troviamo nel-
l'altare di S. Francesco Saverio eretto (1074)
dopo la morte di Pietro da Cortona (1660) su suoi
disegni, nella chiesa del Gesù. Nessuna massa vi
è collocata prospetticamente di sghembo, com'era
sì consueto in cpiel tempo, nessuna colonna si
avanza 0 retrocede con animazione, ma tutte si
allineano sulla stesa di un medesimo piano. Si
sente anche qui una certa gravità solenne che
ancor più appare di fronte al barocchissimo al-
tare di fratel Pozzo con quel senso di gioia colc-
ristica e di movimento vivacissimo che anima l'ar-
chitettura come i gruppi scultorei dei lati, come
le pitture della volta. Quel residuo bai occo del mac-
chinone in stucco che appare nell'alto dell'altare
cortonesco appare ben caratteristico. L'abbia di-
segnato il maestro o derivi da coloro nei quali
si continuava la sua arte, certo sì è che colui che
non sapeva più animare tali effetti scenografici
era in fondo uscito dal barocco.1
Già attraverso queste brevi osservazioni mi
sembra che ci sia apparsa in una qualche evidenza
individuale la figura del Cortona architetto. Ab-
biamo visto come in ogni sua opera, se pur in di-
versa misura, troviamo fuse in una intima unità
espressioni classiche ed espressioni barocche, ri-
cerche euritmiche e ricerche d'intensità d'effetto,
li ben vero che in fondo l'elemento barocco rie-
sce ad avere il sopravvento e l'artista cortonese
ben ci si manifesta figlio del suo tempo e della
sua civiltà, ma il suo spirito toscano, le sue basi
classiche certo ritemprate nello studio delle an-
tichità romane, diedero al barocco del maestro
una misura così particolare da costituire vera-
mente la sua personalità di compositore. Kgli ci
appare come un singolare ricercatore di armonio-
sità, un vero uomo della Rinascenza convertito
al barocco. Non fu egli ad accentrare tutta la
espressione in un motivo trascinante, a dominare
le sue armonie con pochi squilli fondamentali, ma
fuse le parti con legami di reciprocità, uni i movi-
menti in una unità circolare e con attacchi gra-
duti svolse da motivo motivo. Nessun grido ec-
1 B (la notarsi, fra l'altro, come il Cortona nel suo
ultimo periodo stimasse nuovamente il Domenirhino, da
lui disprezzato nella sua secentista giovinezza. (V. I'au-
hkini, op. cit., p. 193).
cessivo, ma un movimento dolcemente ritmato,
con cadenze d'una semplicità che par naturale
ed è sapientissima, una misura nobile ed ariosa
che compenetra ogni vivacità secentista.
Assai notevole è come l'armoniosità cortone-
sca si realizzi nelle vivacità dei movimenti, ab-
bia in sè un carattere dinamico, non s'imposti in
una impassibile quiete.
Tuttociò pone il nostro artista in una posizione
particolare che lo differenzia vivamente dai suoi
grandi contemporanei: il Bernini ed il Borromini.
11 Bernini operò generalmente a comporre grandi
masse assoggettate ad un motivo unico e viva-
cissimo, vuotate completamente di ogni greve
pesantezza nella impetuosità de! movimento; il
suo accordo è pieno e cantante, grandiosamente
clamoroso, (piasi come certe trombe straussiane,
si da far quasi sembrare compassate, al confronto,
le architetture cortonesche. Ma ben più che dal
Bernini il nostro artista si differenzia dal Borro-
mini. Onesti appare di una modernità radical-
mente rivoluzionaria, spezza ogni tradizione in
quel suo comporre inesorabilmente astratto che
lo porta a far nascere con novità profonda tutto
un mondo di meraviglie. Fu egli che dando un
nuovo valore all'elemento linea fece irrompere
nelle sue costruzioni vere correnti di velocità, e
portò le sue espressioni a quel noto senso di ver-
ticalismo, nello slancio di tale elemento verso
l'alto. Allo stesso modo nessun artista del Seicento
ebbe una sì viva gioia di far spiccare acutezze
e contorcimenti di profili, spirali ed inarcamenti.
Così egli ripetutamente delineo e squadrò le sue
masse talora facendo loro perdere ogni gravezza
sì da assumere esse la loro massima espressione
nelle superfici, stese tra pilastri ocolonne con scatto
d'incurvature. Ora di fronte a certe genialità bor-
rominiane il Cortona appare conservatore, la sua
opera non è in guerra con la tradizione ma ne fio-
risce fresca e nuova traendone vita'e alimento,
liei resto questa è proprio una caratteristica del
Cortonese: la sua potenza di assimilazione. Onesta
ci appare evidente anche nella sua opera pittorica,
nel modo con cui seppe trasformare e fondere in uno
stile personalissimo elementi veneti e carracceschi,
correggeschi e manieristici. Del resto, in fondo, le
qualità di armonizzatore e di assimilatole sono
ben d'accordo tra loro si tratta di una stessa po-
sizione spirituale. Ora la personalità del mae-
stro, che abbiamo già notata nel suo svolgimento
consistente nel passaggio dal prevalere del secen-
tismo a quello del classicismo, ci appare sempre
costantemente preoccupata anzitutto di un pro-
blema fondamentale: la concretezza delle singole
Opere, Non egli si preoccupa di scegliersi e d'in-
novare i singoli motivi, le frasi particolari; date-