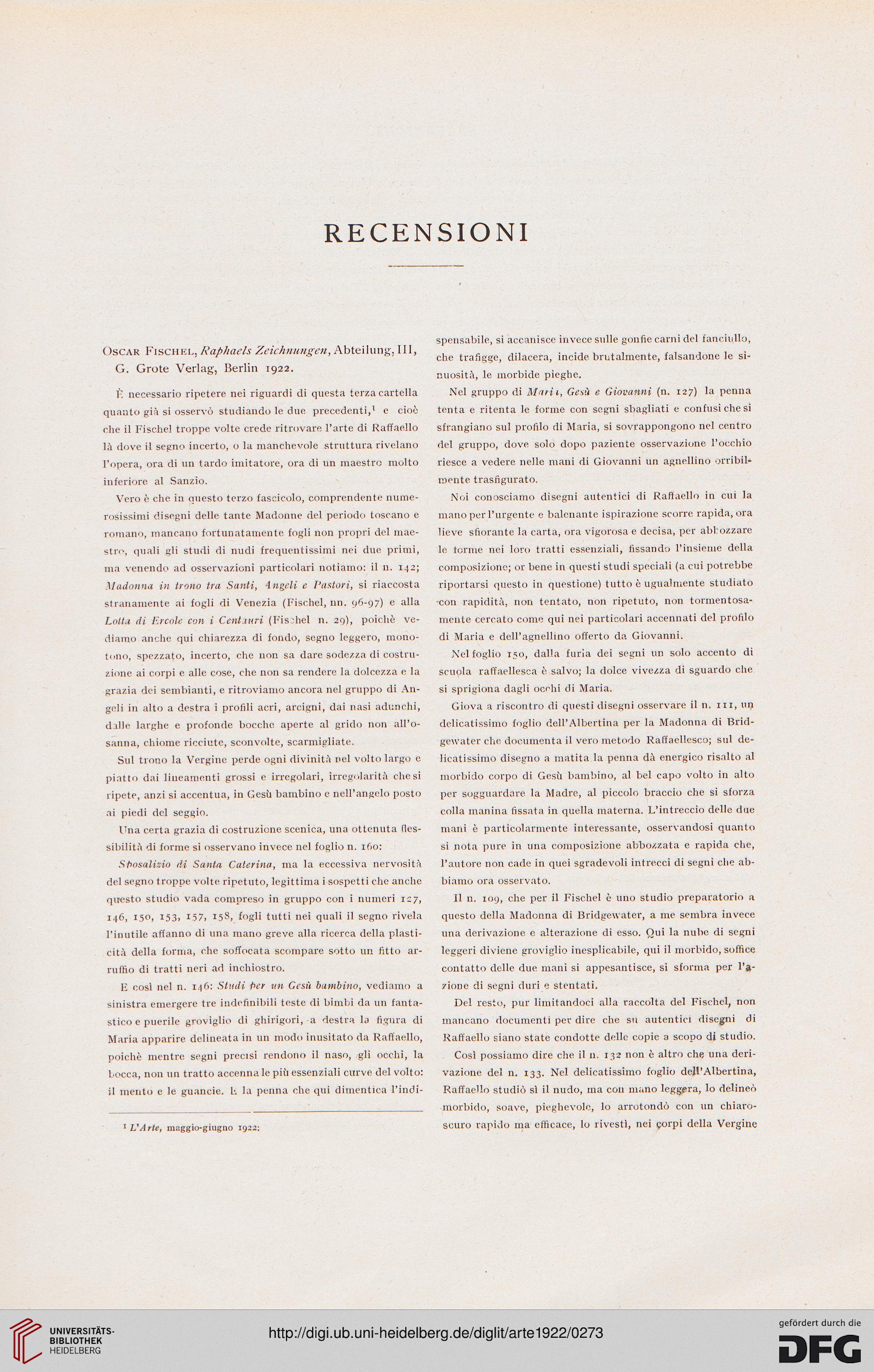RECENSIONI
( )scar Fischel, Raphacls Zeichnungen, Abteilung, III,
G. Grote Verlag, Berlin 1922.
1" necessario ripetere nei riguardi dì questa terza cartella
quanto già si osservò studiando le duo precedenti,' e cioè
che il Fischel troppe volte crede ritrovare l'arte di Raffaello
là dove il segno incerto, o la manchevole struttura rivelano
l'opera, ora di un tardo imitatore, ora di un maestro molto
inferiore al Sanzio.
Vero è che in questo terzo fascicolo, comprendente nume-
rosissimi disegni delle tante Madonne del periodo toscano e
lem,ino, main ano fortunatamente fogli non propri del mae-
stro, quali gli studi di nudi frequentissimi nei due primi,
ma venendo ad osservazioni particolari notiamo: il n. 142;
Madonna in trotto tra Santi, Angeli e l'autori, si riaccosta
stranamente ai fogli di Venezia (Fischel, un. 96-97) e alla
Lotta di Ercole con i Ccntiuri (Fishel n. 29), poiché ve-
diamo anche qui chiarezza di fondo, segno leggero, mono-
tono, spezzato, incerto, che non sa dare sodezza di costru-
zione ai corpi e alle cose, che non sa rendere la dolcezza e la
grazia dei sembianti, e ritroviamo ancora nel gruppo di An-
geli in alto a destra i profili acri, arcigni, dai nasi adunchi,
(1 die larghe e profonde bocche aperte al grido non all'o-
sanna, chiome ricciute, sconvolte, scarmigliate.
Sul trono la Vergine perde ogni divinità nel volto largo e
piatto dai lineamenti grossi e irregolari, irregolarità elicsi
ripete, anzi si accentua, in Gesù bambino e nell'angelo posto
ni piedi del seggio.
Una certa grazia di costruzione scenica, una ottenuta fles-
sibilità di forme si osservano invece nel foglio n. 160:
Sposalizio di Santa Caterina, ma la eccessiva nervosità
del segno t roppe volte ripetuto, legittima i sospetti che anche
questo studio vada compreso in gruppo con i numeri 1:7,
146, 150, 1.13. I57> 158, fogli tutti nel quali il segno rivela
l'inutile affanno di una mano greve alla ricerca della plasti-
cità della forma, che soffocata scompare sotto un fitto ar-
ruffio di tratti neri ad inchiostro.
li cosi nel n. 146: Stadi Per un Gesù bambino, vediamo a
sinistra emergere tre indefinibili teste di bimbi da un fanta-
stico e puerile groviglio di ghirigori, a destra la figura di
Maria apparire delineata in un modo inusitato da Raffaello,
poiché mentre segni precisi rendono il naso, gli occhi, la
bocca, non un tratto accenna le piii essenziali curve del volto:
il mento e le guancie. li la penna che qui dimentica l'indi-
1 L'Arte, mnggio-giugno 1922:
spensabile, si accanisce invece sulle gonfie carni del fanciullo,
che trafigge, dilacera, incide brutalmente, falsandone le si-
nuosità, le morbide pieghe.
Nel gruppo di Marii, Gesù e Giovanni (n. 127) la penna
tenta e ritenta le forme con segni sbagliati e confusi che si
sfrangiano sul profilo di Maria, si sovrappongono nel centro
del gruppo, dove solo dopo paziente osservazione l'occhio
riesce a vedere nelle mani di Giovanni un agnellino orribil-
mente trasfigurato.
Noi conosciamo disegni autentici di Raffaello in cui la
mano per l'urgente e balenante ispirazione scorre rapida, ora
lieve sfiorante la carta, ora vigorosa e decisa, per abbozzare
le torme nei Ioni tratti essenziali, fissando l'insieme della
composizione; or bene in questi studi speciali (a cui potrebbe
riportarsi questo in questione) tutto è ugualmente studiato
con rapidità, non tentato, non ripetuto, non tormentosa-
mente cercato come qui nei particolari accennati del profilo
di Maria e dell'agnellino offerto da Giovanni;
Nel foglio 150, dalla furia dei segni un solo accento di
scuola raffaellesca è salvo; la dolce vivezza di sguardo che
si sprigiona dagli occhi di Maria.
Giova a riscontro di questi disegni osservare il n. in, un
delicatissimo foglio dell'Albertina per la Madonna di Brid-
gewater die documenta il vero metodo Raffaellesco; sul de-
licatissimo disegno a matita la penna dà energico risalto al
morbido corpo di Gesù bambino, al bel capo volto in alto
per sogguardare la Madre, al piccolo braccio che si sforza
colla manina fissata in quella materna. L'intreccio delle due
mani é particolarmente interessante, osservandosi quanto
si nota pure in una composizione abbozzata e rapida che,
l'autore non cade in quei sgradevoli intrecci di segni che ab-
biamo ora osservato.
il n. 109, che per il Fischel è uno studio preparatorio a
questo della Madonna di lìridgewatcr, a me sembra invece
una derivazione e alterazione di esso. Qui la nube di segni
leggeri diviene groviglio inesplicabile, qui il morbido, soffice
contatto delle due mani si appesantisce, si sforma per l'a-
zione di segni duri e stentati.
Del resto, pur limitandoci alla raccolta del Fischel, non
mancano documenti per dire che su autentici disegni di
Raffaello siano state condotte delle copie a scopo di studio.
Cosi possiamo dire che il n. 132 non é altro che una deri-
vazione del n. 133. Nel delicatissimo foglio dell'Albertina,
Raffaello studiò si il nudo, ma con mano leggera, lo delineo
morbido, soave, pieghevole, lo arrotondò con un chiaro-
scuro rapido ma efficace, lo rivesti, nei corpi della Vergine
( )scar Fischel, Raphacls Zeichnungen, Abteilung, III,
G. Grote Verlag, Berlin 1922.
1" necessario ripetere nei riguardi dì questa terza cartella
quanto già si osservò studiando le duo precedenti,' e cioè
che il Fischel troppe volte crede ritrovare l'arte di Raffaello
là dove il segno incerto, o la manchevole struttura rivelano
l'opera, ora di un tardo imitatore, ora di un maestro molto
inferiore al Sanzio.
Vero è che in questo terzo fascicolo, comprendente nume-
rosissimi disegni delle tante Madonne del periodo toscano e
lem,ino, main ano fortunatamente fogli non propri del mae-
stro, quali gli studi di nudi frequentissimi nei due primi,
ma venendo ad osservazioni particolari notiamo: il n. 142;
Madonna in trotto tra Santi, Angeli e l'autori, si riaccosta
stranamente ai fogli di Venezia (Fischel, un. 96-97) e alla
Lotta di Ercole con i Ccntiuri (Fishel n. 29), poiché ve-
diamo anche qui chiarezza di fondo, segno leggero, mono-
tono, spezzato, incerto, che non sa dare sodezza di costru-
zione ai corpi e alle cose, che non sa rendere la dolcezza e la
grazia dei sembianti, e ritroviamo ancora nel gruppo di An-
geli in alto a destra i profili acri, arcigni, dai nasi adunchi,
(1 die larghe e profonde bocche aperte al grido non all'o-
sanna, chiome ricciute, sconvolte, scarmigliate.
Sul trono la Vergine perde ogni divinità nel volto largo e
piatto dai lineamenti grossi e irregolari, irregolarità elicsi
ripete, anzi si accentua, in Gesù bambino e nell'angelo posto
ni piedi del seggio.
Una certa grazia di costruzione scenica, una ottenuta fles-
sibilità di forme si osservano invece nel foglio n. 160:
Sposalizio di Santa Caterina, ma la eccessiva nervosità
del segno t roppe volte ripetuto, legittima i sospetti che anche
questo studio vada compreso in gruppo con i numeri 1:7,
146, 150, 1.13. I57> 158, fogli tutti nel quali il segno rivela
l'inutile affanno di una mano greve alla ricerca della plasti-
cità della forma, che soffocata scompare sotto un fitto ar-
ruffio di tratti neri ad inchiostro.
li cosi nel n. 146: Stadi Per un Gesù bambino, vediamo a
sinistra emergere tre indefinibili teste di bimbi da un fanta-
stico e puerile groviglio di ghirigori, a destra la figura di
Maria apparire delineata in un modo inusitato da Raffaello,
poiché mentre segni precisi rendono il naso, gli occhi, la
bocca, non un tratto accenna le piii essenziali curve del volto:
il mento e le guancie. li la penna che qui dimentica l'indi-
1 L'Arte, mnggio-giugno 1922:
spensabile, si accanisce invece sulle gonfie carni del fanciullo,
che trafigge, dilacera, incide brutalmente, falsandone le si-
nuosità, le morbide pieghe.
Nel gruppo di Marii, Gesù e Giovanni (n. 127) la penna
tenta e ritenta le forme con segni sbagliati e confusi che si
sfrangiano sul profilo di Maria, si sovrappongono nel centro
del gruppo, dove solo dopo paziente osservazione l'occhio
riesce a vedere nelle mani di Giovanni un agnellino orribil-
mente trasfigurato.
Noi conosciamo disegni autentici di Raffaello in cui la
mano per l'urgente e balenante ispirazione scorre rapida, ora
lieve sfiorante la carta, ora vigorosa e decisa, per abbozzare
le torme nei Ioni tratti essenziali, fissando l'insieme della
composizione; or bene in questi studi speciali (a cui potrebbe
riportarsi questo in questione) tutto è ugualmente studiato
con rapidità, non tentato, non ripetuto, non tormentosa-
mente cercato come qui nei particolari accennati del profilo
di Maria e dell'agnellino offerto da Giovanni;
Nel foglio 150, dalla furia dei segni un solo accento di
scuola raffaellesca è salvo; la dolce vivezza di sguardo che
si sprigiona dagli occhi di Maria.
Giova a riscontro di questi disegni osservare il n. in, un
delicatissimo foglio dell'Albertina per la Madonna di Brid-
gewater die documenta il vero metodo Raffaellesco; sul de-
licatissimo disegno a matita la penna dà energico risalto al
morbido corpo di Gesù bambino, al bel capo volto in alto
per sogguardare la Madre, al piccolo braccio che si sforza
colla manina fissata in quella materna. L'intreccio delle due
mani é particolarmente interessante, osservandosi quanto
si nota pure in una composizione abbozzata e rapida che,
l'autore non cade in quei sgradevoli intrecci di segni che ab-
biamo ora osservato.
il n. 109, che per il Fischel è uno studio preparatorio a
questo della Madonna di lìridgewatcr, a me sembra invece
una derivazione e alterazione di esso. Qui la nube di segni
leggeri diviene groviglio inesplicabile, qui il morbido, soffice
contatto delle due mani si appesantisce, si sforma per l'a-
zione di segni duri e stentati.
Del resto, pur limitandoci alla raccolta del Fischel, non
mancano documenti per dire che su autentici disegni di
Raffaello siano state condotte delle copie a scopo di studio.
Cosi possiamo dire che il n. 132 non é altro che una deri-
vazione del n. 133. Nel delicatissimo foglio dell'Albertina,
Raffaello studiò si il nudo, ma con mano leggera, lo delineo
morbido, soave, pieghevole, lo arrotondò con un chiaro-
scuro rapido ma efficace, lo rivesti, nei corpi della Vergine