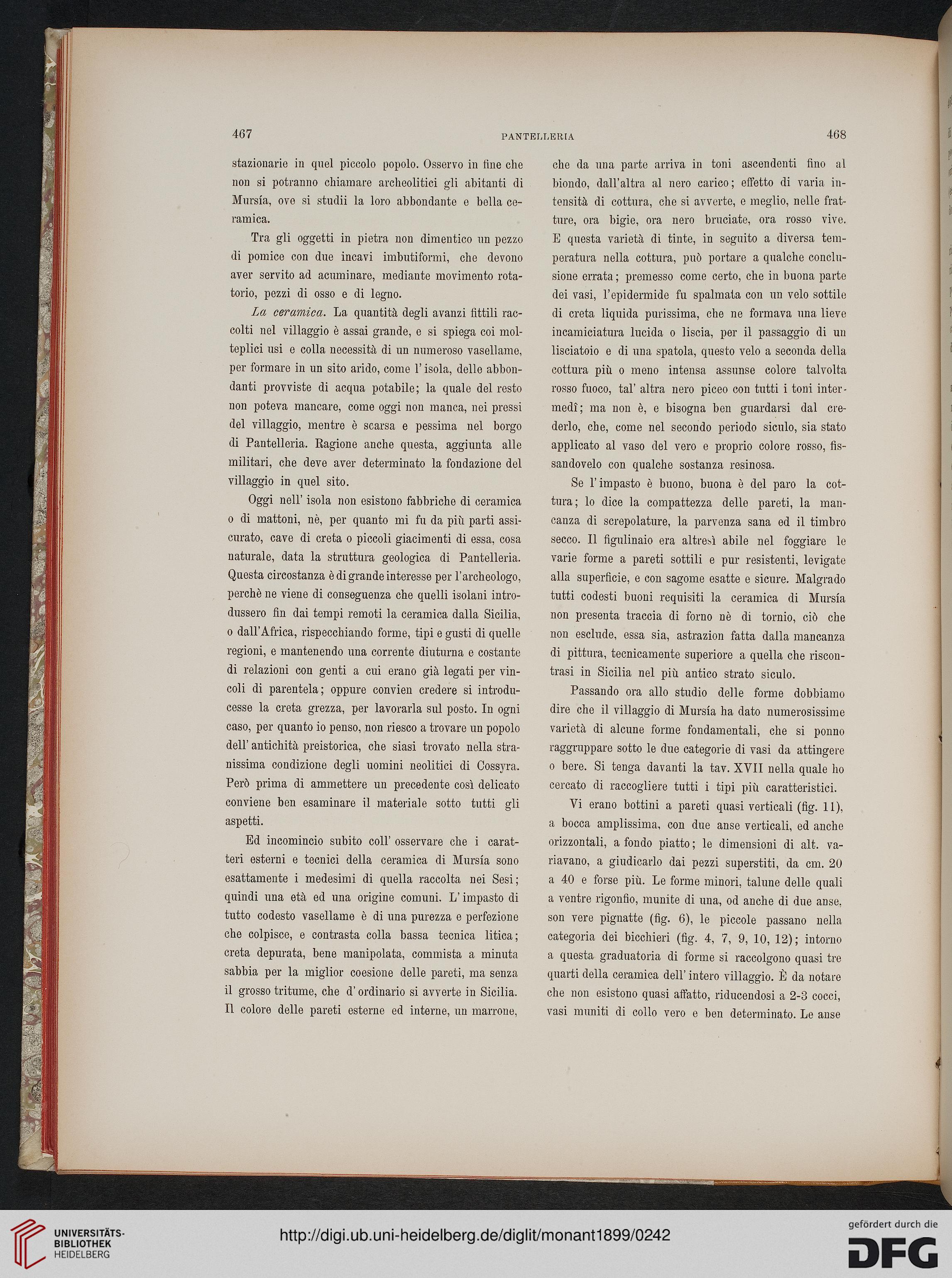467
PANTELLERIA
468
stazionarie in quel piccolo popolo. Osservo in tìne che
non si potranno chiamare archeolitici gli abitanti di
Mursia, ove si studii la loro abbondante e bolla ce-
ramica.
Tra gli oggetti in pietra non dimentico un pezzo
di pomice con due incavi imbutiformi, che devono
aver servito ad acuminare, mediante movimento rota-
torio, pezzi di osso e di legno.
La ceramica. La quantità degli avanzi fittili rac-
colti nel villaggio è assai grande, e si spiega coi mol-
teplici usi e colla necessità di un numeroso vasellame,
per formare in un sito arido, come l'isola, dello abbon-
danti provviste di acqua potabile; la quale del resto
non poteva mancare, come oggi non manca, nei pressi
del villaggio, mentre è scarsa e pessima nel borgo
di Pantelleria. Ragione anche questa, aggiunta alle
militari, che deve aver determinato la fondazione del
villaggio in quel sito.
Oggi nell' isola non esistono fabbriche di ceramica
o di mattoni, nè, per quanto mi fu da più parti assi-
curato, cave di creta o piccoli giacimenti di essa, cosa
naturale, data la struttura geologica di Pantelleria.
Questa circostanza è di grande interesse per l'archeologo,
perchè ne viene di conseguenza che quelli isolani intro-
dussero fin dai tempi remoti la ceramica dalla Sicilia,
o dall'Africa, rispecchiando forme, tipi e gusti di quelle
regioni, e mantenendo una corrente diuturna e costante
di relazioni con genti a cui erano già legati per vin-
coli di parentela; oppure convien credere si introdu-
cesse la creta grezza, per lavorarla sul posto. In ogni
caso, per quanto io penso, non riesco a trovare un popolo
dell' antichità preistorica, che siasi trovato nella stra-
nissima condizione degli uomini neolitici di Cossyra.
Però prima di ammettere un precedente così delicato
conviene ben esaminare il materiale sotto tutti gli
aspetti.
Ed incomincio subito coli' osservare che i carat-
teri esterni e tecnici della ceramica di Mursia sono
esattamente i medesimi di quella raccolta nei Sesi;
quindi una età ed una origine comuni. L'impasto di
tutto codesto vasellame è di una purezza e perfezione
che colpisce, e contrasta colla bassa tecnica litica;
creta depurata, bene manipolata, commista a minuta
sabbia per la miglior coesione delle pareti, ma senza
il grosso tritume, che d'ordinario si avverte in Sicilia.
Il colore delle pareti esterne ed interne, un marrone,
che da una parte arriva in toni ascendenti fino al
biondo, dall'altra al nero carico; effetto di varia in-
tensità di cottura, che si avverto, e meglio, nelle frat-
ture, ora bigie, ora nero bruciate, ora rosso vive.
E questa varietà di tinte, in seguito a diversa tem-
peratura nella cottura, può portare a qualche conclu-
sione errata ; premesso come certo, che in buona parte
dei vasi, l'epidermide fu spalmata con un velo sottile
di creta liquida purissima, che ne formava una lieve
incamiciatura lucida o liscia, per il passaggio di un
lisciatoio e di una spatola, questo velo a seconda della
cottura più o meno intensa assunse colore talvolta
rosso fuoco, tal' altra nero piceo con tutti i toni inter-
medi; ma non è, e bisogna ben guardarsi dal cre-
derlo, che, come nel secondo periodo siculo, sia stato
applicato al vaso del vero e proprio colore rosso, fis-
sandovelo con qualche sostanza resinosa.
Se l'impasto è buono, buona è del paro la cot-
tura; lo dice la compattezza delle pareti, la man-
canza di screpolature, la parvenza sana ed il timbro
secco. Il figulinaio era altresì abile nel foggiare le
varie forme a pareti sottili e pur resistenti, levigate
alla superficie, e con sagome esatte e sicure. Malgrado
tutti codesti buoni requisiti la ceramica di Mursia
non presenta traccia di forno nè di tornio, ciò che
non esclude, essa sia, astrazion fatta dalla mancanza
di pittura, tecnicamente superiore a quella che riscon-
trasi in Sicilia nel più antico strato siculo.
Passando ora allo studio delle forme dobbiamo
dire che il villaggio di Mursia ha dato numerosissime
varietà di alcune forme fondamentali, che si ponno
raggruppare sotto le due categorie di vasi da attingere
o bere. Si tenga davanti la tav. XVII nella quale ho
cercato di raccogliere tutti i tipi più caratteristici.
Vi erano bottini a pareti quasi verticali (fig. 11),
a bocca amplissima, con due anse verticali, ed anche
orizzontali, a fondo piatto ; le dimensioni di alt. va-
riavano, a giudicarlo dai pezzi superstiti, da cm. 20
a 40 e forse più. Le forme minori, talune delle quali
a ventre rigonfio, munite di una, od anche di due anse,
son vere pignatte (fig. 6), le piccole passano nella
categoria dei bicchieri (fig. 4, 7, 9, 10, 12); intorno
a questa graduatoria di forme si raccolgono quasi tre
quarti della ceramica dell' intero villaggio. È da notare
che non esistono quasi affatto, riducendosi a 2-3 cocci,
vasi muniti di collo vero e ben determinato. Le ause
PANTELLERIA
468
stazionarie in quel piccolo popolo. Osservo in tìne che
non si potranno chiamare archeolitici gli abitanti di
Mursia, ove si studii la loro abbondante e bolla ce-
ramica.
Tra gli oggetti in pietra non dimentico un pezzo
di pomice con due incavi imbutiformi, che devono
aver servito ad acuminare, mediante movimento rota-
torio, pezzi di osso e di legno.
La ceramica. La quantità degli avanzi fittili rac-
colti nel villaggio è assai grande, e si spiega coi mol-
teplici usi e colla necessità di un numeroso vasellame,
per formare in un sito arido, come l'isola, dello abbon-
danti provviste di acqua potabile; la quale del resto
non poteva mancare, come oggi non manca, nei pressi
del villaggio, mentre è scarsa e pessima nel borgo
di Pantelleria. Ragione anche questa, aggiunta alle
militari, che deve aver determinato la fondazione del
villaggio in quel sito.
Oggi nell' isola non esistono fabbriche di ceramica
o di mattoni, nè, per quanto mi fu da più parti assi-
curato, cave di creta o piccoli giacimenti di essa, cosa
naturale, data la struttura geologica di Pantelleria.
Questa circostanza è di grande interesse per l'archeologo,
perchè ne viene di conseguenza che quelli isolani intro-
dussero fin dai tempi remoti la ceramica dalla Sicilia,
o dall'Africa, rispecchiando forme, tipi e gusti di quelle
regioni, e mantenendo una corrente diuturna e costante
di relazioni con genti a cui erano già legati per vin-
coli di parentela; oppure convien credere si introdu-
cesse la creta grezza, per lavorarla sul posto. In ogni
caso, per quanto io penso, non riesco a trovare un popolo
dell' antichità preistorica, che siasi trovato nella stra-
nissima condizione degli uomini neolitici di Cossyra.
Però prima di ammettere un precedente così delicato
conviene ben esaminare il materiale sotto tutti gli
aspetti.
Ed incomincio subito coli' osservare che i carat-
teri esterni e tecnici della ceramica di Mursia sono
esattamente i medesimi di quella raccolta nei Sesi;
quindi una età ed una origine comuni. L'impasto di
tutto codesto vasellame è di una purezza e perfezione
che colpisce, e contrasta colla bassa tecnica litica;
creta depurata, bene manipolata, commista a minuta
sabbia per la miglior coesione delle pareti, ma senza
il grosso tritume, che d'ordinario si avverte in Sicilia.
Il colore delle pareti esterne ed interne, un marrone,
che da una parte arriva in toni ascendenti fino al
biondo, dall'altra al nero carico; effetto di varia in-
tensità di cottura, che si avverto, e meglio, nelle frat-
ture, ora bigie, ora nero bruciate, ora rosso vive.
E questa varietà di tinte, in seguito a diversa tem-
peratura nella cottura, può portare a qualche conclu-
sione errata ; premesso come certo, che in buona parte
dei vasi, l'epidermide fu spalmata con un velo sottile
di creta liquida purissima, che ne formava una lieve
incamiciatura lucida o liscia, per il passaggio di un
lisciatoio e di una spatola, questo velo a seconda della
cottura più o meno intensa assunse colore talvolta
rosso fuoco, tal' altra nero piceo con tutti i toni inter-
medi; ma non è, e bisogna ben guardarsi dal cre-
derlo, che, come nel secondo periodo siculo, sia stato
applicato al vaso del vero e proprio colore rosso, fis-
sandovelo con qualche sostanza resinosa.
Se l'impasto è buono, buona è del paro la cot-
tura; lo dice la compattezza delle pareti, la man-
canza di screpolature, la parvenza sana ed il timbro
secco. Il figulinaio era altresì abile nel foggiare le
varie forme a pareti sottili e pur resistenti, levigate
alla superficie, e con sagome esatte e sicure. Malgrado
tutti codesti buoni requisiti la ceramica di Mursia
non presenta traccia di forno nè di tornio, ciò che
non esclude, essa sia, astrazion fatta dalla mancanza
di pittura, tecnicamente superiore a quella che riscon-
trasi in Sicilia nel più antico strato siculo.
Passando ora allo studio delle forme dobbiamo
dire che il villaggio di Mursia ha dato numerosissime
varietà di alcune forme fondamentali, che si ponno
raggruppare sotto le due categorie di vasi da attingere
o bere. Si tenga davanti la tav. XVII nella quale ho
cercato di raccogliere tutti i tipi più caratteristici.
Vi erano bottini a pareti quasi verticali (fig. 11),
a bocca amplissima, con due anse verticali, ed anche
orizzontali, a fondo piatto ; le dimensioni di alt. va-
riavano, a giudicarlo dai pezzi superstiti, da cm. 20
a 40 e forse più. Le forme minori, talune delle quali
a ventre rigonfio, munite di una, od anche di due anse,
son vere pignatte (fig. 6), le piccole passano nella
categoria dei bicchieri (fig. 4, 7, 9, 10, 12); intorno
a questa graduatoria di forme si raccolgono quasi tre
quarti della ceramica dell' intero villaggio. È da notare
che non esistono quasi affatto, riducendosi a 2-3 cocci,
vasi muniti di collo vero e ben determinato. Le ause