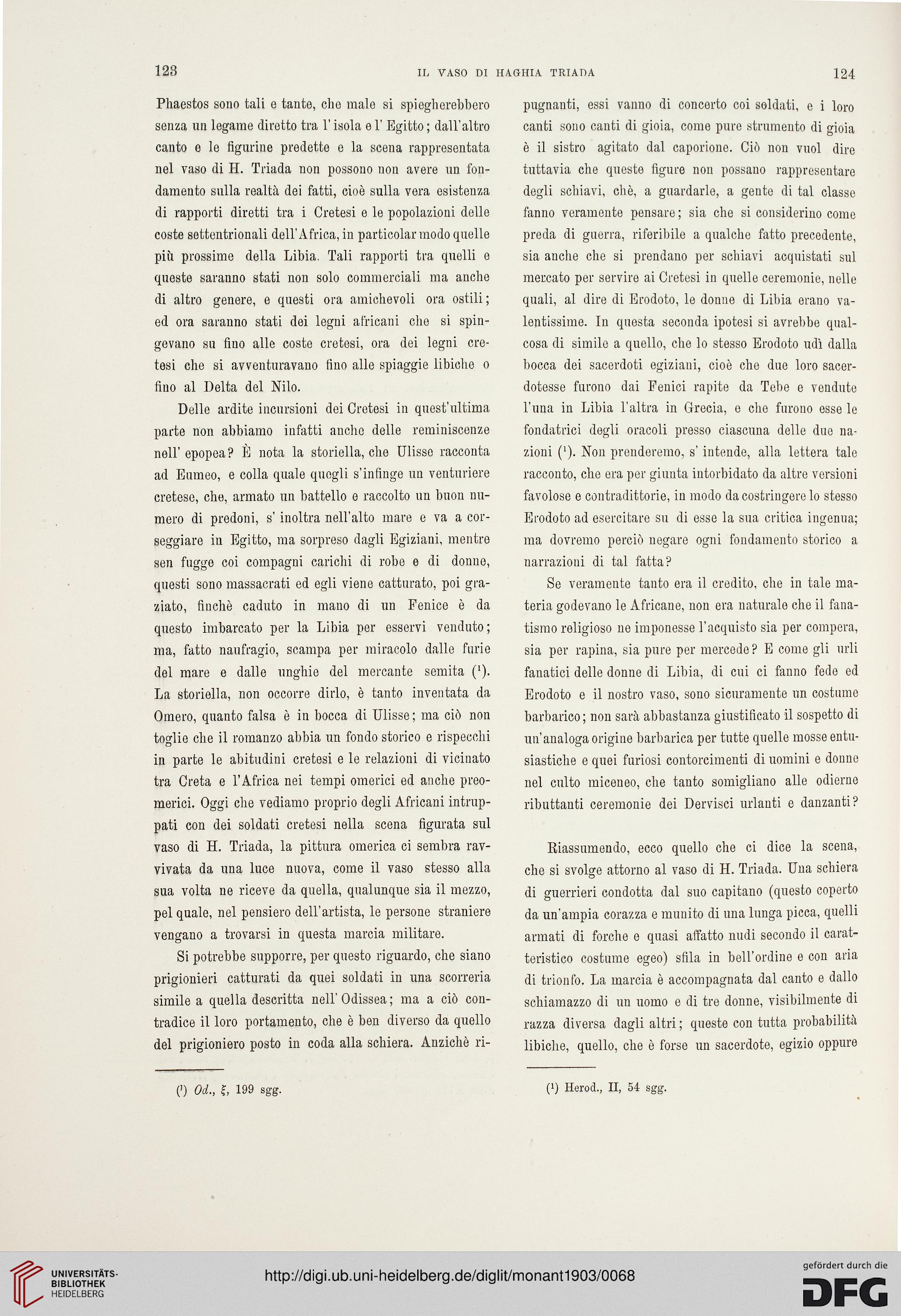123 IL VASO DI
Phaestos sono tali e tante, che male si spiegherebbero
senza un legame diretto tra l'isola e l' Egitto ; dall'altro
canto e le figurine predette e la scena rappresentata
nel vaso di H. Triada non possono non avere un fon-
damento galla realtà dei fatti, cioè sulla vera esistenza
di rapporti diretti tra i Cretesi e le popolazioni delle
coste settentrionali dell'Africa, in particolar modo quelle
più prossime della Libia. Tali rapporti tra quelli e
queste saranno stati non solo commerciali ma anche
di altro genere, e questi ora amichevoli ora ostili ;
ed ora saranno stati dei legni africani elio si spin-
gevano su fino alle coste cretesi, ora dei legni cre-
tesi che si avventuravano fino alle spiaggie libiche o
fino al Delta del Nilo.
Delle ardite incursioni dei Cretesi in quest'ultima
parte non abbiamo infatti anche delle reminiscenze
nell'epopea? È nota la storiella, che Ulisse racconta
ad Eumeo, e colla quale quegli s'infinge un venturiere
cretese, che, armato un battello e raccolto un buon nu-
mero di predoni, s' inoltra nell'alto mare e va a cor-
seggiare in Egitto, ma sorpreso dagli Egiziani, mentre
sen fugge coi compagni carichi di robe e di donno,
questi sono massacrati ed egli viene catturato, poi gra-
ziato, finche caduto in mano di un Fenice è da
questo imbarcato per la Libia per esservi venduto;
ma, fatto naufragio, scampa per miracolo dalle furie
del mare e dalle unghie del mercante semita (')•
La storiella, non occorre dirlo, è tanto inventata da
Omero, quanto falsa è in bocca di Ulisse ; ma ciò non
toglie che il romanzo abbia un fondo storico e rispecchi
in parte le abitudini cretesi e le relazioni di vicinato
tra Creta e l'Africa nei tempi omerici ed anche preo-
merici. Oggi che vediamo proprio degli Africani intrup-
pati con dei soldati cretesi nella scena figurata sul
vaso di H. Triada, la pittura omerica ci sembra rav-
vivata da una luce nuova, come il vaso stesso alla
sua volta ne riceve da quella, qualunque sia il mezzo,
pel quale, nel pensiero dell'artista, le persone straniere
vengano a trovarsi in questa marcia militare.
Si potrebbe supporre, per questo riguardo, che siano
prigionieri catturati da quei soldati in una scorreria
simile a quella descritta nell' Odissea ; ma a ciò con-
tradice il loro portamento, che è ben diverso da quello
del prigioniero posto in coda alla schiera. Anziché ri-
(') Od., l, 199 sgg.
HAGHIA TRIADA 124
pugnanti, essi vanno di concerto coi soldati, e i loro
canti sono canti di gioia, come pure strumento di gioia
è il gistro agitato dal caporione. Ciò non vuol dire
tuttavia che queste figure non possano rappresentare
degli schiavi, ohe, a guardarle, a gente di tal classe
fanno veramente pensare ; sia che si considerino come
preda di guerra, riferibile a qualche fatto precedente,
sia anche che si prendano per schiavi acquistati sul
mercato per servire ai Cretesi in quelle ceremonie, nelle
quali, al dire di Erodoto, le donne di Libia erano va-
lentissime. In questa seconda ipotesi si avrebbe qual-
cosa di simile a quello, che lo stesso Erodoto udì dalla
bocca dei sacerdoti egiziani, cioè che due loro sacer-
dotesse furono dai Penici rapite da Tebe e vendute
l'una in Libia l'altra in Grecia, e che furono esse le
fondatrici degli oracoli presso ciascuna delle due na-
zioni ('). Non prenderemo, s'intende, alla lettera tale
racconto, che era per giunta intorbidato da altre versioni
favolose e contradittorie, in modo da costringere lo stesso
Erodoto ad esercitare su di esse la sua critica ingenua;
ma dovremo perciò negare ogni fondamento storico a
narrazioni di tal fatta?
Se veramente tanto era il credito, che in tale ma-
teria godevano le Africane, non era naturale che il fana-
tismo religioso ne imponesse l'acquisto sia per compera,
sia per rapina, sia pure per mercede? E come gli urli
fanatici delle donne di Libia, di cui ci fanno fede ed
Erodoto e il nostro vaso, sono sicuramente un costume
barbarico ; non sarà abbastanza giustificato il sospetto di
un'analoga origine barbarica per tutte quelle mosse entu-
siastiche e quei furiosi contorcimenti di uomini e donne
nel culto miceneo, che tanto somigliano alle odierno
ributtanti ceremonie dei Dervisci urlanti e danzanti?
Riassumendo, ecco quello che ci dice la scena,
che si svolge attorno al vaso di H. Triada. Una schiera
di guerrieri condotta dal suo capitano (questo coperto
da un'ampia corazza e munito di una lunga picca, quelli
armati di forche e quasi affatto nudi secondo il carat-
teristico costume egeo) sfila in bell'ordine e con aria
di trionfo. La marcia è accompagnata dal canto e dallo
schiamazzo di un uomo e di tre donne, visibilmente di
razza diversa dagli altri ; queste con tutta probabilità
libiche, quello, che è forse un sacerdote, egizio oppure
(i) Herod., II, 54 sgg.
Phaestos sono tali e tante, che male si spiegherebbero
senza un legame diretto tra l'isola e l' Egitto ; dall'altro
canto e le figurine predette e la scena rappresentata
nel vaso di H. Triada non possono non avere un fon-
damento galla realtà dei fatti, cioè sulla vera esistenza
di rapporti diretti tra i Cretesi e le popolazioni delle
coste settentrionali dell'Africa, in particolar modo quelle
più prossime della Libia. Tali rapporti tra quelli e
queste saranno stati non solo commerciali ma anche
di altro genere, e questi ora amichevoli ora ostili ;
ed ora saranno stati dei legni africani elio si spin-
gevano su fino alle coste cretesi, ora dei legni cre-
tesi che si avventuravano fino alle spiaggie libiche o
fino al Delta del Nilo.
Delle ardite incursioni dei Cretesi in quest'ultima
parte non abbiamo infatti anche delle reminiscenze
nell'epopea? È nota la storiella, che Ulisse racconta
ad Eumeo, e colla quale quegli s'infinge un venturiere
cretese, che, armato un battello e raccolto un buon nu-
mero di predoni, s' inoltra nell'alto mare e va a cor-
seggiare in Egitto, ma sorpreso dagli Egiziani, mentre
sen fugge coi compagni carichi di robe e di donno,
questi sono massacrati ed egli viene catturato, poi gra-
ziato, finche caduto in mano di un Fenice è da
questo imbarcato per la Libia per esservi venduto;
ma, fatto naufragio, scampa per miracolo dalle furie
del mare e dalle unghie del mercante semita (')•
La storiella, non occorre dirlo, è tanto inventata da
Omero, quanto falsa è in bocca di Ulisse ; ma ciò non
toglie che il romanzo abbia un fondo storico e rispecchi
in parte le abitudini cretesi e le relazioni di vicinato
tra Creta e l'Africa nei tempi omerici ed anche preo-
merici. Oggi che vediamo proprio degli Africani intrup-
pati con dei soldati cretesi nella scena figurata sul
vaso di H. Triada, la pittura omerica ci sembra rav-
vivata da una luce nuova, come il vaso stesso alla
sua volta ne riceve da quella, qualunque sia il mezzo,
pel quale, nel pensiero dell'artista, le persone straniere
vengano a trovarsi in questa marcia militare.
Si potrebbe supporre, per questo riguardo, che siano
prigionieri catturati da quei soldati in una scorreria
simile a quella descritta nell' Odissea ; ma a ciò con-
tradice il loro portamento, che è ben diverso da quello
del prigioniero posto in coda alla schiera. Anziché ri-
(') Od., l, 199 sgg.
HAGHIA TRIADA 124
pugnanti, essi vanno di concerto coi soldati, e i loro
canti sono canti di gioia, come pure strumento di gioia
è il gistro agitato dal caporione. Ciò non vuol dire
tuttavia che queste figure non possano rappresentare
degli schiavi, ohe, a guardarle, a gente di tal classe
fanno veramente pensare ; sia che si considerino come
preda di guerra, riferibile a qualche fatto precedente,
sia anche che si prendano per schiavi acquistati sul
mercato per servire ai Cretesi in quelle ceremonie, nelle
quali, al dire di Erodoto, le donne di Libia erano va-
lentissime. In questa seconda ipotesi si avrebbe qual-
cosa di simile a quello, che lo stesso Erodoto udì dalla
bocca dei sacerdoti egiziani, cioè che due loro sacer-
dotesse furono dai Penici rapite da Tebe e vendute
l'una in Libia l'altra in Grecia, e che furono esse le
fondatrici degli oracoli presso ciascuna delle due na-
zioni ('). Non prenderemo, s'intende, alla lettera tale
racconto, che era per giunta intorbidato da altre versioni
favolose e contradittorie, in modo da costringere lo stesso
Erodoto ad esercitare su di esse la sua critica ingenua;
ma dovremo perciò negare ogni fondamento storico a
narrazioni di tal fatta?
Se veramente tanto era il credito, che in tale ma-
teria godevano le Africane, non era naturale che il fana-
tismo religioso ne imponesse l'acquisto sia per compera,
sia per rapina, sia pure per mercede? E come gli urli
fanatici delle donne di Libia, di cui ci fanno fede ed
Erodoto e il nostro vaso, sono sicuramente un costume
barbarico ; non sarà abbastanza giustificato il sospetto di
un'analoga origine barbarica per tutte quelle mosse entu-
siastiche e quei furiosi contorcimenti di uomini e donne
nel culto miceneo, che tanto somigliano alle odierno
ributtanti ceremonie dei Dervisci urlanti e danzanti?
Riassumendo, ecco quello che ci dice la scena,
che si svolge attorno al vaso di H. Triada. Una schiera
di guerrieri condotta dal suo capitano (questo coperto
da un'ampia corazza e munito di una lunga picca, quelli
armati di forche e quasi affatto nudi secondo il carat-
teristico costume egeo) sfila in bell'ordine e con aria
di trionfo. La marcia è accompagnata dal canto e dallo
schiamazzo di un uomo e di tre donne, visibilmente di
razza diversa dagli altri ; queste con tutta probabilità
libiche, quello, che è forse un sacerdote, egizio oppure
(i) Herod., II, 54 sgg.