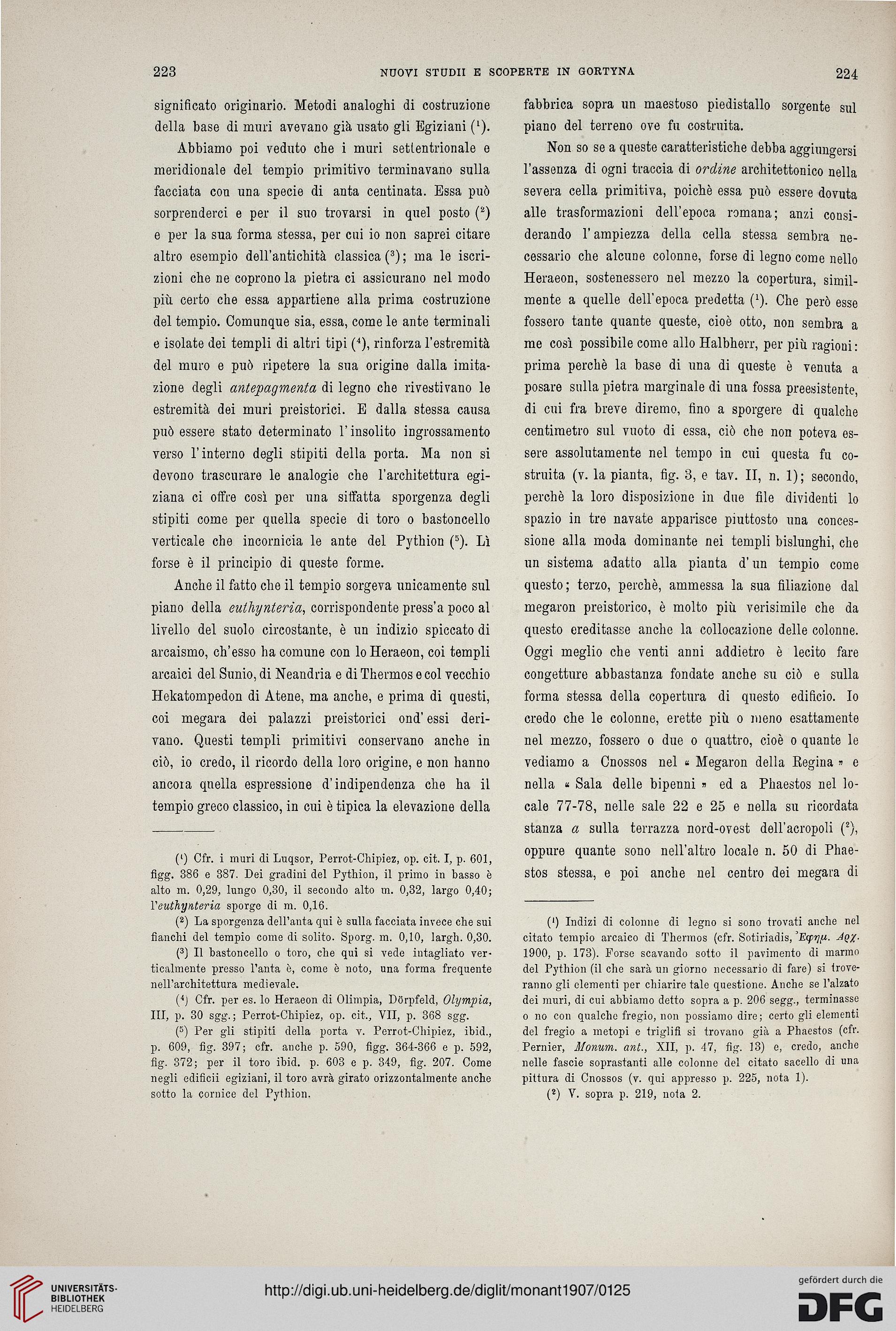223
NUOVI STUDII E SCOPERTE IN GORTYNA
224
significato originario. Metodi analoghi di costruzione
della base di muri avevano già usato gli Egiziani (').
Abbiamo poi veduto che i muri settentrionale e
meridionale del tempio primitivo terminavano sulla
facciata con una specie di anta centinata. Essa può
sorprenderci e per il suo trovarsi in quel posto (2)
e per la sua forma stessa, per cui io non saprei citare
altro esempio dell'antichità classica (3) ; ma le iscri-
zioni che ne coprono la pietra ci assicurano nel modo
più certo che essa appartiene alla prima costruzione
del tempio. Comunque sia, essa, come le ante terminali
e isolate dei templi di altri tipi (4), rinforza l'estremità
del muro e può ripetere la sua origine dalla imita-
zione degli antepagmenta di legno che rivestivano le
estremità dei muri preistorici. E dalla stessa causa
può essere stato determinato l'insolito ingrossamento
verso l'interno degli stipiti della porta. Ma non si
devono trascurare le analogie che l'architettura egi-
ziana ci offre così per una siffatta sporgenza degli
stipiti come per quella specie di toro o bastoncello
verticale che incornicia le ante del Pythion (5). Lì
forse è il principio di queste forme.
Anche il fatto che il tempio sorgeva unicamente sul
piano della euthynteria, corrispondente press'a poco al
livello del suolo circostante, è un indizio spiccato di
arcaismo, ch'esso ha comune con lo Heraeon, coi templi
arcaici del Sunio, di Neandria e di Thermos e col vecchio
Hekatompedon di Atene, ma anche, e prima di questi,
coi megara dei palazzi preistorici ond' essi deri-
vano. Questi templi primitivi conservano anche in
ciò, io credo, il ricordo della loro origine, e non hanno
ancoia quella espressione d'indipendenza che ha il
tempio greco classico, in cui è tipica la elevazione della
(') Cfr. i muri di Luqsor, Perrot-Chipiez, op. cit. I, p. 601,
fìgg. 386 e 387. Dei gradini del Pythion, il primo in basso è
alto m. 0,29, lungo 0,30, il secondo alto m. 0,32, largo 0,40;
Veuthynteria sporge di m. 0,16.
(2) La sporgenza dell'anta qui è sulla facciata invece che sui
fianchi del tempio come di solito. Sporg. m. 0,10, largh. 0,30.
(3) Il bastoncello o toro, che qui si vede intagliato ver-
ticalmente presso l'anta è, come è noto, una forma frequente
nell'architettura medievale.
(4J Cfr. per es. lo Heraeon di Olimpia, DOrpfeld, Olympia,
III, p. 30 sgg. ; Perrot-Chipiez, op. cit., VII, p. 368 sgg.
(5) Per gli stipiti della porta v. Perrot-Chipiez, ibid.,
p. 609, fig. 397; cfr. anche p. 590, figg. 364-366 e p. 592,
flg. 372; per il toro ibid. p. 603 e p. 349, fig. 207. Come
negli edificii egiziani, il toro avrà girato orizzontalmente anche
sotto la cornice del Pythion.
fabbrica sopra un maestoso piedistallo sorgente sul
piano del terreno ove fu costruita.
Non so se a queste caratteristiche debba aggiungersi
l'assenza di ogni traccia di ordine architettonico nella
severa cella primitiva, poiché essa può essere dovuta
alle trasformazioni dell'epoca romana; anzi consi-
derando l'ampiezza della cella stessa sembra ne-
cessario che alcune colonne, forse di legno come nello
Heraeon, sostenessero nel mezzo la copertura, simil-
mente a quelle dell'epoca predetta ('). Che però esse
fossero tante quante queste, cioè otto, non sembra a
me così possibile come allo Halbherr, per più ragioni :
prima perchè la base di una di queste è venuta a
posare sulla pietra marginale di una fossa preesistente
di cui fra breve diremo, tino a sporgere di qualche
centimetro sul vuoto di essa, ciò che non poteva es-
sere assolutamente nel tempo in cui questa fu co-
struita (v. la pianta, fig. 3, e tav. II, n. 1); secondo,
perchè la loro disposizione in due file dividenti lo
spazio in tre navate apparisce piuttosto una conces-
sione alla moda dominante nei templi bislunghi, che
un sistema adatto alla pianta d'un tempio come
questo; terzo, perchè, ammessa la sua filiazione dal
megaron preistorico, è molto più verisimile che da
questo ereditasse anche la collocazione delle colonne.
Oggi meglio che venti anni addietro è lecito fare
congetture abbastanza fondate anche su ciò e sulla
forma stessa della copertura di questo edificio. Io
credo che le colonne, erette più o meno esattamente
nel mezzo, fossero o due o quattro, cioè o quante le
vediamo a Cnossos nel « Megaron della Regina » e
nella « Sala delle bipenni » ed a Phaestos nel lo-
cale 77-78, nelle sale 22 e 25 e nella su ricordata
stanza a sulla terrazza nord-ovest dell'acropoli (2),
oppure quante sono nell'altro locale n. 50 di Phae-
stos stessa, e poi anche nel centro dei megara di
(') Indizi di colonne di legno si sono trovati anche nel
citato tempio arcaico di Thermos (cfr. Sotiriadis, 'Eqpj^u. Jq/-
1900, p. 173). Forse scavando sotto il pavimento di marmo
del Pythion (il che sarà un giorno necessario di fare) si trove-
ranno gli clementi per chiarire tale questione. Anche se l'alzato
dei muri, di cui abbiamo detto sopra a p. 206 segg., terminasse
o no con qualche fregio, non possiamo dire; certo gli elementi
del fregio a metopi e triglifi si trovano già a Phaestos (cfr.
Pernier, Monum. aut., XII, p. 47, fig. 13) e, credo, anche
nelle fascie soprastanti alle colonne del citato sacello di una
pittura di Cnossos (v. qui appresso p. 225, nota 1).
(2) V. sopra p. 219, nota 2.
NUOVI STUDII E SCOPERTE IN GORTYNA
224
significato originario. Metodi analoghi di costruzione
della base di muri avevano già usato gli Egiziani (').
Abbiamo poi veduto che i muri settentrionale e
meridionale del tempio primitivo terminavano sulla
facciata con una specie di anta centinata. Essa può
sorprenderci e per il suo trovarsi in quel posto (2)
e per la sua forma stessa, per cui io non saprei citare
altro esempio dell'antichità classica (3) ; ma le iscri-
zioni che ne coprono la pietra ci assicurano nel modo
più certo che essa appartiene alla prima costruzione
del tempio. Comunque sia, essa, come le ante terminali
e isolate dei templi di altri tipi (4), rinforza l'estremità
del muro e può ripetere la sua origine dalla imita-
zione degli antepagmenta di legno che rivestivano le
estremità dei muri preistorici. E dalla stessa causa
può essere stato determinato l'insolito ingrossamento
verso l'interno degli stipiti della porta. Ma non si
devono trascurare le analogie che l'architettura egi-
ziana ci offre così per una siffatta sporgenza degli
stipiti come per quella specie di toro o bastoncello
verticale che incornicia le ante del Pythion (5). Lì
forse è il principio di queste forme.
Anche il fatto che il tempio sorgeva unicamente sul
piano della euthynteria, corrispondente press'a poco al
livello del suolo circostante, è un indizio spiccato di
arcaismo, ch'esso ha comune con lo Heraeon, coi templi
arcaici del Sunio, di Neandria e di Thermos e col vecchio
Hekatompedon di Atene, ma anche, e prima di questi,
coi megara dei palazzi preistorici ond' essi deri-
vano. Questi templi primitivi conservano anche in
ciò, io credo, il ricordo della loro origine, e non hanno
ancoia quella espressione d'indipendenza che ha il
tempio greco classico, in cui è tipica la elevazione della
(') Cfr. i muri di Luqsor, Perrot-Chipiez, op. cit. I, p. 601,
fìgg. 386 e 387. Dei gradini del Pythion, il primo in basso è
alto m. 0,29, lungo 0,30, il secondo alto m. 0,32, largo 0,40;
Veuthynteria sporge di m. 0,16.
(2) La sporgenza dell'anta qui è sulla facciata invece che sui
fianchi del tempio come di solito. Sporg. m. 0,10, largh. 0,30.
(3) Il bastoncello o toro, che qui si vede intagliato ver-
ticalmente presso l'anta è, come è noto, una forma frequente
nell'architettura medievale.
(4J Cfr. per es. lo Heraeon di Olimpia, DOrpfeld, Olympia,
III, p. 30 sgg. ; Perrot-Chipiez, op. cit., VII, p. 368 sgg.
(5) Per gli stipiti della porta v. Perrot-Chipiez, ibid.,
p. 609, fig. 397; cfr. anche p. 590, figg. 364-366 e p. 592,
flg. 372; per il toro ibid. p. 603 e p. 349, fig. 207. Come
negli edificii egiziani, il toro avrà girato orizzontalmente anche
sotto la cornice del Pythion.
fabbrica sopra un maestoso piedistallo sorgente sul
piano del terreno ove fu costruita.
Non so se a queste caratteristiche debba aggiungersi
l'assenza di ogni traccia di ordine architettonico nella
severa cella primitiva, poiché essa può essere dovuta
alle trasformazioni dell'epoca romana; anzi consi-
derando l'ampiezza della cella stessa sembra ne-
cessario che alcune colonne, forse di legno come nello
Heraeon, sostenessero nel mezzo la copertura, simil-
mente a quelle dell'epoca predetta ('). Che però esse
fossero tante quante queste, cioè otto, non sembra a
me così possibile come allo Halbherr, per più ragioni :
prima perchè la base di una di queste è venuta a
posare sulla pietra marginale di una fossa preesistente
di cui fra breve diremo, tino a sporgere di qualche
centimetro sul vuoto di essa, ciò che non poteva es-
sere assolutamente nel tempo in cui questa fu co-
struita (v. la pianta, fig. 3, e tav. II, n. 1); secondo,
perchè la loro disposizione in due file dividenti lo
spazio in tre navate apparisce piuttosto una conces-
sione alla moda dominante nei templi bislunghi, che
un sistema adatto alla pianta d'un tempio come
questo; terzo, perchè, ammessa la sua filiazione dal
megaron preistorico, è molto più verisimile che da
questo ereditasse anche la collocazione delle colonne.
Oggi meglio che venti anni addietro è lecito fare
congetture abbastanza fondate anche su ciò e sulla
forma stessa della copertura di questo edificio. Io
credo che le colonne, erette più o meno esattamente
nel mezzo, fossero o due o quattro, cioè o quante le
vediamo a Cnossos nel « Megaron della Regina » e
nella « Sala delle bipenni » ed a Phaestos nel lo-
cale 77-78, nelle sale 22 e 25 e nella su ricordata
stanza a sulla terrazza nord-ovest dell'acropoli (2),
oppure quante sono nell'altro locale n. 50 di Phae-
stos stessa, e poi anche nel centro dei megara di
(') Indizi di colonne di legno si sono trovati anche nel
citato tempio arcaico di Thermos (cfr. Sotiriadis, 'Eqpj^u. Jq/-
1900, p. 173). Forse scavando sotto il pavimento di marmo
del Pythion (il che sarà un giorno necessario di fare) si trove-
ranno gli clementi per chiarire tale questione. Anche se l'alzato
dei muri, di cui abbiamo detto sopra a p. 206 segg., terminasse
o no con qualche fregio, non possiamo dire; certo gli elementi
del fregio a metopi e triglifi si trovano già a Phaestos (cfr.
Pernier, Monum. aut., XII, p. 47, fig. 13) e, credo, anche
nelle fascie soprastanti alle colonne del citato sacello di una
pittura di Cnossos (v. qui appresso p. 225, nota 1).
(2) V. sopra p. 219, nota 2.