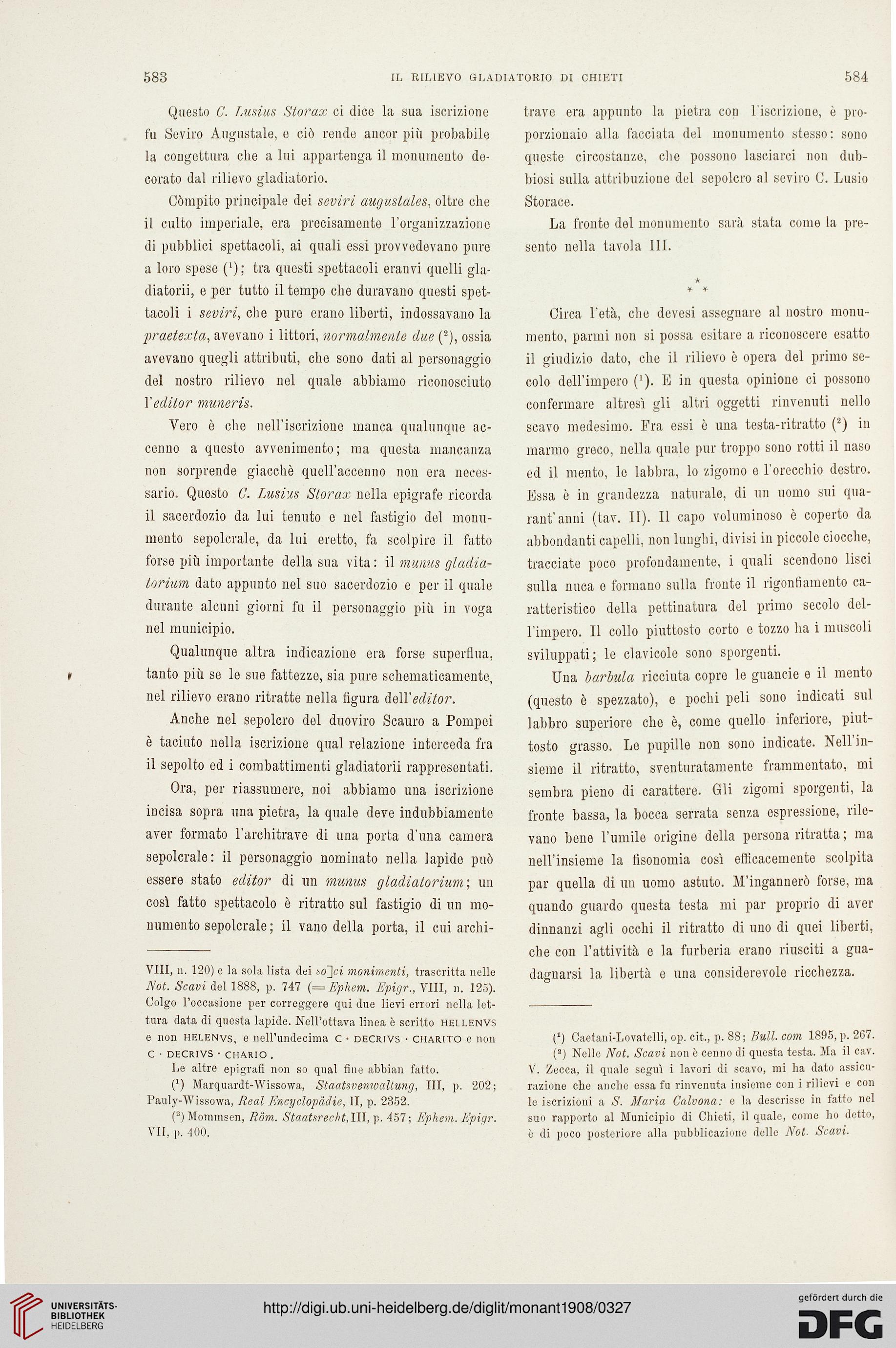583
il rilievo gladiatorio di chikti
584
Questo C. Lusius Storax ci dice la sua iscrizione
fu Seviro Augustale, e ciò rende ancor più probabile
la congettura che a lui appartenga il monumento do-
corato dal rilievo gladiatorio.
Compito principale dei seviri augustales, oltre che
il culto imperiale, era precisamente l'organizzazione
di pubblici spettacoli, ai quali essi provvedevano pure
a loro spese ('); tra questi spettacoli eranvi quelli gla-
diatori!, e per tutto il tempo che duravano questi spet-
tacoli i seviri, che pure erano liberti, indossavano la
■praetexta, avevano i littori, normalmente due (2), ossia
avevano quegli attributi, che sono dati al personaggio
del nostro rilievo nel quale abbiamo riconosciuto
Yeditor muneris.
Vero è che nell'iscrizione manca qualunque ac-
cenno a questo avvenimento; ma questa mancanza
non sorprende giacché quell'accenno non era neces-
sario. Questo C. Lusius Storax nella epigrafe ricorda
il sacerdozio da lui tenuto e nel fastigio del monu-
mento sepolcrale, da lui eretto, fa scolpire il fatto
forse più importante della sua vita: il munus gladia-
torium dato appunto nel suo sacerdozio e per il quale
durante alcuni giorni fu il personaggio più in voga
nel municipio.
Qualunque altra indicazione era forse superflua,
tanto più se le sue fattezze, sia pure schematicamente,
nel rilievo erano ritratte nella figura dell' editor.
Anche nel sepolcro del duoviro Scauro a Pompei
è taciuto nella iscrizione qual relazione interceda fra
il sepolto ed i combattimenti gladiatorii rappresentati.
Ora, per riassumere, noi abbiamo una iscrizione
incisa sopra una pietra, la quale deve indubbiamente
aver formato l'architrave di una porta d'una camera
sepolcrale: il personaggio nominato nella lapido può
essere stato editor di un munus gladiatorium; un
così fatto spettacolo è ritratto sul fastigio di un mo-
numento sepolcrale; il vano della porta, il cui archi-
vili, n. 120) e la sola lista dei bO~\ci monimenti, trascritta nelle
Not. Scavi del 1888, p. 747 (= Ephem. Epigr., Vili, n. 125).
Colgo l'occasione per correggere qui due lievi errori nella let-
tura data di questa lapide. Nell'ottava linea è scritto hellenvs
e non helenvs, e nell'undecima c • decrivs • charito c non
c ■ decrivs • chario .
Le altre epigrafi non so qual fine abbian fatto.
(') Marquardt-Wissowa, Staatsvenwaltung, III, p. 202;
Pauly-Wissowa, Real Encyclopàdie, lì, p. 2352.
(s) Mommsen, Rum. Staatsrecht,lU,y,. 457; Ephem. Epigr.
VII, p. -100.
trave era appunto la pietra con l'iscrizione, è pro-
porzionalo alla facciala del monumento stesso: sono
queste circostanze, die possono lasciarci non dub-
biosi sulla attribuzione del sepolcro al seviro C. Lusio
Storace.
La fronte del monumento sarà stata come la pre-
sento nella tavola III.
* *■
Circa l'età, che devesi assegnare al nostro monu-
mento, panni non si possa esitare a riconoscere esatto
il giudizio dato, che il rilievo è opera del primo se-
colo dell'impero ('). E in quosta opinione ci possono
confermare altresì gli altri oggetti rinvenuti nello
scavo medesimo. Fra essi è una testa-ritratto (2) in
marmo greco, nella quale pur troppo sono rotti il naso
ed il mento, le labbra, lo zigomo e l'orecchio destro.
Essa ò in grandezza naturale, di un uomo sui qua-
rant'anni (tav. II). Il capo voluminoso è coperto da
abbondanti capelli, non lunghi, divisi in piccole ciocche,
tracciate poco profondamente, i quali scendono lisci
sulla nuca e formano sulla fronte il rigonfiamento ca-
ratteristico della pettinatura del primo secolo del-
l'impero. Il collo piuttosto corto e tozzo ha i muscoli
sviluppati; le clavicole sono sporgenti.
Una barbula ricciuta copre le guancie e il mento
(questo è spezzato), e pochi peli sono indicati sul
labbro superiore che è, come quello inferiore, piut-
tosto grasso. Le pupille non sono indicate. Nell'in-
sieme il ritratto, sventuratamente frammentato, mi
sembra pieno di carattere. Gli zigomi sporgenti, la
fronte bassa, la bocca serrata senza espressione, rile-
vano bene l'umile origine della persona ritratta ; ma
nell'insieme la fisonomia così efficacemente scolpita
par quella di un uomo astuto. M'ingannerò forse, ma
quando guardo questa testa mi par proprio di aver
dinnanzi agli occhi il ritratto di uno di quei liberti,
che con l'attività e la furberia erano riusciti a gua-
dagnarsi la libertà e una considerevole ricchezza.
C) Caetani-Lovatelli, op. cit., p. 88 ; Bull, com 1895, p. 207.
(a) Nelle Not. Scavi non è cenno di questa testa. Ma il cav.
V. Zecca, il quale seguì i lavori di scavo, mi ha dato assicu-
razione che anche essa fu rinvenuta insieme con i rilievi e con
le iscrizioni a S. Maria Galvona: e la descrisse in fatto nel
suo rapporto al Municipio di Chieti, il quale, come ho dette,
è di poco posteriore alla pubblicazione delle Not- Scavi.
il rilievo gladiatorio di chikti
584
Questo C. Lusius Storax ci dice la sua iscrizione
fu Seviro Augustale, e ciò rende ancor più probabile
la congettura che a lui appartenga il monumento do-
corato dal rilievo gladiatorio.
Compito principale dei seviri augustales, oltre che
il culto imperiale, era precisamente l'organizzazione
di pubblici spettacoli, ai quali essi provvedevano pure
a loro spese ('); tra questi spettacoli eranvi quelli gla-
diatori!, e per tutto il tempo che duravano questi spet-
tacoli i seviri, che pure erano liberti, indossavano la
■praetexta, avevano i littori, normalmente due (2), ossia
avevano quegli attributi, che sono dati al personaggio
del nostro rilievo nel quale abbiamo riconosciuto
Yeditor muneris.
Vero è che nell'iscrizione manca qualunque ac-
cenno a questo avvenimento; ma questa mancanza
non sorprende giacché quell'accenno non era neces-
sario. Questo C. Lusius Storax nella epigrafe ricorda
il sacerdozio da lui tenuto e nel fastigio del monu-
mento sepolcrale, da lui eretto, fa scolpire il fatto
forse più importante della sua vita: il munus gladia-
torium dato appunto nel suo sacerdozio e per il quale
durante alcuni giorni fu il personaggio più in voga
nel municipio.
Qualunque altra indicazione era forse superflua,
tanto più se le sue fattezze, sia pure schematicamente,
nel rilievo erano ritratte nella figura dell' editor.
Anche nel sepolcro del duoviro Scauro a Pompei
è taciuto nella iscrizione qual relazione interceda fra
il sepolto ed i combattimenti gladiatorii rappresentati.
Ora, per riassumere, noi abbiamo una iscrizione
incisa sopra una pietra, la quale deve indubbiamente
aver formato l'architrave di una porta d'una camera
sepolcrale: il personaggio nominato nella lapido può
essere stato editor di un munus gladiatorium; un
così fatto spettacolo è ritratto sul fastigio di un mo-
numento sepolcrale; il vano della porta, il cui archi-
vili, n. 120) e la sola lista dei bO~\ci monimenti, trascritta nelle
Not. Scavi del 1888, p. 747 (= Ephem. Epigr., Vili, n. 125).
Colgo l'occasione per correggere qui due lievi errori nella let-
tura data di questa lapide. Nell'ottava linea è scritto hellenvs
e non helenvs, e nell'undecima c • decrivs • charito c non
c ■ decrivs • chario .
Le altre epigrafi non so qual fine abbian fatto.
(') Marquardt-Wissowa, Staatsvenwaltung, III, p. 202;
Pauly-Wissowa, Real Encyclopàdie, lì, p. 2352.
(s) Mommsen, Rum. Staatsrecht,lU,y,. 457; Ephem. Epigr.
VII, p. -100.
trave era appunto la pietra con l'iscrizione, è pro-
porzionalo alla facciala del monumento stesso: sono
queste circostanze, die possono lasciarci non dub-
biosi sulla attribuzione del sepolcro al seviro C. Lusio
Storace.
La fronte del monumento sarà stata come la pre-
sento nella tavola III.
* *■
Circa l'età, che devesi assegnare al nostro monu-
mento, panni non si possa esitare a riconoscere esatto
il giudizio dato, che il rilievo è opera del primo se-
colo dell'impero ('). E in quosta opinione ci possono
confermare altresì gli altri oggetti rinvenuti nello
scavo medesimo. Fra essi è una testa-ritratto (2) in
marmo greco, nella quale pur troppo sono rotti il naso
ed il mento, le labbra, lo zigomo e l'orecchio destro.
Essa ò in grandezza naturale, di un uomo sui qua-
rant'anni (tav. II). Il capo voluminoso è coperto da
abbondanti capelli, non lunghi, divisi in piccole ciocche,
tracciate poco profondamente, i quali scendono lisci
sulla nuca e formano sulla fronte il rigonfiamento ca-
ratteristico della pettinatura del primo secolo del-
l'impero. Il collo piuttosto corto e tozzo ha i muscoli
sviluppati; le clavicole sono sporgenti.
Una barbula ricciuta copre le guancie e il mento
(questo è spezzato), e pochi peli sono indicati sul
labbro superiore che è, come quello inferiore, piut-
tosto grasso. Le pupille non sono indicate. Nell'in-
sieme il ritratto, sventuratamente frammentato, mi
sembra pieno di carattere. Gli zigomi sporgenti, la
fronte bassa, la bocca serrata senza espressione, rile-
vano bene l'umile origine della persona ritratta ; ma
nell'insieme la fisonomia così efficacemente scolpita
par quella di un uomo astuto. M'ingannerò forse, ma
quando guardo questa testa mi par proprio di aver
dinnanzi agli occhi il ritratto di uno di quei liberti,
che con l'attività e la furberia erano riusciti a gua-
dagnarsi la libertà e una considerevole ricchezza.
C) Caetani-Lovatelli, op. cit., p. 88 ; Bull, com 1895, p. 207.
(a) Nelle Not. Scavi non è cenno di questa testa. Ma il cav.
V. Zecca, il quale seguì i lavori di scavo, mi ha dato assicu-
razione che anche essa fu rinvenuta insieme con i rilievi e con
le iscrizioni a S. Maria Galvona: e la descrisse in fatto nel
suo rapporto al Municipio di Chieti, il quale, come ho dette,
è di poco posteriore alla pubblicazione delle Not- Scavi.