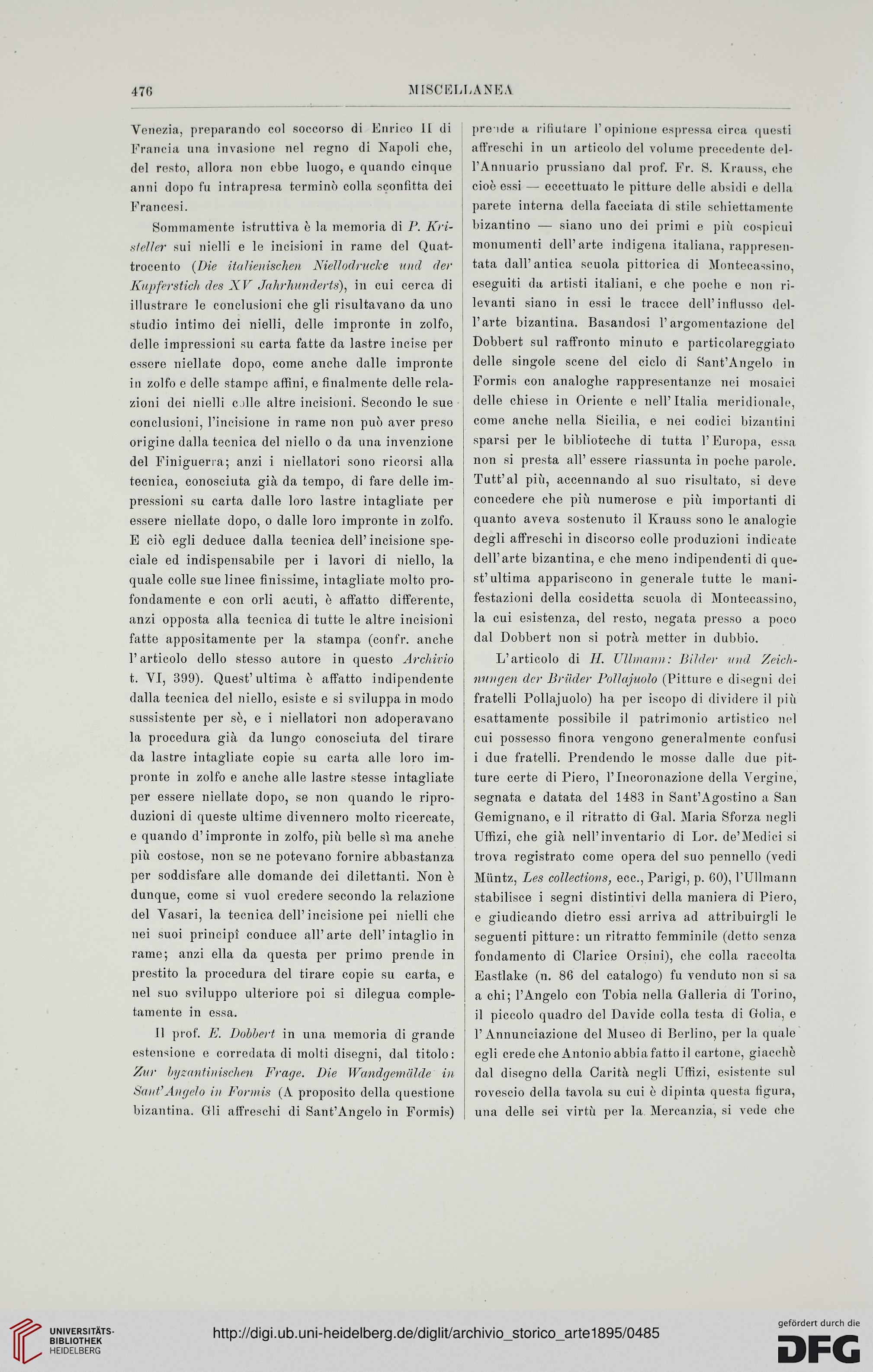476
MISCELLANEA
Venezia, preparando col soccorso di Enrico II di
Francia una invasione nel regno di Napoli che,
del resto, allora non ebbe luogo, e quando cinque
anni dopo fu intrapresa terminò colla sconfitta dei
I rancesi.
Sommamente istruttiva è la memoria di P. Kri-
slcller sui nielli e le incisioni in rame del Quat-
trocento (Die italienischen Niellodrucke und der
Kupferstich des XV Jahrhunderts), in cui cerca di
illustrare le conclusioni che gli risultavano da uno
studio intimo dei nielli, delle impronte in zolfo,
delle impressioni su carta fatte da lastre incise per
essere niellate dopo, come anche dalle impronte
in zolfo e delle stampe affini, e finalmente delle rela-
zioni dei nielli c.ille altre incisioni. Secondo le sue
conclusioni, l'incisione in rame non può aver preso
origine dalla tecnica del niello o da una invenzione
del Finiguerra; anzi i niellatori sono ricorsi alla
tecnica, conosciuta già da tempo, di fare delle im-
pressioni su carta dalle loro lastre intagliate per
essere niellate dopo, o dalle loro impronte in zolfo.
E ciò egli deduce dalla tecnica dell' incisione spe-
ciale ed indispensabile per i lavori di niello, la
quale colle sue linee finissime, intagliate molto pro-
fondamente e con orli acuti, è affatto differente,
anzi opposta alla tecnica di tutte le altre incisioni
fatte appositamente per la stampa (confr. anche
l'articolo dello stesso autore in questo Archivio
t. VI, 399). Quest'ultima è affatto indipendente
dalla tecnica del niello, esiste e si sviluppa in modo
sussistente per se, e i niellatori non adoperavano
la procedura già da lungo conosciuta del tirare
da lastre intagliate copie su carta alle loro im-
pronte in zolfo e anche alle lastre stesse intagliate
per essere niellate dopo, se non quando le ripro-
duzioni di queste ultime divennero molto ricercate,
e quando d'impronte in zolfo, più belle sì ma anche
più costose, non se ne potevano fornire abbastanza
per soddisfare alle domande dei dilettanti. Non è
dunque, come si vuol credere secondo la relazione
del Vasari, la tecnica dell'incisione pei nielli che
nei suoi principi conduce all'arte dell'intaglio in
rame; anzi ella da questa per primo prende in
prestito la procedura del tirare copie su carta, e
nel suo sviluppo ulteriore poi si dilegua comple-
tamente in essa.
Il prof. E. Dobbert in una memoria di grande
estensione e corredata di molti disegni, dal titolo:
Zur byzantinischen Frage. Die Wandgemàlde in
Sant'Angelo in Formis (A proposito della questione
bizantina. Oli affreschi di Sant'Angelo in Formis)
prode a rifiutare l'opinione espressa circa questi
affreschi in un articolo del volume precedente del-
l'Annuario prussiano dal prof. Fr. S. Krauss, che
cioè essi — eccettuato le pitture delle absidi e della
parete interna della facciata di stile schiettamente
bizantino — siano uno dei primi e più cospicui
monumenti dell'arte indigena italiana, rappresen-
tata dall'antica scuola pittorica di Montecassino,
eseguiti da artisti italiani, e che poche e non ri-
levanti siano in essi le tracce dell'influsso del-
l'arte bizantina. Basandosi l'argomentazione del
Dobbert sul raffronto minuto e particolareggiato
delle singole scene del ciclo di Sant'Angelo in
Formis con analoghe rappresentanze nei mosaici
delle chiese in Oriente e nell' Italia meridionale,
come anche nella Sicilia, e nei codici bizantini
sparsi per le biblioteche di tutta l'Europa, essa
non si presta all' essere riassunta in poche parole.
Tutt'al più, accennando al suo risultato, si deve
concedere che più numerose e più importanti di
quanto aveva sostenuto il Krauss sono le analogie
degli affreschi in discorso colle produzioni indicate
dell'arte bizantina, e che meno indipendenti di que-
st'ultima appariscono in generale tutte le mani-
festazioni della cosidetta scuola di Montecassino,
la cui esistenza, del resto, negata presso a poco
dal Dobbert non si potrà metter in dubbio.
L'articolo di H. Ullmann: Biìdev und Zeich-
nnngen dcr Briider Pollajuolo (Pitture e disegni dei
fratelli Pollajuolo) ha per iscopo di dividere il più
esattamente possibile il patrimonio artistico nel
cui possesso finora vengono generalmente confusi
i due fratelli. Prendendo le mosse dalle due pit-
ture certe di Piero, l'Incoronazione della Vergine,
segnata e datata del 1483 in Sant'Agostino a San
Oemignano, e il ritratto di Gal. Maria Sforza negli
Uffizi, che già nell'inventario di Lor. de'Medici si
trova registrato come opera del suo pennello (vedi
Muntz, Les collections, ecc., Parigi, p. 60), rUllmann
stabilisce i segni distintivi della maniera di Piero,
e giudicando dietro essi arriva ad attribuirgli le
seguenti pitture: un ritratto femminile (detto senza
fondamento di Clarice Orsini), che colla raccolta
Eastlake (n. 86 del catalogo) fu venduto non si sa
a chi; l'Angelo con Tobia nella Galleria di Torino,
il piccolo quadro del Davide colla testa di Golia, e
l'Annunciazione del Museo di Berlino, per la quale
egli crede che Antonio abbia fatto il cartone, giacche
dal disegno della Carità negli Uffizi, esistente sul
rovescio della tavola su cui ò dipinta questa figura,
una delle sei virtù per la Mercanzia, si vede che
MISCELLANEA
Venezia, preparando col soccorso di Enrico II di
Francia una invasione nel regno di Napoli che,
del resto, allora non ebbe luogo, e quando cinque
anni dopo fu intrapresa terminò colla sconfitta dei
I rancesi.
Sommamente istruttiva è la memoria di P. Kri-
slcller sui nielli e le incisioni in rame del Quat-
trocento (Die italienischen Niellodrucke und der
Kupferstich des XV Jahrhunderts), in cui cerca di
illustrare le conclusioni che gli risultavano da uno
studio intimo dei nielli, delle impronte in zolfo,
delle impressioni su carta fatte da lastre incise per
essere niellate dopo, come anche dalle impronte
in zolfo e delle stampe affini, e finalmente delle rela-
zioni dei nielli c.ille altre incisioni. Secondo le sue
conclusioni, l'incisione in rame non può aver preso
origine dalla tecnica del niello o da una invenzione
del Finiguerra; anzi i niellatori sono ricorsi alla
tecnica, conosciuta già da tempo, di fare delle im-
pressioni su carta dalle loro lastre intagliate per
essere niellate dopo, o dalle loro impronte in zolfo.
E ciò egli deduce dalla tecnica dell' incisione spe-
ciale ed indispensabile per i lavori di niello, la
quale colle sue linee finissime, intagliate molto pro-
fondamente e con orli acuti, è affatto differente,
anzi opposta alla tecnica di tutte le altre incisioni
fatte appositamente per la stampa (confr. anche
l'articolo dello stesso autore in questo Archivio
t. VI, 399). Quest'ultima è affatto indipendente
dalla tecnica del niello, esiste e si sviluppa in modo
sussistente per se, e i niellatori non adoperavano
la procedura già da lungo conosciuta del tirare
da lastre intagliate copie su carta alle loro im-
pronte in zolfo e anche alle lastre stesse intagliate
per essere niellate dopo, se non quando le ripro-
duzioni di queste ultime divennero molto ricercate,
e quando d'impronte in zolfo, più belle sì ma anche
più costose, non se ne potevano fornire abbastanza
per soddisfare alle domande dei dilettanti. Non è
dunque, come si vuol credere secondo la relazione
del Vasari, la tecnica dell'incisione pei nielli che
nei suoi principi conduce all'arte dell'intaglio in
rame; anzi ella da questa per primo prende in
prestito la procedura del tirare copie su carta, e
nel suo sviluppo ulteriore poi si dilegua comple-
tamente in essa.
Il prof. E. Dobbert in una memoria di grande
estensione e corredata di molti disegni, dal titolo:
Zur byzantinischen Frage. Die Wandgemàlde in
Sant'Angelo in Formis (A proposito della questione
bizantina. Oli affreschi di Sant'Angelo in Formis)
prode a rifiutare l'opinione espressa circa questi
affreschi in un articolo del volume precedente del-
l'Annuario prussiano dal prof. Fr. S. Krauss, che
cioè essi — eccettuato le pitture delle absidi e della
parete interna della facciata di stile schiettamente
bizantino — siano uno dei primi e più cospicui
monumenti dell'arte indigena italiana, rappresen-
tata dall'antica scuola pittorica di Montecassino,
eseguiti da artisti italiani, e che poche e non ri-
levanti siano in essi le tracce dell'influsso del-
l'arte bizantina. Basandosi l'argomentazione del
Dobbert sul raffronto minuto e particolareggiato
delle singole scene del ciclo di Sant'Angelo in
Formis con analoghe rappresentanze nei mosaici
delle chiese in Oriente e nell' Italia meridionale,
come anche nella Sicilia, e nei codici bizantini
sparsi per le biblioteche di tutta l'Europa, essa
non si presta all' essere riassunta in poche parole.
Tutt'al più, accennando al suo risultato, si deve
concedere che più numerose e più importanti di
quanto aveva sostenuto il Krauss sono le analogie
degli affreschi in discorso colle produzioni indicate
dell'arte bizantina, e che meno indipendenti di que-
st'ultima appariscono in generale tutte le mani-
festazioni della cosidetta scuola di Montecassino,
la cui esistenza, del resto, negata presso a poco
dal Dobbert non si potrà metter in dubbio.
L'articolo di H. Ullmann: Biìdev und Zeich-
nnngen dcr Briider Pollajuolo (Pitture e disegni dei
fratelli Pollajuolo) ha per iscopo di dividere il più
esattamente possibile il patrimonio artistico nel
cui possesso finora vengono generalmente confusi
i due fratelli. Prendendo le mosse dalle due pit-
ture certe di Piero, l'Incoronazione della Vergine,
segnata e datata del 1483 in Sant'Agostino a San
Oemignano, e il ritratto di Gal. Maria Sforza negli
Uffizi, che già nell'inventario di Lor. de'Medici si
trova registrato come opera del suo pennello (vedi
Muntz, Les collections, ecc., Parigi, p. 60), rUllmann
stabilisce i segni distintivi della maniera di Piero,
e giudicando dietro essi arriva ad attribuirgli le
seguenti pitture: un ritratto femminile (detto senza
fondamento di Clarice Orsini), che colla raccolta
Eastlake (n. 86 del catalogo) fu venduto non si sa
a chi; l'Angelo con Tobia nella Galleria di Torino,
il piccolo quadro del Davide colla testa di Golia, e
l'Annunciazione del Museo di Berlino, per la quale
egli crede che Antonio abbia fatto il cartone, giacche
dal disegno della Carità negli Uffizi, esistente sul
rovescio della tavola su cui ò dipinta questa figura,
una delle sei virtù per la Mercanzia, si vede che