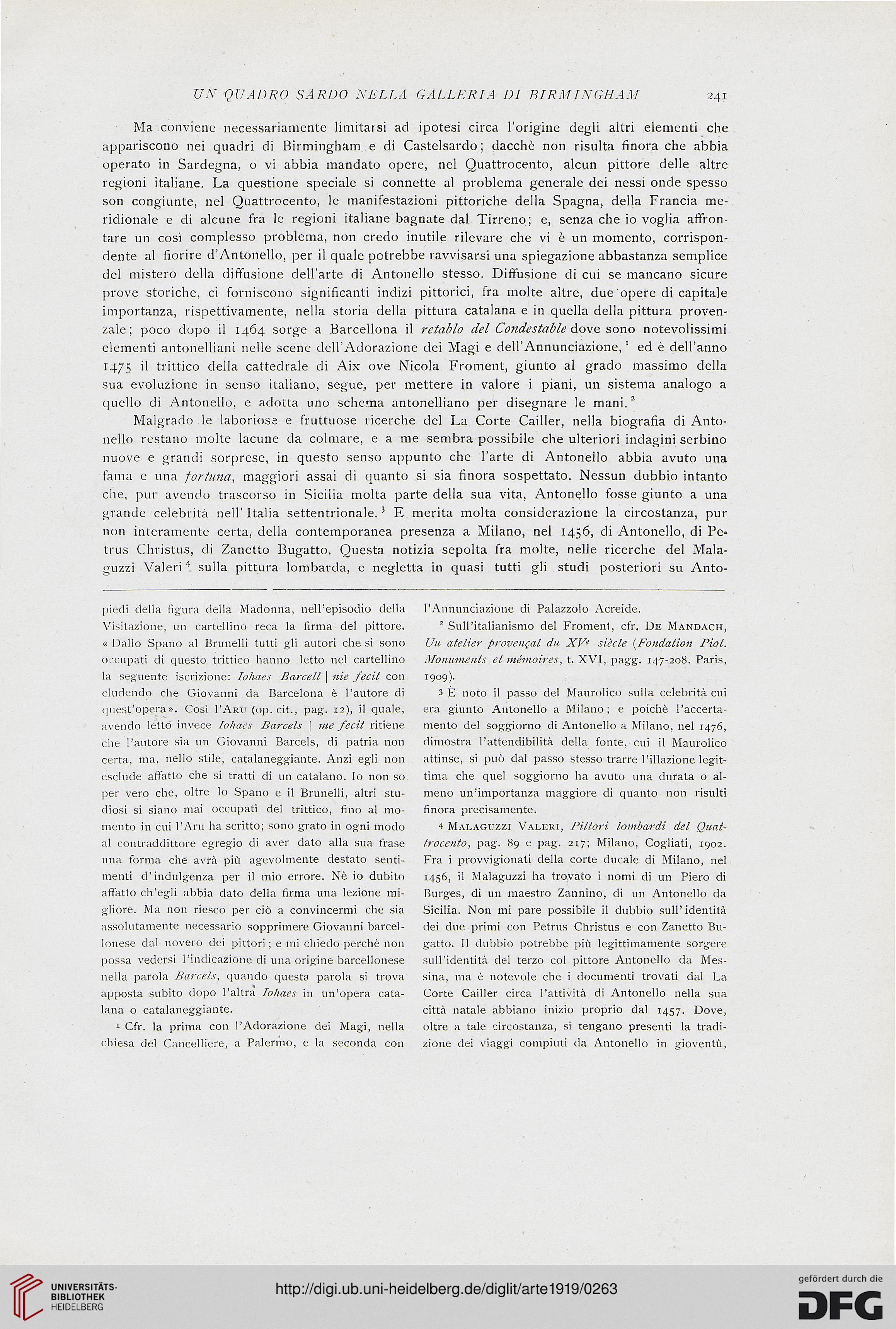UN QUADRO SARDO NELLA GALLERIA DI BIRMINGHAM
241
Ma conviene necessariamente limitai si ad ipotesi circa l'origine degli altri elementi che
appariscono nei quadri di Birmingham e di Castelsardo ; dacché non risulta finora che abbia
operato in Sardegna, o vi abbia mandato opere, nel Quattrocento, alcun pittore delle altre
regioni italiane. La questione speciale si connette al problema generale dei nessi onde spesso
son congiunte, nel Quattrocento, le manifestazioni pittoriche della Spagna, della Francia me-
ridionale e di alcune fra le regioni italiane bagnate dal Tirreno; e, senza che io voglia affron-
tare un così complesso problema, non credo inutile rilevare che vi è un momento, corrispon-
dente al fiorire d'Antonello, per il quale potrebbe ravvisarsi una spiegazione abbastanza semplice
del mistero della diffusione dell'arte di Antonello stesso. Diffusione di cui se mancano sicure
prove storiche, ci forniscono significanti indizi pittorici, fra molte altre, due opere di capitale
importanza, rispettivamente, nella storia della pittura catalana e in quella della pittura proven-
zale ; poco dopo il 1464 sorge a Barcellona il retablo del Condestable dove sono notevolissimi
elementi antonelliani nelle scene dell'Adorazione dei Magi e dell'Annunciazione,1 ed è dell'anno
1475 il trittico della cattedrale di Aix ove Nicola Froment, giunto al grado massimo della
sua evoluzione in senso italiano, segue, per mettere in valore i piani, un sistema analogo a
quello di Antonello, e adotta uno schema antonelliano per disegnare le mani.2
Malgrado le laboriosa e fruttuose ricerche del La Corte Cailler, nella biografia di Anto-
nello restano molte lacune da colmare, e a me sembra possibile che ulteriori indagini serbino
nuove e grandi sorprese, in questo senso appunto che l'arte di Antonello abbia avuto una
fama e una fortuna, maggiori assai di quanto si sia finora sospettato. Nessun dubbio intanto
che, pur avendo trascorso in Sicilia molta parte della sua vita, Antonello fosse giunto a una
grande celebrità nell' Italia settentrionale. 3 E merita molta considerazione la circostanza, pur
non interamente certa, della contemporanea presenza a Milano, nel 1456, di Antonello, di Pe-
trus Christus, di Zanetto Bugatto. Questa notizia sepolta fra molte, nelle ricerche del Mala-
guzzi Valeri4 sulla pittura lombarda, e negletta in quasi tutti gli studi posteriori su Anto-
piedi della figura della Madonna, nell'episodio della
Visitazione, un cartellino reca la firma del pittore.
« Dallo Spano al Brtfnelli tutti gli autori che si sono
occupati di questo trittico hanno letto nel cartellino
la seguente iscrizione: lohaes Barcell \ nie fecit con
eludendo che Giovanni da Barcelona è l'autore di
quest'opera». Così I'Aru (op. cit., pag. 12), il quale,
avendo letto invece lohaes Barcels \ me fecit ritiene
che l'autore sia un Giovanni Barcels, di patria non
certa, ma, nello stile, catalaneggiante. Anzi egli non
esclude affatto che si tratti di un catalano. Io non so
per vero che, oltre lo Spano e il Brunelli, altri stu-
diosi si siano mai occupati del trittico, fino al mo-
mento in cui l'Aru ha scritto; sono grato in ogni modo
al contraddittore egregio di aver dato alla sua frase
una forma che avrà più agevolmente destato senti-
menti d'indulgenza per il mio errore. Nè io dubito
affatto ch'egli abbia dato della firma una lezione mi-
gliore. Ma non riesco per ciò a convincermi che sia
assolutamente necessario sopprimere Giovanni barcel-
lonese dal novero dei pittori ; e mi chiedo perchè non
possa vedersi l'indicazione di una origine barcellonese
nella parola Barcels, quando questa parola si trova
apposta subito dopi) l'altra lohaes in un'opera cata-
lana o catalaneggiante.
1 Cfr. la prima con l'Adorazione dei Magi, nella
chiesa del Cancelliere, a Palermo, e la seconda con
l'Annunciazione di Palazzolo Acreide.
2 Sull'italianismo del Froment, cfr. De Mandach,
Uu atelier provencal du XVe siede {Fondation Piot.
Monuments et mémoires, t. XVI, pagg. 147-208. Paris,
1909).
3 E noto il passo del Maurolico sulla celebrità cui
era giunto Antonello a Milano; e poiché l'accerta-
mento del soggiorno di Antonello a Milano, nel 1476,
dimostra l'attendibilità della fonte, cui il Maurolico
attinse, si può dal passo stesso trarre l'illazione legit-
tima che quel soggiorno ha avuto una durata o al-
meno un'importanza maggiore di quanto non risulti
finora precisamente.
1 Malaguzzi Valeri, Pittori lombardi del Quat-
trocento, pag. 89 e pag. 217; Milano, Cogliati, 1902.
Fra i provvigionati della corte ducale di Milano, nel
1456, il Malaguzzi ha trovato i nomi di un Piero di
Burges, di un maestro Zannino, di un Antonello da
Sicilia. Non mi pare possibile il dubbio sull'identità
dei due primi con Petrus Christus e con Zanetto Bu-
gatto. Il dubbio potrebbe più legittimamente sorgere
sull'identità del terzo col pittore Antonello da Mes-
sina, ma è notevole che i documenti trovati dal La
Corte Cailler circa l'attività di Antonello nella sua
città natale abbiano inizio proprio dal 1457. Dove,
oltre a tale circostanza, si tengano presenti la tradi-
zione dei viaggi compiuti da Antonello in gioventù,
241
Ma conviene necessariamente limitai si ad ipotesi circa l'origine degli altri elementi che
appariscono nei quadri di Birmingham e di Castelsardo ; dacché non risulta finora che abbia
operato in Sardegna, o vi abbia mandato opere, nel Quattrocento, alcun pittore delle altre
regioni italiane. La questione speciale si connette al problema generale dei nessi onde spesso
son congiunte, nel Quattrocento, le manifestazioni pittoriche della Spagna, della Francia me-
ridionale e di alcune fra le regioni italiane bagnate dal Tirreno; e, senza che io voglia affron-
tare un così complesso problema, non credo inutile rilevare che vi è un momento, corrispon-
dente al fiorire d'Antonello, per il quale potrebbe ravvisarsi una spiegazione abbastanza semplice
del mistero della diffusione dell'arte di Antonello stesso. Diffusione di cui se mancano sicure
prove storiche, ci forniscono significanti indizi pittorici, fra molte altre, due opere di capitale
importanza, rispettivamente, nella storia della pittura catalana e in quella della pittura proven-
zale ; poco dopo il 1464 sorge a Barcellona il retablo del Condestable dove sono notevolissimi
elementi antonelliani nelle scene dell'Adorazione dei Magi e dell'Annunciazione,1 ed è dell'anno
1475 il trittico della cattedrale di Aix ove Nicola Froment, giunto al grado massimo della
sua evoluzione in senso italiano, segue, per mettere in valore i piani, un sistema analogo a
quello di Antonello, e adotta uno schema antonelliano per disegnare le mani.2
Malgrado le laboriosa e fruttuose ricerche del La Corte Cailler, nella biografia di Anto-
nello restano molte lacune da colmare, e a me sembra possibile che ulteriori indagini serbino
nuove e grandi sorprese, in questo senso appunto che l'arte di Antonello abbia avuto una
fama e una fortuna, maggiori assai di quanto si sia finora sospettato. Nessun dubbio intanto
che, pur avendo trascorso in Sicilia molta parte della sua vita, Antonello fosse giunto a una
grande celebrità nell' Italia settentrionale. 3 E merita molta considerazione la circostanza, pur
non interamente certa, della contemporanea presenza a Milano, nel 1456, di Antonello, di Pe-
trus Christus, di Zanetto Bugatto. Questa notizia sepolta fra molte, nelle ricerche del Mala-
guzzi Valeri4 sulla pittura lombarda, e negletta in quasi tutti gli studi posteriori su Anto-
piedi della figura della Madonna, nell'episodio della
Visitazione, un cartellino reca la firma del pittore.
« Dallo Spano al Brtfnelli tutti gli autori che si sono
occupati di questo trittico hanno letto nel cartellino
la seguente iscrizione: lohaes Barcell \ nie fecit con
eludendo che Giovanni da Barcelona è l'autore di
quest'opera». Così I'Aru (op. cit., pag. 12), il quale,
avendo letto invece lohaes Barcels \ me fecit ritiene
che l'autore sia un Giovanni Barcels, di patria non
certa, ma, nello stile, catalaneggiante. Anzi egli non
esclude affatto che si tratti di un catalano. Io non so
per vero che, oltre lo Spano e il Brunelli, altri stu-
diosi si siano mai occupati del trittico, fino al mo-
mento in cui l'Aru ha scritto; sono grato in ogni modo
al contraddittore egregio di aver dato alla sua frase
una forma che avrà più agevolmente destato senti-
menti d'indulgenza per il mio errore. Nè io dubito
affatto ch'egli abbia dato della firma una lezione mi-
gliore. Ma non riesco per ciò a convincermi che sia
assolutamente necessario sopprimere Giovanni barcel-
lonese dal novero dei pittori ; e mi chiedo perchè non
possa vedersi l'indicazione di una origine barcellonese
nella parola Barcels, quando questa parola si trova
apposta subito dopi) l'altra lohaes in un'opera cata-
lana o catalaneggiante.
1 Cfr. la prima con l'Adorazione dei Magi, nella
chiesa del Cancelliere, a Palermo, e la seconda con
l'Annunciazione di Palazzolo Acreide.
2 Sull'italianismo del Froment, cfr. De Mandach,
Uu atelier provencal du XVe siede {Fondation Piot.
Monuments et mémoires, t. XVI, pagg. 147-208. Paris,
1909).
3 E noto il passo del Maurolico sulla celebrità cui
era giunto Antonello a Milano; e poiché l'accerta-
mento del soggiorno di Antonello a Milano, nel 1476,
dimostra l'attendibilità della fonte, cui il Maurolico
attinse, si può dal passo stesso trarre l'illazione legit-
tima che quel soggiorno ha avuto una durata o al-
meno un'importanza maggiore di quanto non risulti
finora precisamente.
1 Malaguzzi Valeri, Pittori lombardi del Quat-
trocento, pag. 89 e pag. 217; Milano, Cogliati, 1902.
Fra i provvigionati della corte ducale di Milano, nel
1456, il Malaguzzi ha trovato i nomi di un Piero di
Burges, di un maestro Zannino, di un Antonello da
Sicilia. Non mi pare possibile il dubbio sull'identità
dei due primi con Petrus Christus e con Zanetto Bu-
gatto. Il dubbio potrebbe più legittimamente sorgere
sull'identità del terzo col pittore Antonello da Mes-
sina, ma è notevole che i documenti trovati dal La
Corte Cailler circa l'attività di Antonello nella sua
città natale abbiano inizio proprio dal 1457. Dove,
oltre a tale circostanza, si tengano presenti la tradi-
zione dei viaggi compiuti da Antonello in gioventù,