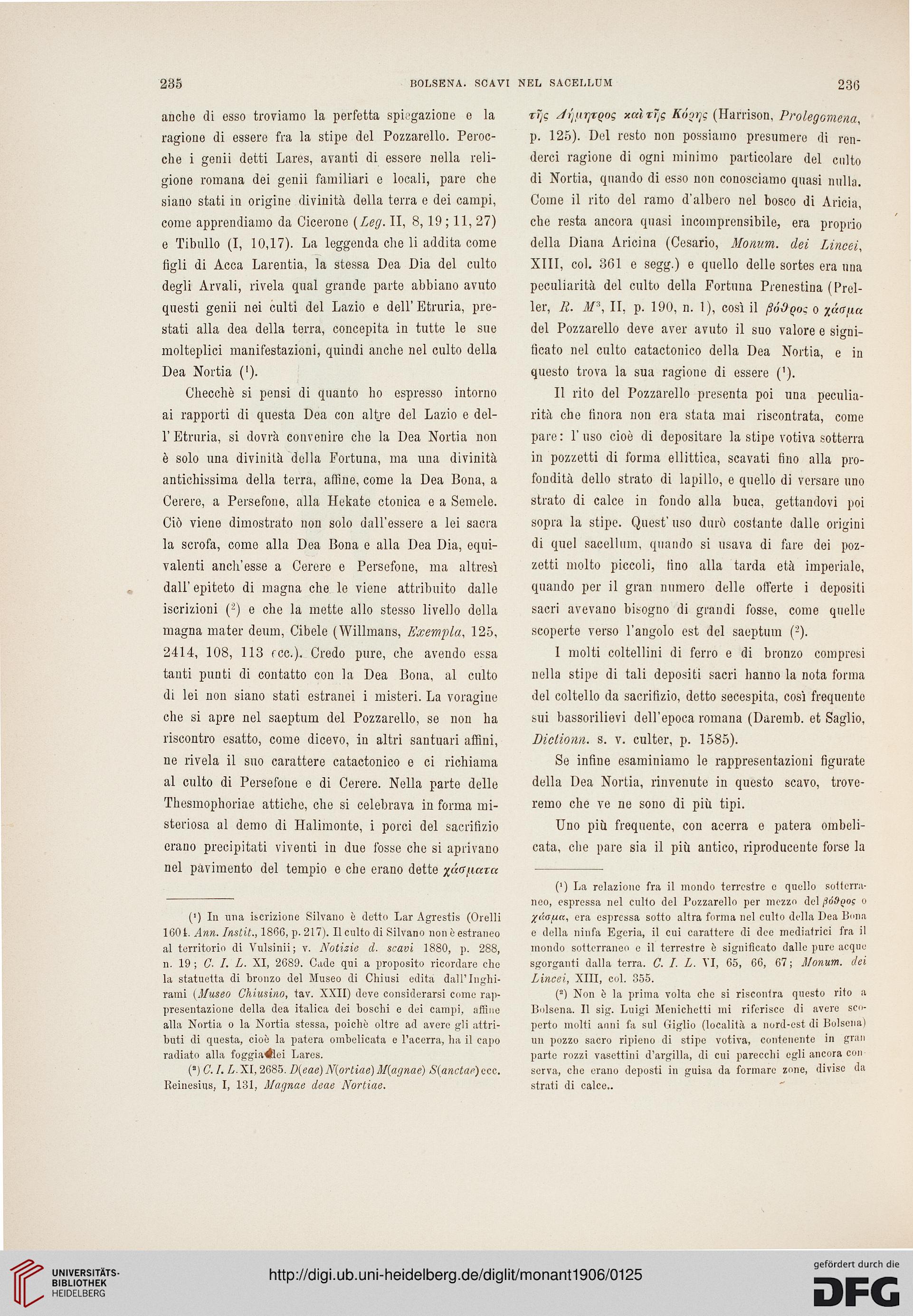235
bolsena. scavi nel sacei.lum
230
anche di esso troviamo la perfetta spiegazione e la
ragione di essere fra la stipe del Pozzarello. Peroc-
ché i genii detti Lares, avanti di essere nella reli-
gione romana dei genii familiari e locali, pare che
siano stati in origine divinità della terra e dei campi,
come apprendiamo da Cicerone (Leg. II, 8, 19 ; 11, 27)
e Tibullo (I, 10,17). La leggenda che li addita come
figli di Acca Larentia, la stessa Dea Dia del culto
degli Arvali, rivela qual grande parte abbiano avuto
questi genii nei culti del Lazio e dell' Etruria, pre-
stati alla dea della terra, concepita in tutte le sue
molteplici manifestazioni, quindi anche nel culto della
Dea Nortia (').
Checché si pensi di quanto ho espresso intorno
ai rapporti di questa Dea con altre del Lazio e del-
l' Etruria, si dovrà convenire che la Dea Nortia non
è solo una divinità della Fortuna, ma una divinità
antichissima della terra, affine, come la Dea Bona, a
Cerere, a Persefone, alla Hekate ctonica e a Semele.
Ciò viene dimostrato non solo dall'essere a lei sacra
la scrofa, come alla Dea Bona e alla Dea Dia, equi-
valenti anch'esse a Cerere e Persefone, ma altresì
dall'epiteto di magna che le viene attribuito dalle
iscrizioni (2) e che la mette allo stesso livello della
magna mater deum, Cibele (Willmans, Kxempla, 125,
2414, 108, 113 ree). Credo pure, che avendo essa
tanti punti di contatto con la Dea Bona, al culto
di lei non siano stati estranei i misteri. La voragine
che si apre nel saeptum del Pozzarello, se non ha
riscontro esatto, come dicevo, in altri santuari affini,
ne rivela il suo carattere catactonico e ci richiama
al culto di Persefone e di Cerere. Nella parte delle
Thesmophoriae attiche, che si celebrava in forma mi-
steriosa al demo di Halimonte, i porci del sacrifizio
erano precipitati viventi in due fosse che si aprivano
nel pavimento del tempio e che erano dette %àa^ara
(') In una iscrizione Silvano è detto Lar Agrestis (Orelli
1601. Ann. Instit., 1866, p. 217). Il culto di Silvano non è estraneo
al territorio di Vulsinii; v. Notizie d. scavi 1880, p. 288,
n. 19 ; C- I. L. XI, 2689. Cade qui a proposito ricordare che
la statuetta di bronzo del Museo di Chiusi edita dall' Incili-
rami [Museo Chiusino, tav. XXII) deve considerarsi come rap-
presentazione della dea italica dei boschi e dei campi, affine
alla Nortia o la Nortia stessa, poiché oltre ad avere gli attri-
buti di questa, cioè la patera ombelicata e l'acerra, ha il capo
radiato alla foggiadHei Lares.
(•) C. I. L.Xl, 2685. D(eae)N{ortiae)M{agnae) S(anctae)cce.
Keinesius, I, 131, Magnete deae Nortiae.
t/"c Jì^iirjTQog xalt^g Kó^q (Harrison, Prolegomeaa,
p. 125). Del resto non possiamo presumere di ren-
derci ragione di ogni minimo particolare del culto
di Nortia, quando di esso non conosciamo quasi nulla.
Come il rito del ramo d'albero nel bosco di Alicia,
che resta ancora quasi incomprensibile, era proprio
della Diana Aricina (Cesario, Montini, dei Lincei,
XIII, col. 361 e segg.) e quello delle sortes era una
peculiarità del culto della Fortuna Prenestina (Prel-
ler, li. M*, II, p. 190, n. 1), così il §60q(k o %cea)ia
del Pozzarello deve aver avuto il suo valore e signi-
ficato nel culto catactonico della Dea Nortia, e in
questo trova la sua ragione di essere (').
Il rito del Pozzarello presenta poi una peculia-
rità che finora non era stata mai riscontrata, come
pare : 1' uso cioè di depositare la stipe votiva sotterra
in pozzetti di forma ellittica, scavati fino alla pro-
fondità dello strato di lapillo, e quello di versare uno
strato di calce in fondo alla buca, gettandovi poi
sopra la stipe. Quest' uso durò costante dalle origini
di quel sacellum, quando si usava di fare dei poz-
zetti molto piccoli, fino alla tarda età imperiale,
quando per il gran numero delle offerte i depositi
sacri avevano bisogno di grandi fosse, come quelle
scoperte verso l'angolo est del saeptum (2).
I molti coltellini di ferro e di bronzo compresi
nella stipe di tali depositi sacri hanno la nota forma
del coltello da sacrifizio, detto secespita, così frequento
sui bassorilievi dell'epoca romana (Daremb. et Saglio,
Diclionn. s. v. culter, p. 1585).
Se infine esaminiamo le rappresentazioni figurate
della Dea Nortia, rinvenute in questo scavo, trove-
remo che ve ne sono di più tipi.
Uno più frequente, con acerra e patera ombeli-
cata, che pare sia il più antico, riproducente forse la
(') La relazione fra il mondo terrestre e quello sotterra-
neo, espressa nel culto del Pozzarello per mezzo del Jó&qo; o
XÙofj.a, era espressa sotto altra forma nel culto della Dea Bona
e della ninfa Egeria, il cui carattere di dee mediatrici fra il
mondo sotterraneo e il terrestre è significato dalle pure acque
sgorganti dalla terra. C. I. L. VI, 65, 66, 67; Monum. dei
Lincei, XIII, col. 355.
(2) Non è la prima volta che si riscontra questo rito a
Bolsena. Il sig. Luigi Menichetti mi riferisce di avere sco-
perto molti anni fa sul Giglio (località a nord-est di Bulscna)
un pozzo sacro ripieno di stipe votiva, contenente in gran
parte ruzzi vasettini d'argilla, di cui parecchi egli ancora con
serva, che erano deposti in guisa da formare zone, divise da
strati di calce..
bolsena. scavi nel sacei.lum
230
anche di esso troviamo la perfetta spiegazione e la
ragione di essere fra la stipe del Pozzarello. Peroc-
ché i genii detti Lares, avanti di essere nella reli-
gione romana dei genii familiari e locali, pare che
siano stati in origine divinità della terra e dei campi,
come apprendiamo da Cicerone (Leg. II, 8, 19 ; 11, 27)
e Tibullo (I, 10,17). La leggenda che li addita come
figli di Acca Larentia, la stessa Dea Dia del culto
degli Arvali, rivela qual grande parte abbiano avuto
questi genii nei culti del Lazio e dell' Etruria, pre-
stati alla dea della terra, concepita in tutte le sue
molteplici manifestazioni, quindi anche nel culto della
Dea Nortia (').
Checché si pensi di quanto ho espresso intorno
ai rapporti di questa Dea con altre del Lazio e del-
l' Etruria, si dovrà convenire che la Dea Nortia non
è solo una divinità della Fortuna, ma una divinità
antichissima della terra, affine, come la Dea Bona, a
Cerere, a Persefone, alla Hekate ctonica e a Semele.
Ciò viene dimostrato non solo dall'essere a lei sacra
la scrofa, come alla Dea Bona e alla Dea Dia, equi-
valenti anch'esse a Cerere e Persefone, ma altresì
dall'epiteto di magna che le viene attribuito dalle
iscrizioni (2) e che la mette allo stesso livello della
magna mater deum, Cibele (Willmans, Kxempla, 125,
2414, 108, 113 ree). Credo pure, che avendo essa
tanti punti di contatto con la Dea Bona, al culto
di lei non siano stati estranei i misteri. La voragine
che si apre nel saeptum del Pozzarello, se non ha
riscontro esatto, come dicevo, in altri santuari affini,
ne rivela il suo carattere catactonico e ci richiama
al culto di Persefone e di Cerere. Nella parte delle
Thesmophoriae attiche, che si celebrava in forma mi-
steriosa al demo di Halimonte, i porci del sacrifizio
erano precipitati viventi in due fosse che si aprivano
nel pavimento del tempio e che erano dette %àa^ara
(') In una iscrizione Silvano è detto Lar Agrestis (Orelli
1601. Ann. Instit., 1866, p. 217). Il culto di Silvano non è estraneo
al territorio di Vulsinii; v. Notizie d. scavi 1880, p. 288,
n. 19 ; C- I. L. XI, 2689. Cade qui a proposito ricordare che
la statuetta di bronzo del Museo di Chiusi edita dall' Incili-
rami [Museo Chiusino, tav. XXII) deve considerarsi come rap-
presentazione della dea italica dei boschi e dei campi, affine
alla Nortia o la Nortia stessa, poiché oltre ad avere gli attri-
buti di questa, cioè la patera ombelicata e l'acerra, ha il capo
radiato alla foggiadHei Lares.
(•) C. I. L.Xl, 2685. D(eae)N{ortiae)M{agnae) S(anctae)cce.
Keinesius, I, 131, Magnete deae Nortiae.
t/"c Jì^iirjTQog xalt^g Kó^q (Harrison, Prolegomeaa,
p. 125). Del resto non possiamo presumere di ren-
derci ragione di ogni minimo particolare del culto
di Nortia, quando di esso non conosciamo quasi nulla.
Come il rito del ramo d'albero nel bosco di Alicia,
che resta ancora quasi incomprensibile, era proprio
della Diana Aricina (Cesario, Montini, dei Lincei,
XIII, col. 361 e segg.) e quello delle sortes era una
peculiarità del culto della Fortuna Prenestina (Prel-
ler, li. M*, II, p. 190, n. 1), così il §60q(k o %cea)ia
del Pozzarello deve aver avuto il suo valore e signi-
ficato nel culto catactonico della Dea Nortia, e in
questo trova la sua ragione di essere (').
Il rito del Pozzarello presenta poi una peculia-
rità che finora non era stata mai riscontrata, come
pare : 1' uso cioè di depositare la stipe votiva sotterra
in pozzetti di forma ellittica, scavati fino alla pro-
fondità dello strato di lapillo, e quello di versare uno
strato di calce in fondo alla buca, gettandovi poi
sopra la stipe. Quest' uso durò costante dalle origini
di quel sacellum, quando si usava di fare dei poz-
zetti molto piccoli, fino alla tarda età imperiale,
quando per il gran numero delle offerte i depositi
sacri avevano bisogno di grandi fosse, come quelle
scoperte verso l'angolo est del saeptum (2).
I molti coltellini di ferro e di bronzo compresi
nella stipe di tali depositi sacri hanno la nota forma
del coltello da sacrifizio, detto secespita, così frequento
sui bassorilievi dell'epoca romana (Daremb. et Saglio,
Diclionn. s. v. culter, p. 1585).
Se infine esaminiamo le rappresentazioni figurate
della Dea Nortia, rinvenute in questo scavo, trove-
remo che ve ne sono di più tipi.
Uno più frequente, con acerra e patera ombeli-
cata, che pare sia il più antico, riproducente forse la
(') La relazione fra il mondo terrestre e quello sotterra-
neo, espressa nel culto del Pozzarello per mezzo del Jó&qo; o
XÙofj.a, era espressa sotto altra forma nel culto della Dea Bona
e della ninfa Egeria, il cui carattere di dee mediatrici fra il
mondo sotterraneo e il terrestre è significato dalle pure acque
sgorganti dalla terra. C. I. L. VI, 65, 66, 67; Monum. dei
Lincei, XIII, col. 355.
(2) Non è la prima volta che si riscontra questo rito a
Bolsena. Il sig. Luigi Menichetti mi riferisce di avere sco-
perto molti anni fa sul Giglio (località a nord-est di Bulscna)
un pozzo sacro ripieno di stipe votiva, contenente in gran
parte ruzzi vasettini d'argilla, di cui parecchi egli ancora con
serva, che erano deposti in guisa da formare zone, divise da
strati di calce..