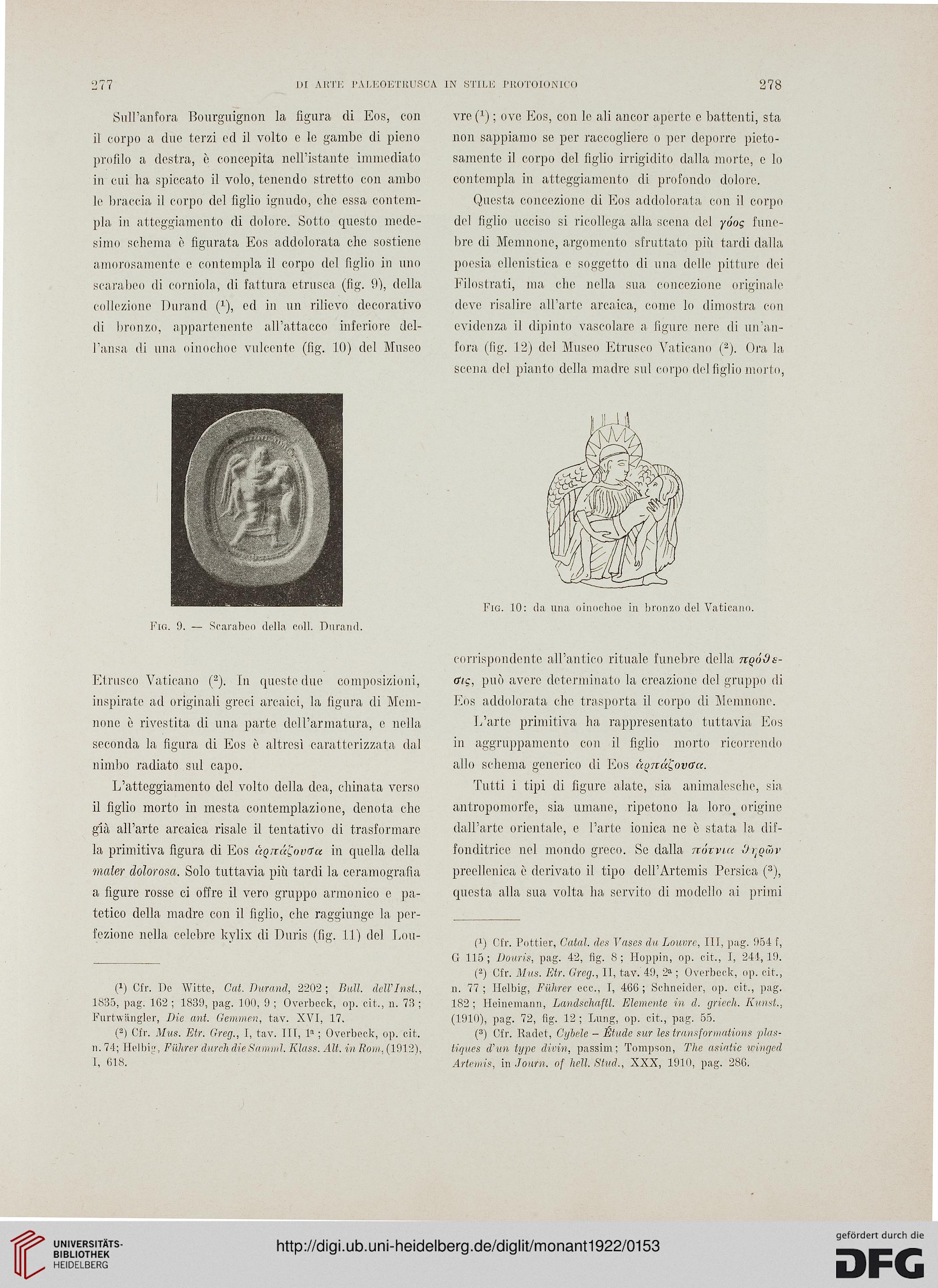]>[ ARTE L'ALEOETRUSCA IN STI LE PROTOIONICO
278
Sull'anfora Bourguignon la figura di Eos, con
il corpo a due terzi ed il volto e le gambe di pieno
profilo a destra, è concepita nell'istante immediato
in cui lui spiccato il volo, tenendo stretto con ambo
le braccia il corpo del figlio ignudo, che essa contem-
pla in atteggiamento di dolore. Sotto questo mede-
simo schema è figurata Eos addolorata che sostiene
amorosamente e contempla il corpo del figlio in uno
scarabeo di corniola, di fattura etnisca (fìg. 10, della,
collezione Durami (]), ed in un rilievo decorativo
di bronzo, appartenente all'attacco inferiore del-
l'ansa di una. oinochoe vulcente (fig. 10) del Museo
l'ic. '.). — Scarabeo della culi. Durami.
Etrusco Vaticano (2). In queste due composizioni,
inspirale ad originali greci arcaici, la figura di Meni-
none è rivestita di una parte dell'armatura, e nella
seconda la figura di Eos è altresì caratterizzala, dal
nimbo radiato sul capo.
L'atteggiamento del volto della dea, chinata verso
il figlio morto in mesta contemplazione, denota che
già all'arte arcaica risale il tentativo di trasformare
la primitiva figura di Eos ùona^ovta in quella della
maler dolorosa. Solo tuttavia più tardi la ceramografìa
a figure rosse ci offre il vero gruppo armonico e pa-
tetico della madre con il figlio, che raggiunge la per-
fezione nella celebre kylix di Duris (fìg. LI) del Lou-
C1) Cfr. De Wittc, Cat. Duranti, 2202 ; Bull. dell'Inst.,
1835, pag. 162 ; 1839, pag. 100, 9 ; Overbeck, op. eit., n. 73 ;
Furtwangler, Die aut. Gemmen, tav. XVI, 17.
(2) Cfr. Mus. Etr. Greg., I, tav. ITT, la ; Overbeck, op. eit.
n. 74; Helbig, Fuhrer duréh dieSamml. Klass. Alt. in Rom, (191:?),
I, 618.
vre (*) ; ove Eos, con le ali ancor aperte e battenti, sta
non sappiamo se per raccogliere o per deporre pieto-
samente il corpo del figlio irrigidito dalla morte, e lo
contempla in atteggiamento di profondo dolore.
Questa concezione di Eos addolorata con il corpo
del figlio ucciso si ricollega alla scena del yóog fune-
bre di Meninone, argomento sfruttato più tardi dalla
poesia ellenistica, e soggetto di una delle pitture dei
Filostrati, ma che nella sua concezione originale
deve risalire all'arte arcaica, come lo dimostra, con
evidenza il dipinto vascolare a ligure nere di un'an-
fora (fig. 12) del Museo Etrusco Vaticano (2). Ora la
scena del pianto della madre sul corpo del figlio morto(
Fig. 10: da una oinochoe in bronzo del Vaticani).
corrispondente all'antico rituale funebre della nQÓVt-
<Jig, può avere determinato la creazione del gruppo di
Eos addolorata che trasporta il corpo di Memnone.
L'arte primitiva ha rappresentato tuttavia Eos
in aggruppamento con il figlio morto ricorrendo
allo schema generico di Eos ùoncì£ovGa.
Tutti i tipi di figure alate, sia animalesche, sia
antropomorfe, sia umane, ripetono la loro> origine
dall'arte orientale, e l'arte ionica ne ò stata la dif-
fonditrice nel mondo greco. Se dalla nóxvict OrjQwv
preellenica è derivato il tipo dell'Artemis Persica (3),
questa alla sua volta ha servito di modello ai primi
(!) Cfr. Pottier, Calai, des Vasca da Louvre, III, pag. 954 f,
G 115; Douris, pag. 42, fig. 8; Hoppin, op. eit., I, 244,19.
(2) Cfr. Mus. Etr. Greg., II, tav. 49, 2» ; Overbeck, op. eit.,
n. 77 ; Ilelbig, Fuhrer ecc., I, 466 ; Schneider, op. eit, pag.
182; Heinemann, Landschaftl. Elemente in d. griech. Eunst.,
(1910), pag. 72, fìg. 12 ; Lung, op. cit., pag. 55.
(3) Cfr. Radet, Cylele - Étude sur les transformations plas-
tiques d'un type divin, passim; Tompson, The asiatic winged
Artemis, in Joufn. of hell. Stud., XXX, 1910, pag. 286.
278
Sull'anfora Bourguignon la figura di Eos, con
il corpo a due terzi ed il volto e le gambe di pieno
profilo a destra, è concepita nell'istante immediato
in cui lui spiccato il volo, tenendo stretto con ambo
le braccia il corpo del figlio ignudo, che essa contem-
pla in atteggiamento di dolore. Sotto questo mede-
simo schema è figurata Eos addolorata che sostiene
amorosamente e contempla il corpo del figlio in uno
scarabeo di corniola, di fattura etnisca (fìg. 10, della,
collezione Durami (]), ed in un rilievo decorativo
di bronzo, appartenente all'attacco inferiore del-
l'ansa di una. oinochoe vulcente (fig. 10) del Museo
l'ic. '.). — Scarabeo della culi. Durami.
Etrusco Vaticano (2). In queste due composizioni,
inspirale ad originali greci arcaici, la figura di Meni-
none è rivestita di una parte dell'armatura, e nella
seconda la figura di Eos è altresì caratterizzala, dal
nimbo radiato sul capo.
L'atteggiamento del volto della dea, chinata verso
il figlio morto in mesta contemplazione, denota che
già all'arte arcaica risale il tentativo di trasformare
la primitiva figura di Eos ùona^ovta in quella della
maler dolorosa. Solo tuttavia più tardi la ceramografìa
a figure rosse ci offre il vero gruppo armonico e pa-
tetico della madre con il figlio, che raggiunge la per-
fezione nella celebre kylix di Duris (fìg. LI) del Lou-
C1) Cfr. De Wittc, Cat. Duranti, 2202 ; Bull. dell'Inst.,
1835, pag. 162 ; 1839, pag. 100, 9 ; Overbeck, op. eit., n. 73 ;
Furtwangler, Die aut. Gemmen, tav. XVI, 17.
(2) Cfr. Mus. Etr. Greg., I, tav. ITT, la ; Overbeck, op. eit.
n. 74; Helbig, Fuhrer duréh dieSamml. Klass. Alt. in Rom, (191:?),
I, 618.
vre (*) ; ove Eos, con le ali ancor aperte e battenti, sta
non sappiamo se per raccogliere o per deporre pieto-
samente il corpo del figlio irrigidito dalla morte, e lo
contempla in atteggiamento di profondo dolore.
Questa concezione di Eos addolorata con il corpo
del figlio ucciso si ricollega alla scena del yóog fune-
bre di Meninone, argomento sfruttato più tardi dalla
poesia ellenistica, e soggetto di una delle pitture dei
Filostrati, ma che nella sua concezione originale
deve risalire all'arte arcaica, come lo dimostra, con
evidenza il dipinto vascolare a ligure nere di un'an-
fora (fig. 12) del Museo Etrusco Vaticano (2). Ora la
scena del pianto della madre sul corpo del figlio morto(
Fig. 10: da una oinochoe in bronzo del Vaticani).
corrispondente all'antico rituale funebre della nQÓVt-
<Jig, può avere determinato la creazione del gruppo di
Eos addolorata che trasporta il corpo di Memnone.
L'arte primitiva ha rappresentato tuttavia Eos
in aggruppamento con il figlio morto ricorrendo
allo schema generico di Eos ùoncì£ovGa.
Tutti i tipi di figure alate, sia animalesche, sia
antropomorfe, sia umane, ripetono la loro> origine
dall'arte orientale, e l'arte ionica ne ò stata la dif-
fonditrice nel mondo greco. Se dalla nóxvict OrjQwv
preellenica è derivato il tipo dell'Artemis Persica (3),
questa alla sua volta ha servito di modello ai primi
(!) Cfr. Pottier, Calai, des Vasca da Louvre, III, pag. 954 f,
G 115; Douris, pag. 42, fig. 8; Hoppin, op. eit., I, 244,19.
(2) Cfr. Mus. Etr. Greg., II, tav. 49, 2» ; Overbeck, op. eit.,
n. 77 ; Ilelbig, Fuhrer ecc., I, 466 ; Schneider, op. eit, pag.
182; Heinemann, Landschaftl. Elemente in d. griech. Eunst.,
(1910), pag. 72, fìg. 12 ; Lung, op. cit., pag. 55.
(3) Cfr. Radet, Cylele - Étude sur les transformations plas-
tiques d'un type divin, passim; Tompson, The asiatic winged
Artemis, in Joufn. of hell. Stud., XXX, 1910, pag. 286.