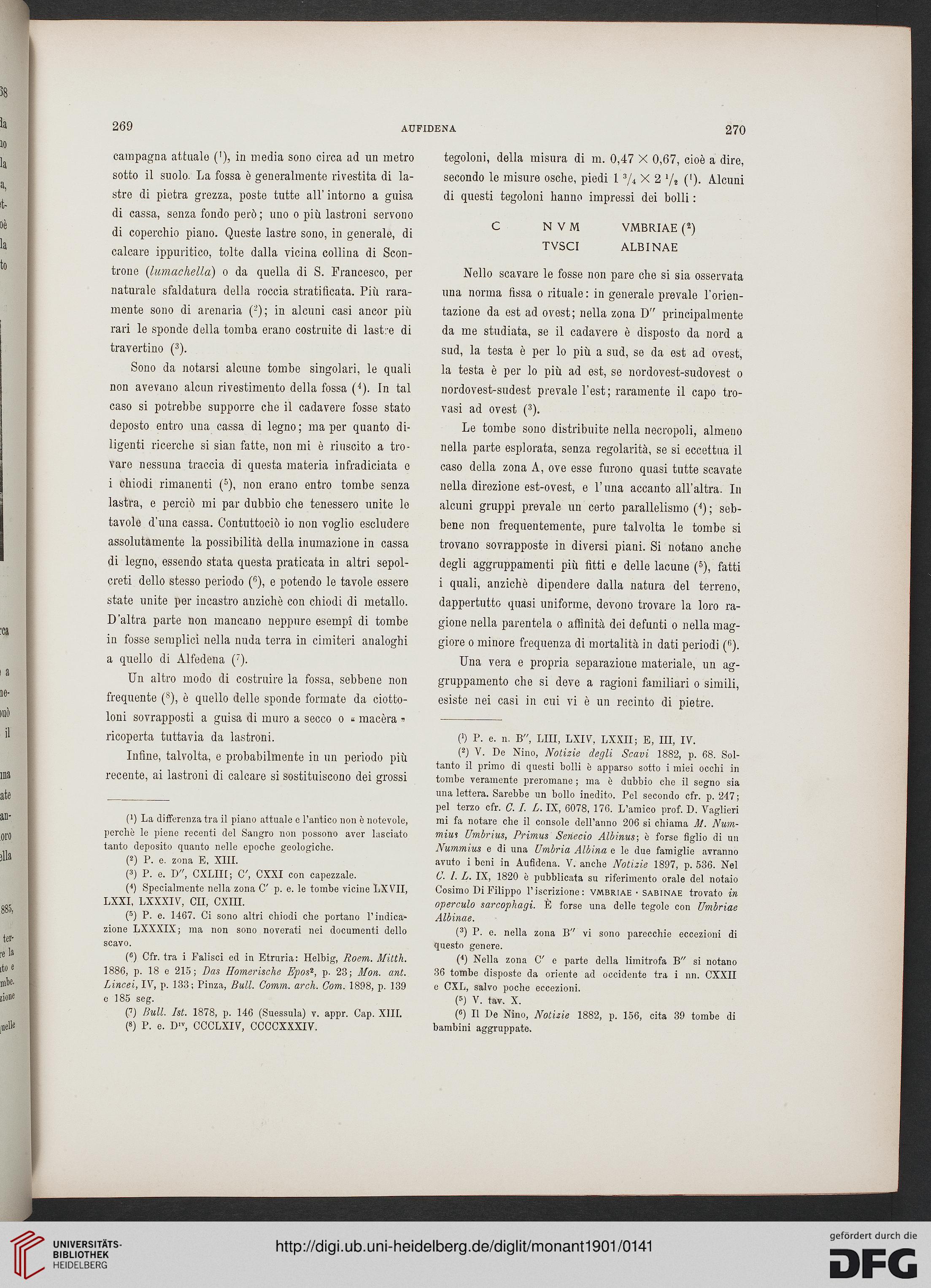269
AUFIDENA
270
campagna attualo ('), in media sono circa ad un metro
sotto il suolo. La fossa è generalmente rivestita di la-
stre di pietra grezza, poste tutte all' intorno a guisa
di cassa, senza fondo però; uno o più lastroni servono
di coperchio piano. Queste lastre sono, in generale, di
calcare ippuritico, tolte dalla vicina collina di Scon-
trone {lumachella) o da quella di S. Francesco, per
naturale sfaldatura della roccia stratificata. Più rara-
mente sono di arenaria (-); in alcuni casi ancor più
rari le sponde della tomba erano costruite di lastre di
travertino (3).
Sono da notarsi alcune tombe singolari, le quali
non avevano alcun rivestimento della fossa (4). In tal
caso si potrebbe supporre che il cadavere fosse stato
deposto entro una cassa di legno; ma per quanto di-
ligenti ricerche si sian fatte, non mi è riuscito a tro-
vare nessuna traccia di questa materia infradiciata e
i chiodi rimanenti (5), non erano entro tombe senza
lastra, e perciò mi par dubbio che tenessero unite lo
tavole d'una cassa. Contuttociò io non voglio escludere
assolutamente la possibilità della inumazione in cassa
di legno, essendo stata questa praticata in altri sepol-
creti dello stesso periodo (r>), e potendo le tavole essere
state unite per incastro anziché con chiodi di metallo.
D'altra parte non mancano neppure esempì di tombe
in fosse semplici nella nuda terra in cimiteri analoghi
a quello di Alfedena (").
Un altro modo di costruire la fossa, sebbene non
frequente (8), è quello delle sponde formate da ciotto-
loni sovrapposti a guisa di muro a secco o « macèra *
ricoperta tuttavia da lastroni.
Infine, talvolta, e probabilmente in un periodo più
recente, ai lastroni di calcare si sostituiscono dei grossi
(') La differenza tra il piano attuale e l'antico non è notevole,
perchè le piene recenti del Sangro non possono aver lasciato
tanto deposito quanto nelle epoche geologiche.
(2) P. e. zona E. XIII.
(3) P. e. B", CXLLU; C, CXXI con capezzale.
(4) Specialmente nella zona C p. e. le tombe vicine LXVII,
LXXI, LXXXIV, CU, CXIH.
(5) P. e. 1467. Ci sono altri chiodi che portano l'indica-
zione LXXXIX; ma non sono noverati nei documenti dello
scavo.
(6) Cfr. tra i Falisci ed in Etruria: Helbig, Roem. Mitth.
1886, p. 18 e 215; Das Homerische Epos9, p. 23; Mon. ant.
Lincei, IV, p. 133; Pinza, Bull. Comm. arch. Gom. 1898, p. 139
e 185 seg.
(7) Bull. Jst. 1878, p. 146 (Suessula) v. appr. Cap. XIII.
(«) P. e. DIT, CCCLXIV, CCCCXXXIV.
tegoloni, della misura di m. 0,47 X 0,67, cioè a dire,
secondo le misure osche, piedi 13/4 X21/, (')• Alcuni
di questi tegoloni hanno impressi dei bolli :
C N V M VMBRIAE (2)
TVSCI ALBINAE
Nello scavare le fosse non pare che si sia osservata
una norma fissa o rituale: in generale prevale l'orien-
tazione da est ad ovest; nella zona D" principalmente
da me studiata, se il cadavere è disposto da nord a
sud, la testa è per lo più a sud, se da est ad ovest,
la testa è per lo più ad est, se nordovest-sudovest o
nordovest-sudest prevale l'est; raramente il capo tro-
vasi ad ovest (3).
Le tombe sono distribuite nella necropoli, almeno
nella parte esplorata, senza regolarità, se si eccettua il
caso della zona A, ove esse furono quasi tutte scavate
nella direzione est-ovest, e l'ima accanto all'altra. In
alcuni gruppi prevale un certo parallelismo (4) ; seb-
bene non frequentemente, pure talvolta le tombe si
trovano sovrapposte in diversi piani. Si notano anche
degli aggruppamenti più fitti e delle lacune (5), fatti
i quali, anziché dipendere dalla natura del terreno,
dappertutto quasi uniforme, devono trovare la loro ra-
gione nella parentela o affinità dei defunti o nella mag-
giore o minore frequenza di mortalità in dati periodi (fi).
Una vera e propria separazione materiale, un ag-
gruppamento che si deve a ragioni familiari o simili,
esiste nei casi in cui vi è un recinto di pietre.
(') P. e. n. B", LUI, LXIV", LXXH; E, III, IV.
(2) V. De Nino, Notizie degli Scavi 1882, p. 68. Sol-
tanto il primo di questi bolli è apparso sotto i miei occhi in
tombe veramente preromane ; ma è dubbio che il segno sia
una lettera. Sarebbe un bollo inedito. Pel secondo cfr. p. 247 ;
pel terzo cfr. C. I. L. IX, 6078, 176. L'amico prof. D. Vaglieri
mi fa notare che il console dell'anno 206 si chiama M. Num-
miui Umbrius, Primus Seriecio Albinus; è forse figlio di un
Nummius e di una Umbria Albina e le due famiglie avranno
avuto i beni in Aufìdena. V. anche Notizie 1897, p. 536. Nel
C. I. L. IX, 1820 è pubblicata su riferimento orale del notaio
Cosimo Di Filippo l'iscrizione: vmbriae • sabinae trovato in
operculo sarcophagi. E forse una delle tegole con Umbriae
Albinae.
(3) P. e. nella zona B" vi sono parecchie eccezioni di
questo genere.
(4) Nella zona C e parte della limitrofa B" si notano
36 tombe disposte da oriente ad occidente tra i un. CXXII
e CXL, salvo poche eccezioni.
(5) V. tav. X.
(«) Il De Nino, Notizie 1882, p. 156, cita 39 tombe di
bambini aggruppate.
AUFIDENA
270
campagna attualo ('), in media sono circa ad un metro
sotto il suolo. La fossa è generalmente rivestita di la-
stre di pietra grezza, poste tutte all' intorno a guisa
di cassa, senza fondo però; uno o più lastroni servono
di coperchio piano. Queste lastre sono, in generale, di
calcare ippuritico, tolte dalla vicina collina di Scon-
trone {lumachella) o da quella di S. Francesco, per
naturale sfaldatura della roccia stratificata. Più rara-
mente sono di arenaria (-); in alcuni casi ancor più
rari le sponde della tomba erano costruite di lastre di
travertino (3).
Sono da notarsi alcune tombe singolari, le quali
non avevano alcun rivestimento della fossa (4). In tal
caso si potrebbe supporre che il cadavere fosse stato
deposto entro una cassa di legno; ma per quanto di-
ligenti ricerche si sian fatte, non mi è riuscito a tro-
vare nessuna traccia di questa materia infradiciata e
i chiodi rimanenti (5), non erano entro tombe senza
lastra, e perciò mi par dubbio che tenessero unite lo
tavole d'una cassa. Contuttociò io non voglio escludere
assolutamente la possibilità della inumazione in cassa
di legno, essendo stata questa praticata in altri sepol-
creti dello stesso periodo (r>), e potendo le tavole essere
state unite per incastro anziché con chiodi di metallo.
D'altra parte non mancano neppure esempì di tombe
in fosse semplici nella nuda terra in cimiteri analoghi
a quello di Alfedena (").
Un altro modo di costruire la fossa, sebbene non
frequente (8), è quello delle sponde formate da ciotto-
loni sovrapposti a guisa di muro a secco o « macèra *
ricoperta tuttavia da lastroni.
Infine, talvolta, e probabilmente in un periodo più
recente, ai lastroni di calcare si sostituiscono dei grossi
(') La differenza tra il piano attuale e l'antico non è notevole,
perchè le piene recenti del Sangro non possono aver lasciato
tanto deposito quanto nelle epoche geologiche.
(2) P. e. zona E. XIII.
(3) P. e. B", CXLLU; C, CXXI con capezzale.
(4) Specialmente nella zona C p. e. le tombe vicine LXVII,
LXXI, LXXXIV, CU, CXIH.
(5) P. e. 1467. Ci sono altri chiodi che portano l'indica-
zione LXXXIX; ma non sono noverati nei documenti dello
scavo.
(6) Cfr. tra i Falisci ed in Etruria: Helbig, Roem. Mitth.
1886, p. 18 e 215; Das Homerische Epos9, p. 23; Mon. ant.
Lincei, IV, p. 133; Pinza, Bull. Comm. arch. Gom. 1898, p. 139
e 185 seg.
(7) Bull. Jst. 1878, p. 146 (Suessula) v. appr. Cap. XIII.
(«) P. e. DIT, CCCLXIV, CCCCXXXIV.
tegoloni, della misura di m. 0,47 X 0,67, cioè a dire,
secondo le misure osche, piedi 13/4 X21/, (')• Alcuni
di questi tegoloni hanno impressi dei bolli :
C N V M VMBRIAE (2)
TVSCI ALBINAE
Nello scavare le fosse non pare che si sia osservata
una norma fissa o rituale: in generale prevale l'orien-
tazione da est ad ovest; nella zona D" principalmente
da me studiata, se il cadavere è disposto da nord a
sud, la testa è per lo più a sud, se da est ad ovest,
la testa è per lo più ad est, se nordovest-sudovest o
nordovest-sudest prevale l'est; raramente il capo tro-
vasi ad ovest (3).
Le tombe sono distribuite nella necropoli, almeno
nella parte esplorata, senza regolarità, se si eccettua il
caso della zona A, ove esse furono quasi tutte scavate
nella direzione est-ovest, e l'ima accanto all'altra. In
alcuni gruppi prevale un certo parallelismo (4) ; seb-
bene non frequentemente, pure talvolta le tombe si
trovano sovrapposte in diversi piani. Si notano anche
degli aggruppamenti più fitti e delle lacune (5), fatti
i quali, anziché dipendere dalla natura del terreno,
dappertutto quasi uniforme, devono trovare la loro ra-
gione nella parentela o affinità dei defunti o nella mag-
giore o minore frequenza di mortalità in dati periodi (fi).
Una vera e propria separazione materiale, un ag-
gruppamento che si deve a ragioni familiari o simili,
esiste nei casi in cui vi è un recinto di pietre.
(') P. e. n. B", LUI, LXIV", LXXH; E, III, IV.
(2) V. De Nino, Notizie degli Scavi 1882, p. 68. Sol-
tanto il primo di questi bolli è apparso sotto i miei occhi in
tombe veramente preromane ; ma è dubbio che il segno sia
una lettera. Sarebbe un bollo inedito. Pel secondo cfr. p. 247 ;
pel terzo cfr. C. I. L. IX, 6078, 176. L'amico prof. D. Vaglieri
mi fa notare che il console dell'anno 206 si chiama M. Num-
miui Umbrius, Primus Seriecio Albinus; è forse figlio di un
Nummius e di una Umbria Albina e le due famiglie avranno
avuto i beni in Aufìdena. V. anche Notizie 1897, p. 536. Nel
C. I. L. IX, 1820 è pubblicata su riferimento orale del notaio
Cosimo Di Filippo l'iscrizione: vmbriae • sabinae trovato in
operculo sarcophagi. E forse una delle tegole con Umbriae
Albinae.
(3) P. e. nella zona B" vi sono parecchie eccezioni di
questo genere.
(4) Nella zona C e parte della limitrofa B" si notano
36 tombe disposte da oriente ad occidente tra i un. CXXII
e CXL, salvo poche eccezioni.
(5) V. tav. X.
(«) Il De Nino, Notizie 1882, p. 156, cita 39 tombe di
bambini aggruppate.