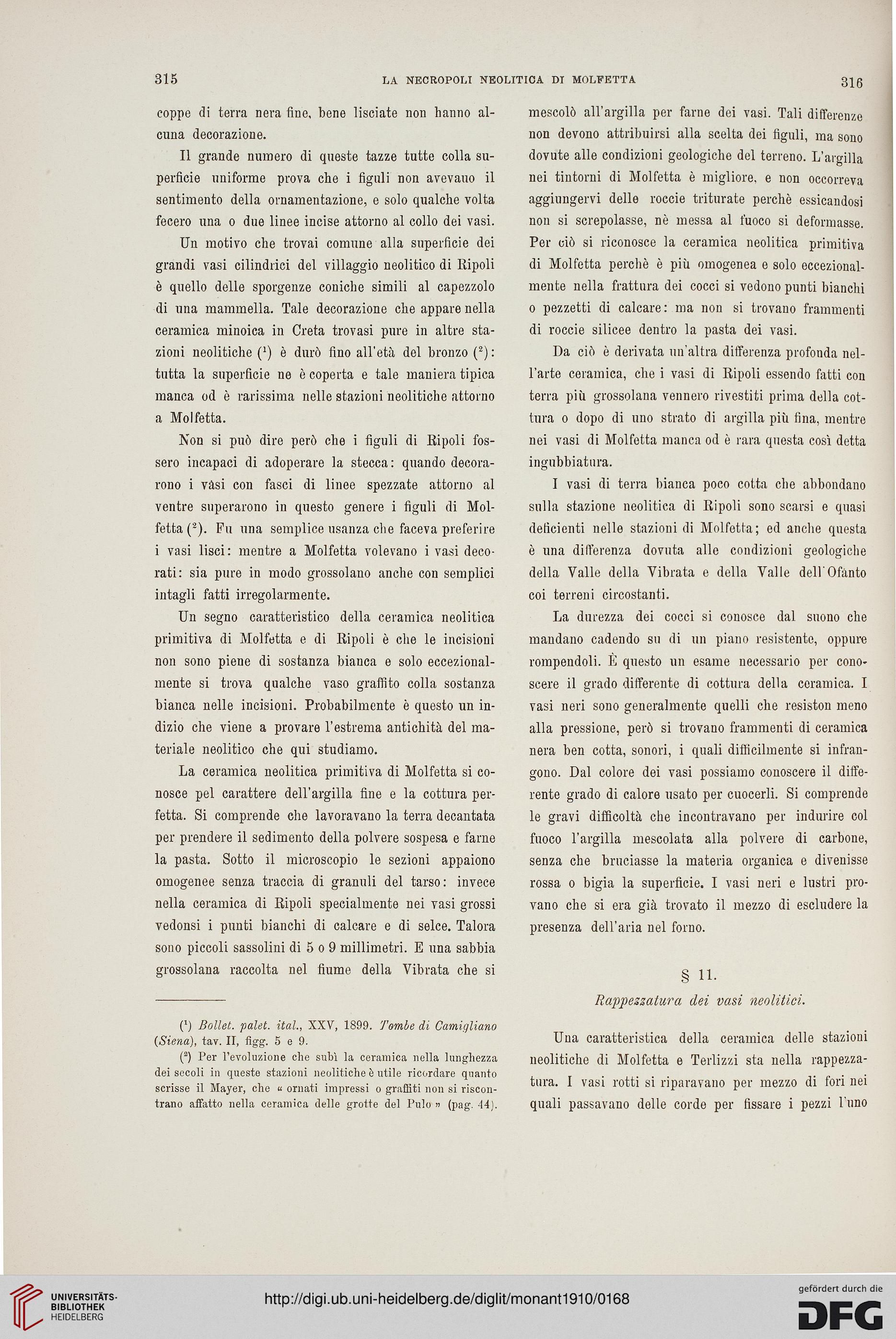315
LA NECROPOLI NEOLITICA DI MOLFETTA
316
coppe di terra nera fine, bene lisciate non hanno al-
cuna decorazione.
Il grande numero di queste tazze tutte colla su-
perficie uniforme prova che i figlili non avevano il
sentimento della ornamentazione, e solo qualche volta
fecero una o due linee incise attorno al collo dei vasi.
Un motivo che trovai comune alla superficie dei
grandi vasi cilindrici del villaggio neolitico di Ripoli
è quello delle sporgenze coniche simili al capezzolo
di una mammella. Tale decorazione che appare nella
ceramica minoica in Creta trovasi pure in altre sta-
zioni neolitiche (') è durò fino all'età del bronzo (2):
tutta la superficie ne è coperta e tale maniera tipica
manca od è rarissima nelle stazioni neolitiche attorno
a Molfetta.
Non si può dire però che i figuli di Ripoli fos-
sero incapaci di adoperare la stecca: quando decora-
rono i vasi con fasci di linee spezzate attorno al
ventre superarono in questo genere i figuli di Mol-
fetta (2). Fu una semplice usanza che faceva preferire
i vasi lisci: mentre a Molfetta volevano i vasi deco-
rati: sia pure in modo grossolano anche con semplici
intagli fatti irregolarmente.
Un segno caratteristico della ceramica neolitica
primitiva di Molfetta e di Ripoli è che le incisioni
non sono piene di sostanza bianca e solo eccezional-
mente si trova qualche vaso graffito colla sostanza
bianca nelle incisioni. Probabilmente è questo un in-
dizio che viene a provare l'estrema antichità del ma-
teriale neolitico che qui studiamo.
La ceramica neolitica primitiva di Molfetta si co-
nosce pel carattere dell'argilla fine e la cottura per-
fetta. Si comprende che lavoravano la terra decantata
per prendere il sedimento della polvere sospesa e farne
la pasta. Sotto il microscopio le sezioni appaiono
omogenee senza traccia di granuli del tarso: invece
nella ceramica di Ripoli specialmente nei vasi grossi
vedonsi i punti bianchi di calcare e di selce. Talora
sono piccoli sassolini di 5 o 9 millimetri. E una sabbia
grossolana raccolta nel fiume della Vibrata che si
(') Bollet. palet. ital., XXV, 1899. Tombe di Camigliano
(Siena), tav. II, figg. 5 e 9.
(2) Per l'evoluzione che subì la ceramica nella lunghezza
dei secoli in queste stazioni neolitiche è utile ricordare quanto
scrisse il Mayer, che « ornati impressi o graffiti non si riscon-
trano affatto nella ceramica delle grotte del Pulo » (pag. 44).
mescolò all'argilla per farne dei vasi. Tali differenze
non devono attribuirsi alla scelta dei figuli, ma sono
dovute alle condizioni geologiche del terreno. L'argilla
nei tintomi di Molfetta è migliore, e non occorreva
aggiungervi delle roccie triturate perchè essicandosi
non si screpolasse, nè messa al fuoco si deformasse.
Per ciò si riconosce la ceramica neolitica primitiva
di Molfetta perchè è più omogenea e solo eccezional-
mente nella frattura dei cocci si vedono punti bianchi
o pezzetti di calcare: ma non si trovano frammenti
di roccie silicee dentro la pasta dei vasi.
Da ciò è derivata un'altra differenza profonda nel-
l'arte ceramica, che i vasi di Ripoli essendo fatti con
terra più grossolana vennero rivestiti prima della cot-
tura o dopo di uno strato di argilla più fina, mentre
nei vasi di Molfetta manca od è rara questa così detta
ingubbiatura.
I vasi di terra bianca poco cotta che abbondano
sulla stazione neolitica di Ripoli sono scarsi e quasi
deficienti nelle stazioni di Molfetta; ed anche questa
è una differenza dovuta alle condizioni geologiche
della Valle della Vibrata e della Valle dell'Ofànto
coi terreni circostanti.
La durezza dei cocci si conosce dal suono che
mandano cadendo su di un piano resistente, oppure
rompendoli. È questo un esame necessario per cono-
scere il grado differente di cottura della ceramica. I
vasi neri sono generalmente quelli che resiston meno
alla pressione, però si trovano frammenti di ceramica
nera ben cotta, sonori, i quali difficilmente si infran-
gono. Dal colore dei vasi possiamo conoscere il diffe-
rente grado di calore usato per cuocerli. Si comprende
le gravi difficoltà che incontravano per indurire col
fuoco l'argilla mescolata alla polvere di carbone,
senza che bruciasse la materia organica e divenisse
rossa o bigia la superficie. I vasi neri e lustri pro-
vano che si era già trovato il mezzo di escludere la
presenza dell'aria nel forno.
§ n.
Rappezzatura dei vasi neolitici.
Una caratteristica della ceramica delle stazioni
neolitiche di Molfetta e Terlizzi sta nella rappezza-
tura. I vasi rotti si riparavano per mezzo di fori nei
quali passavano delle corde per fissare i pezzi l'uno
LA NECROPOLI NEOLITICA DI MOLFETTA
316
coppe di terra nera fine, bene lisciate non hanno al-
cuna decorazione.
Il grande numero di queste tazze tutte colla su-
perficie uniforme prova che i figlili non avevano il
sentimento della ornamentazione, e solo qualche volta
fecero una o due linee incise attorno al collo dei vasi.
Un motivo che trovai comune alla superficie dei
grandi vasi cilindrici del villaggio neolitico di Ripoli
è quello delle sporgenze coniche simili al capezzolo
di una mammella. Tale decorazione che appare nella
ceramica minoica in Creta trovasi pure in altre sta-
zioni neolitiche (') è durò fino all'età del bronzo (2):
tutta la superficie ne è coperta e tale maniera tipica
manca od è rarissima nelle stazioni neolitiche attorno
a Molfetta.
Non si può dire però che i figuli di Ripoli fos-
sero incapaci di adoperare la stecca: quando decora-
rono i vasi con fasci di linee spezzate attorno al
ventre superarono in questo genere i figuli di Mol-
fetta (2). Fu una semplice usanza che faceva preferire
i vasi lisci: mentre a Molfetta volevano i vasi deco-
rati: sia pure in modo grossolano anche con semplici
intagli fatti irregolarmente.
Un segno caratteristico della ceramica neolitica
primitiva di Molfetta e di Ripoli è che le incisioni
non sono piene di sostanza bianca e solo eccezional-
mente si trova qualche vaso graffito colla sostanza
bianca nelle incisioni. Probabilmente è questo un in-
dizio che viene a provare l'estrema antichità del ma-
teriale neolitico che qui studiamo.
La ceramica neolitica primitiva di Molfetta si co-
nosce pel carattere dell'argilla fine e la cottura per-
fetta. Si comprende che lavoravano la terra decantata
per prendere il sedimento della polvere sospesa e farne
la pasta. Sotto il microscopio le sezioni appaiono
omogenee senza traccia di granuli del tarso: invece
nella ceramica di Ripoli specialmente nei vasi grossi
vedonsi i punti bianchi di calcare e di selce. Talora
sono piccoli sassolini di 5 o 9 millimetri. E una sabbia
grossolana raccolta nel fiume della Vibrata che si
(') Bollet. palet. ital., XXV, 1899. Tombe di Camigliano
(Siena), tav. II, figg. 5 e 9.
(2) Per l'evoluzione che subì la ceramica nella lunghezza
dei secoli in queste stazioni neolitiche è utile ricordare quanto
scrisse il Mayer, che « ornati impressi o graffiti non si riscon-
trano affatto nella ceramica delle grotte del Pulo » (pag. 44).
mescolò all'argilla per farne dei vasi. Tali differenze
non devono attribuirsi alla scelta dei figuli, ma sono
dovute alle condizioni geologiche del terreno. L'argilla
nei tintomi di Molfetta è migliore, e non occorreva
aggiungervi delle roccie triturate perchè essicandosi
non si screpolasse, nè messa al fuoco si deformasse.
Per ciò si riconosce la ceramica neolitica primitiva
di Molfetta perchè è più omogenea e solo eccezional-
mente nella frattura dei cocci si vedono punti bianchi
o pezzetti di calcare: ma non si trovano frammenti
di roccie silicee dentro la pasta dei vasi.
Da ciò è derivata un'altra differenza profonda nel-
l'arte ceramica, che i vasi di Ripoli essendo fatti con
terra più grossolana vennero rivestiti prima della cot-
tura o dopo di uno strato di argilla più fina, mentre
nei vasi di Molfetta manca od è rara questa così detta
ingubbiatura.
I vasi di terra bianca poco cotta che abbondano
sulla stazione neolitica di Ripoli sono scarsi e quasi
deficienti nelle stazioni di Molfetta; ed anche questa
è una differenza dovuta alle condizioni geologiche
della Valle della Vibrata e della Valle dell'Ofànto
coi terreni circostanti.
La durezza dei cocci si conosce dal suono che
mandano cadendo su di un piano resistente, oppure
rompendoli. È questo un esame necessario per cono-
scere il grado differente di cottura della ceramica. I
vasi neri sono generalmente quelli che resiston meno
alla pressione, però si trovano frammenti di ceramica
nera ben cotta, sonori, i quali difficilmente si infran-
gono. Dal colore dei vasi possiamo conoscere il diffe-
rente grado di calore usato per cuocerli. Si comprende
le gravi difficoltà che incontravano per indurire col
fuoco l'argilla mescolata alla polvere di carbone,
senza che bruciasse la materia organica e divenisse
rossa o bigia la superficie. I vasi neri e lustri pro-
vano che si era già trovato il mezzo di escludere la
presenza dell'aria nel forno.
§ n.
Rappezzatura dei vasi neolitici.
Una caratteristica della ceramica delle stazioni
neolitiche di Molfetta e Terlizzi sta nella rappezza-
tura. I vasi rotti si riparavano per mezzo di fori nei
quali passavano delle corde per fissare i pezzi l'uno