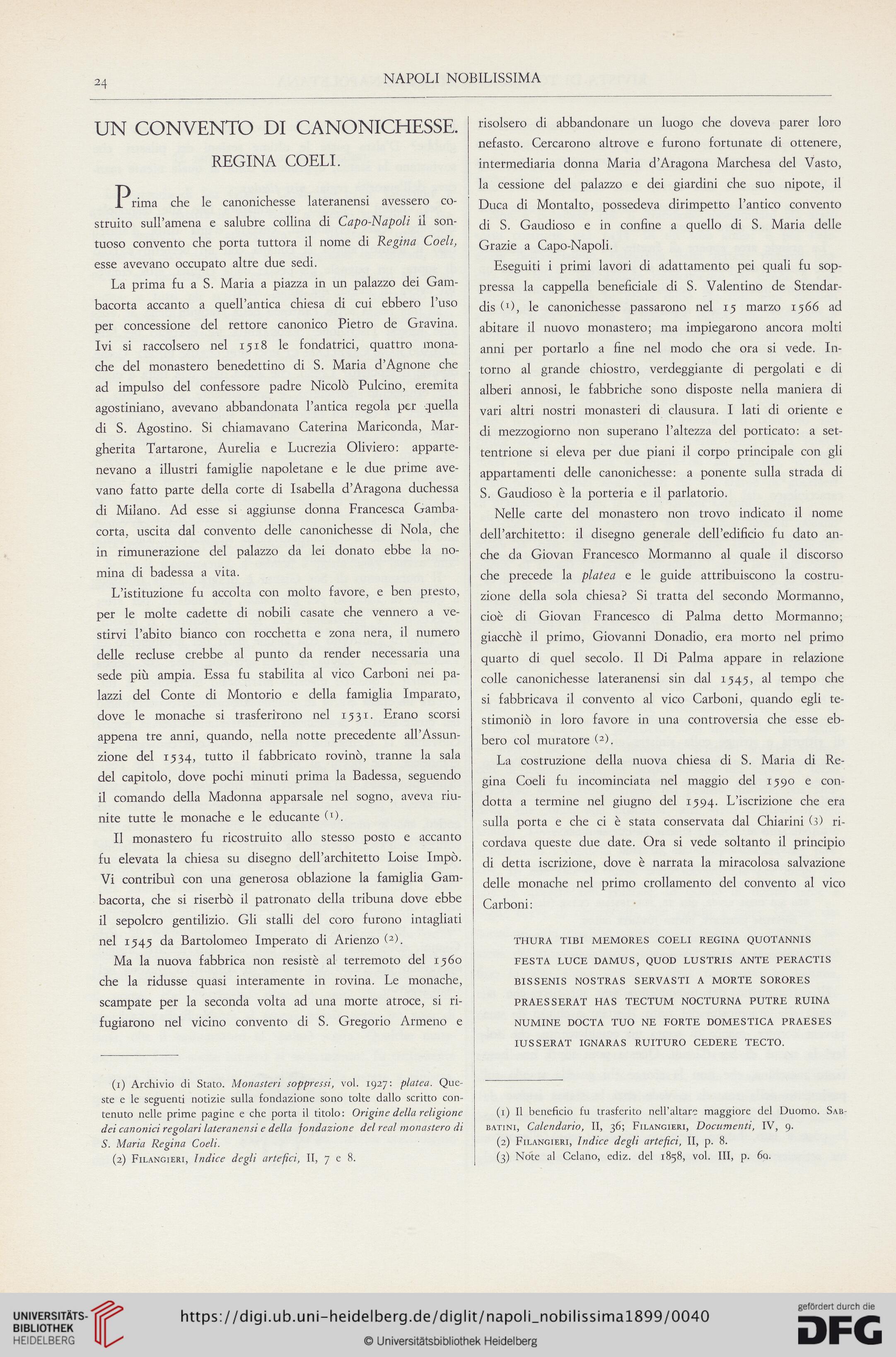24
NAPOLI NOBILISSIMA
UN CONVENTO DI CANONICHESSE.
REGINA COELI.
Prima che le canonichesse lateranensi avessero co-
struito sull'amena e salubre collina di Capo-Napoli il son-
tuoso convento che porta tuttora il nome di Regina Coeli,
esse avevano occupato altre due sedi.
La prima fu a S. Maria a piazza in un palazzo dei Gam-
bacorta accanto a quell'antica chiesa di cui ebbero l'uso
per concessione del rettore canonico Pietro de Gravina.
Ivi si raccolsero nel 1518 le fondatrici, quattro mona-
che del monastero benedettino di S. Maria d'Agnone che
ad impulso del confessore padre Nicolò Pulcino, eremita
agostiniano, avevano abbandonata l'antica regola per quella
di S. Agostino. Si chiamavano Caterina Mariconda, Mar-
gherita Tartarone, Aurelia e Lucrezia Oliviero: apparte-
nevano a illustri famiglie napoletane e le due prime ave-
vano fatto parte della corte di Isabella d'Aragona duchessa
di Milano. Ad esse si aggiunse donna Francesca Gamba-
corta, uscita dal convento delle canonichesse di Nola, che
in rimunerazione del palazzo da lei donato ebbe la no-
mina di badessa a vita.
L'istituzione fu accolta con molto favore, e ben presto,
per le molte cadette di nobili casate che vennero a ve-
stirvi l'abito bianco con rocchetta e zona nera, il numero
delle recluse crebbe al punto da render necessaria una
sede più ampia. Essa fu stabilita al vico Carboni nei pa-
lazzi del Conte di Montorio e della famiglia Imparato,
dove le monache si trasferirono nel 1531. Erano scorsi
appena tre anni, quando, nella notte precedente all'Assun-
zione del 1534, tutto il fabbricato rovinò, tranne la sala
del capitolo, dove pochi minuti prima la Badessa, seguendo
il comando della Madonna apparsale nel sogno, aveva riu-
nite tutte le monache e le educante (0.
Il monastero fu ricostruito allo stesso posto e accanto
fu elevata la chiesa su disegno dell'architetto Loise Impò.
Vi contribuì con una generosa oblazione la famiglia Gam-
bacorta, che si riserbò il patronato della tribuna dove ebbe
il sepolcro gentilizio. Gli stalli del coro furono intagliati
nel 1545 da Bartolomeo Imperato di Arienzo (2).
Ma la nuova fabbrica non resistè al terremoto del 1,60
che la ridusse quasi interamente in rovina. Le monache,
scampate per la seconda volta ad una morte atroce, si ri-
fugiarono nel vicino convento di S. Gregorio Armeno e
risolsero di abbandonare un luogo che doveva parer loro
nefasto. Cercarono altrove e furono fortunate di ottenere,
intermediaria donna Maria d'Aragona Marchesa del Vasto,
la cessione del palazzo e dei giardini che suo nipote, il
Duca di Montalto, possedeva dirimpetto l'antico convento
di S. Gaudioso e in confine a quello di S. Maria delle
Grazie a Capo-Napoli.
Eseguiti i primi lavori di adattamento pei quali fu sop-
pressa la cappella beneficiale di S. Valentino de Stendar-
dis C), le canonichesse passarono nel 15 marzo 1566 ad
abitare il nuovo monastero; ma impiegarono ancora molti
anni per portarlo a fine nel modo che ora si vede. In-
torno al grande chiostro, verdeggiante di pergolati e di
alberi annosi, le fabbriche sono disposte nella maniera di
vari altri nostri monasteri di clausura. I lati di oriente e
di mezzogiorno non superano l'altezza del porticato: a set-
tentrione si eleva per due piani il corpo principale con gli
appartamenti delle canonichesse: a ponente sulla strada di
S. Gaudioso è la porteria e il parlatorio.
Nelle carte del monastero non trovo indicato il nome
dell'architetto: il disegno generale dell'edificio fu dato an-
che da Giovan Francesco Mormanno al quale il discorso
che precede la platea e le guide attribuiscono la costru-
zione della sola chiesa? Si tratta del secondo Mormanno,
cioè di Giovan Francesco di Palma detto Mormanno;
giacché il primo, Giovanni Donadio, era morto nel primo
quarto di quel secolo. Il Di Palma appare in relazione
colle canonichesse lateranensi sin dal 1545, al tempo che
si fabbricava il convento al vico Carboni, quando egli te-
stimoniò in loro favore in una controversia che esse eb-
bero col muratore (2).
La costruzione della nuova chiesa di S. Maria di Re-
gina Coeli fu incominciata nel maggio del 1590 e con-
dotta a termine nel giugno del 1594. L'iscrizione che era
sulla porta e che ci è stata conservata dal Chiarini (3) ri-
cordava queste due date. Ora si vede soltanto il principio
di detta iscrizione, dove è narrata la miracolosa salvazione
delle monache nel primo crollamento del convento al vico
Carboni:
THURA TIBI MEMORES COELI REGINA QUOTANNIS
FESTA LUCE DAMUS, QUOD LUSTRIS ANTE PERACTIS
BISSENIS NOSTRAS SERVASTI A MORTE SORORES
PRAESSERAT HAS TECTUM NOCTURNA PUTRE RUINA
NUMINE DOCTA TUO NE FORTE DOMESTICA PRAESES
IUSSERAT IGNARAS RUITURO CEDERE TECTO.
(1) Archivio di Stato. Monasteri soppressi, voi. 1927: platea. Que-
ste e le seguenti notizie sulla fondazione sono tolte dallo scritto con-
tenuto nelle prime pagine e che porta il titolo: Origine della religione
dei canonici regolari lateranensi e della fondazione del real monastero di
S. Maria Regina Coeli.
(2) Filangieri, Indice degli artefici, II, 7 e 8.
(1) Il beneficio fu trasferito nell'altare maggiore del Duomo. Sab-
batini, Calendario, II, 36; Filangieri, Documenti, IV, 9.
(2) Filangieri, Indice degli artefici, II, p. 8.
(3) Note al Celano, ediz. del 1858, voi. III, p. 69.
NAPOLI NOBILISSIMA
UN CONVENTO DI CANONICHESSE.
REGINA COELI.
Prima che le canonichesse lateranensi avessero co-
struito sull'amena e salubre collina di Capo-Napoli il son-
tuoso convento che porta tuttora il nome di Regina Coeli,
esse avevano occupato altre due sedi.
La prima fu a S. Maria a piazza in un palazzo dei Gam-
bacorta accanto a quell'antica chiesa di cui ebbero l'uso
per concessione del rettore canonico Pietro de Gravina.
Ivi si raccolsero nel 1518 le fondatrici, quattro mona-
che del monastero benedettino di S. Maria d'Agnone che
ad impulso del confessore padre Nicolò Pulcino, eremita
agostiniano, avevano abbandonata l'antica regola per quella
di S. Agostino. Si chiamavano Caterina Mariconda, Mar-
gherita Tartarone, Aurelia e Lucrezia Oliviero: apparte-
nevano a illustri famiglie napoletane e le due prime ave-
vano fatto parte della corte di Isabella d'Aragona duchessa
di Milano. Ad esse si aggiunse donna Francesca Gamba-
corta, uscita dal convento delle canonichesse di Nola, che
in rimunerazione del palazzo da lei donato ebbe la no-
mina di badessa a vita.
L'istituzione fu accolta con molto favore, e ben presto,
per le molte cadette di nobili casate che vennero a ve-
stirvi l'abito bianco con rocchetta e zona nera, il numero
delle recluse crebbe al punto da render necessaria una
sede più ampia. Essa fu stabilita al vico Carboni nei pa-
lazzi del Conte di Montorio e della famiglia Imparato,
dove le monache si trasferirono nel 1531. Erano scorsi
appena tre anni, quando, nella notte precedente all'Assun-
zione del 1534, tutto il fabbricato rovinò, tranne la sala
del capitolo, dove pochi minuti prima la Badessa, seguendo
il comando della Madonna apparsale nel sogno, aveva riu-
nite tutte le monache e le educante (0.
Il monastero fu ricostruito allo stesso posto e accanto
fu elevata la chiesa su disegno dell'architetto Loise Impò.
Vi contribuì con una generosa oblazione la famiglia Gam-
bacorta, che si riserbò il patronato della tribuna dove ebbe
il sepolcro gentilizio. Gli stalli del coro furono intagliati
nel 1545 da Bartolomeo Imperato di Arienzo (2).
Ma la nuova fabbrica non resistè al terremoto del 1,60
che la ridusse quasi interamente in rovina. Le monache,
scampate per la seconda volta ad una morte atroce, si ri-
fugiarono nel vicino convento di S. Gregorio Armeno e
risolsero di abbandonare un luogo che doveva parer loro
nefasto. Cercarono altrove e furono fortunate di ottenere,
intermediaria donna Maria d'Aragona Marchesa del Vasto,
la cessione del palazzo e dei giardini che suo nipote, il
Duca di Montalto, possedeva dirimpetto l'antico convento
di S. Gaudioso e in confine a quello di S. Maria delle
Grazie a Capo-Napoli.
Eseguiti i primi lavori di adattamento pei quali fu sop-
pressa la cappella beneficiale di S. Valentino de Stendar-
dis C), le canonichesse passarono nel 15 marzo 1566 ad
abitare il nuovo monastero; ma impiegarono ancora molti
anni per portarlo a fine nel modo che ora si vede. In-
torno al grande chiostro, verdeggiante di pergolati e di
alberi annosi, le fabbriche sono disposte nella maniera di
vari altri nostri monasteri di clausura. I lati di oriente e
di mezzogiorno non superano l'altezza del porticato: a set-
tentrione si eleva per due piani il corpo principale con gli
appartamenti delle canonichesse: a ponente sulla strada di
S. Gaudioso è la porteria e il parlatorio.
Nelle carte del monastero non trovo indicato il nome
dell'architetto: il disegno generale dell'edificio fu dato an-
che da Giovan Francesco Mormanno al quale il discorso
che precede la platea e le guide attribuiscono la costru-
zione della sola chiesa? Si tratta del secondo Mormanno,
cioè di Giovan Francesco di Palma detto Mormanno;
giacché il primo, Giovanni Donadio, era morto nel primo
quarto di quel secolo. Il Di Palma appare in relazione
colle canonichesse lateranensi sin dal 1545, al tempo che
si fabbricava il convento al vico Carboni, quando egli te-
stimoniò in loro favore in una controversia che esse eb-
bero col muratore (2).
La costruzione della nuova chiesa di S. Maria di Re-
gina Coeli fu incominciata nel maggio del 1590 e con-
dotta a termine nel giugno del 1594. L'iscrizione che era
sulla porta e che ci è stata conservata dal Chiarini (3) ri-
cordava queste due date. Ora si vede soltanto il principio
di detta iscrizione, dove è narrata la miracolosa salvazione
delle monache nel primo crollamento del convento al vico
Carboni:
THURA TIBI MEMORES COELI REGINA QUOTANNIS
FESTA LUCE DAMUS, QUOD LUSTRIS ANTE PERACTIS
BISSENIS NOSTRAS SERVASTI A MORTE SORORES
PRAESSERAT HAS TECTUM NOCTURNA PUTRE RUINA
NUMINE DOCTA TUO NE FORTE DOMESTICA PRAESES
IUSSERAT IGNARAS RUITURO CEDERE TECTO.
(1) Archivio di Stato. Monasteri soppressi, voi. 1927: platea. Que-
ste e le seguenti notizie sulla fondazione sono tolte dallo scritto con-
tenuto nelle prime pagine e che porta il titolo: Origine della religione
dei canonici regolari lateranensi e della fondazione del real monastero di
S. Maria Regina Coeli.
(2) Filangieri, Indice degli artefici, II, 7 e 8.
(1) Il beneficio fu trasferito nell'altare maggiore del Duomo. Sab-
batini, Calendario, II, 36; Filangieri, Documenti, IV, 9.
(2) Filangieri, Indice degli artefici, II, p. 8.
(3) Note al Celano, ediz. del 1858, voi. III, p. 69.