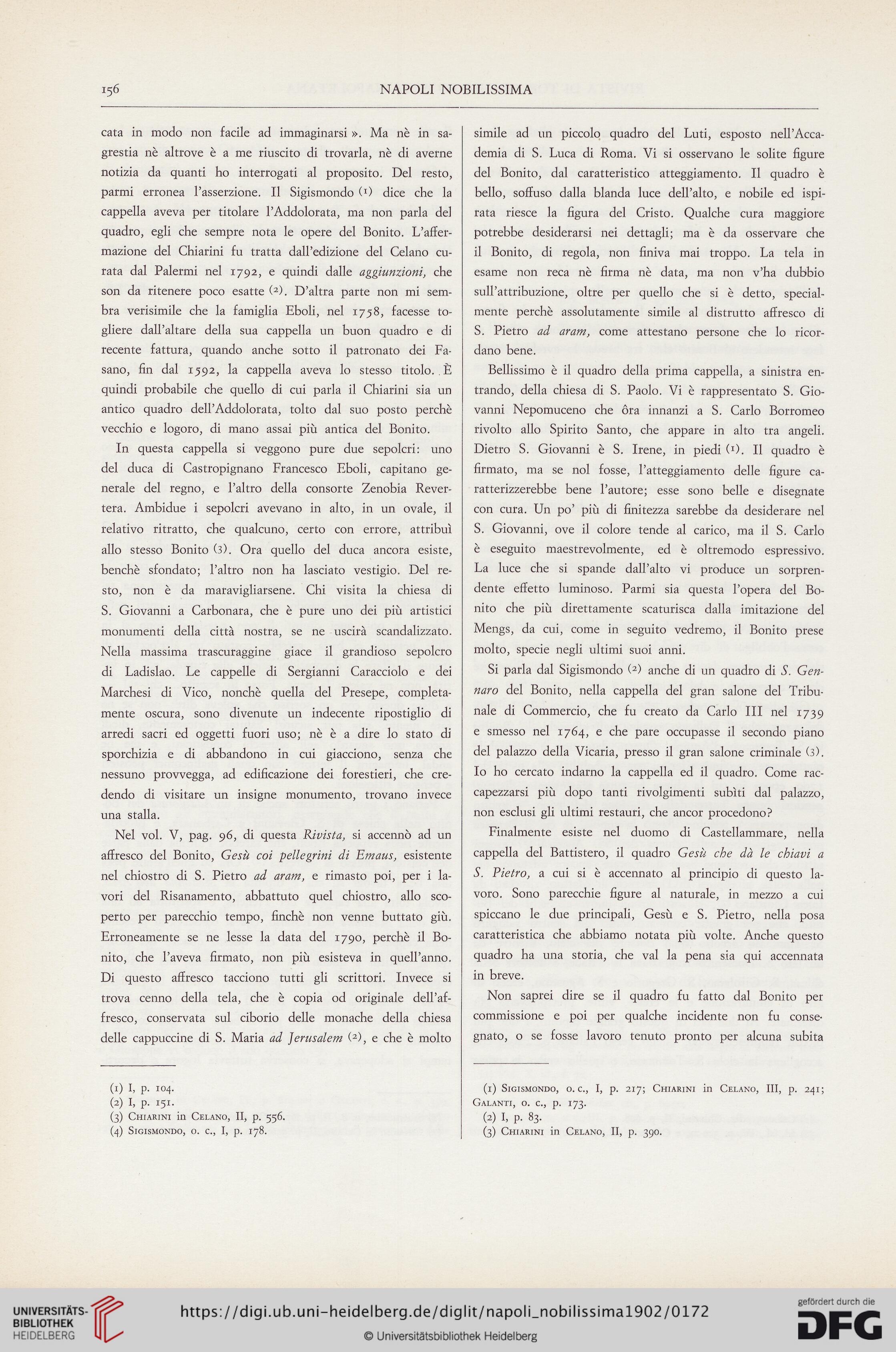i56
NAPOLI NOBILISSIMA
cata in modo non facile ad immaginarsi ». Ma nè in sa-
grestia nè altrove è a me riuscito di trovarla, nè di averne
notizia da quanti ho interrogati al proposito. Del resto,
parmi erronea l'asserzione. Il Sigismondo (0 dice che la
cappella aveva per titolare l'Addolorata, ma non parla del
quadro, egli che sempre nota le opere del Bonito. L'affer-
mazione del Chiarini fu tratta dall'edizione del Celano cu-
rata dal Palermi nel 1792, e quindi dalle aggiunzioni, che
son da ritenere poco esatte (2). D'altra parte non mi sem-
bra verisimile che la famiglia Eboli, nel 1758, facesse to-
gliere dall'altare della sua cappella un buon quadro e di
recente fattura, quando anche sotto il patronato dei Fa-
sano, fin dal 1592, la cappella aveva lo stesso titolo. È
quindi probabile che quello di cui parla il Chiarini sia un
antico quadro dell'Addolorata, tolto dal suo posto perchè
vecchio e logoro, di mano assai più antica del Bonito.
In questa cappella si veggono pure due sepolcri: uno
del duca di Castropignano Francesco Eboli, capitano ge-
nerale del regno, e l'altro della consorte Zenobia Rever-
tera. Ambidue i sepolcri avevano in alto, in un ovale, il
relativo ritratto, che qualcuno, certo con errore, attribuì
allo stesso Bonito (3). Ora quello del duca ancora esiste,
benché sfondato; l'altro non ha lasciato vestigio. Del re-
sto, non è da maravigliarsene. Chi visita la chiesa di
S. Giovanni a Carbonara, che è pure uno dei più artistici
monumenti della città nostra, se ne uscirà scandalizzato.
Nella massima trascuraggine giace il grandioso sepolcro
di Ladislao. Le cappelle di Sergianni Caracciolo e dei
Marchesi di Vico, nonché quella del Presepe, compieta-
mente oscura, sono divenute un indecente ripostiglio di
arredi sacri ed oggetti fuori uso; nè è a dire lo stato di
sporchizia e di abbandono in cui giacciono, senza che
nessuno provvegga, ad edificazione dei forestieri, che cre-
dendo di visitare un insigne monumento, trovano invece
una stalla.
Nel vol. V, pag. 96, di questa Rivista, si accennò ad un
affresco del Bonito, Gesù coi pellegrini di Emaus, esistente
nel chiostro di S. Pietro ad aravi, e rimasto poi, per i la-
vori del Risanamento, abbattuto quel chiostro, allo sco-
perto per parecchio tempo, finche non venne buttato giù.
Erroneamente se ne lesse la data del 1790, perchè il Bo-
nito, che l'aveva firmato, non più esisteva in quell'anno.
Di questo affresco tacciono tutti gli scrittori. Invece si
trova cenno della tela, che è copia od originale dell'af-
fresco, conservata sul ciborio delle monache della chiesa
delle cappuccine di S. Maria ad Jerusalem (2), e che è molto
simile ad un piccolo quadro del Luti, esposto nell'Acca-
demia di S. Luca di Roma. Vi si osservano le solite figure
del Bonito, dal caratteristico atteggiamento. Il quadro è
bello, soffuso dalla blanda luce dell'alto, e nobile ed ispi-
rata riesce la figura del Cristo. Qualche cura maggiore
potrebbe desiderarsi nei dettagli; ma è da osservare che
il Bonito, di regola, non finiva mai troppo. La tela in
esame non reca nè firma nè data, ma non v'ha dubbio
sull'attribuzione, oltre per quello che si è detto, special-
mente perchè assolutamente simile al distrutto affresco di
S. Pietro ad aram, come attestano persone che lo ricor-
dano bene.
Bellissimo è il quadro della prima cappella, a sinistra en-
trando, della chiesa di S. Paolo. Vi è rappresentato S. Gio-
vanni Nepomuceno che óra innanzi a S. Carlo Borromeo
rivolto allo Spirito Santo, che appare in alto tra angeli.
Dietro S. Giovanni è S. Irene, in piedi (0. Il quadro è
firmato, ma se noi fosse, l'atteggiamento delle figure ca-
ratterizzerebbe bene l'autore; esse sono belle e disegnate
con cura. Un po' più di finitezza sarebbe da desiderare nel
S. Giovanni, ove il colore tende al carico, ma il S. Carlo
è eseguito maestrevolmente, ed è oltremodo espressivo.
La luce che si spande dall'alto vi produce un sorpren-
dente effetto luminoso. Parmi sia questa l'opera del Bo-
nito che più direttamente scaturisca dalla imitazione del
Mengs, da cui, come in seguito vedremo, il Bonito prese
molto, specie negli ultimi suoi anni.
Si parla dal Sigismondo (2) anche di un quadro di S. Gen-
naro del Bonito, nella cappella del gran salone del Tribu-
nale di Commercio, che fu creato da Carlo III nel 1739
e smesso nel 1764, e che pare occupasse il secondo piano
del palazzo della Vicaria, presso il gran salone criminale (3).
Io ho cercato indarno la cappella ed il quadro. Come rac-
capezzarsi più dopo tanti rivolgimenti subiti dal palazzo,
non esclusi gli ultimi restauri, che ancor procedono?
Finalmente esiste nel duomo di Castellammare, nella
cappella del Battistero, il quadro Gesù che dà le chiavi a
S. Pietro, a cui si è accennato al principio di questo la-
voro. Sono parecchie figure al naturale, in mezzo a cui
spiccano le due principali, Gesù e S. Pietro, nella posa
caratteristica che abbiamo notata più volte. Anche questo
quadro ha una storia, che val la pena sia qui accennata
in breve.
Non saprei dire se il quadro fu fatto dal Bonito per
commissione e poi per qualche incidente non fu conse-
gnato, 0 se fosse lavoro tenuto pronto per alcuna subita
(1) I, p. 104.
(2) I, p. 151.
(3) Chiarini in Celano, II, p. 556.
(4) Sigismondo, o. c., I, p. 178.
(1) Sigismondo, o. c., I, p.
Galanti, o. c., p. 173.
(2) I, p. 83.
(3) Chiarini in Celano, II,
217; Chiarini in Celano, III, 241;
P. 390-
NAPOLI NOBILISSIMA
cata in modo non facile ad immaginarsi ». Ma nè in sa-
grestia nè altrove è a me riuscito di trovarla, nè di averne
notizia da quanti ho interrogati al proposito. Del resto,
parmi erronea l'asserzione. Il Sigismondo (0 dice che la
cappella aveva per titolare l'Addolorata, ma non parla del
quadro, egli che sempre nota le opere del Bonito. L'affer-
mazione del Chiarini fu tratta dall'edizione del Celano cu-
rata dal Palermi nel 1792, e quindi dalle aggiunzioni, che
son da ritenere poco esatte (2). D'altra parte non mi sem-
bra verisimile che la famiglia Eboli, nel 1758, facesse to-
gliere dall'altare della sua cappella un buon quadro e di
recente fattura, quando anche sotto il patronato dei Fa-
sano, fin dal 1592, la cappella aveva lo stesso titolo. È
quindi probabile che quello di cui parla il Chiarini sia un
antico quadro dell'Addolorata, tolto dal suo posto perchè
vecchio e logoro, di mano assai più antica del Bonito.
In questa cappella si veggono pure due sepolcri: uno
del duca di Castropignano Francesco Eboli, capitano ge-
nerale del regno, e l'altro della consorte Zenobia Rever-
tera. Ambidue i sepolcri avevano in alto, in un ovale, il
relativo ritratto, che qualcuno, certo con errore, attribuì
allo stesso Bonito (3). Ora quello del duca ancora esiste,
benché sfondato; l'altro non ha lasciato vestigio. Del re-
sto, non è da maravigliarsene. Chi visita la chiesa di
S. Giovanni a Carbonara, che è pure uno dei più artistici
monumenti della città nostra, se ne uscirà scandalizzato.
Nella massima trascuraggine giace il grandioso sepolcro
di Ladislao. Le cappelle di Sergianni Caracciolo e dei
Marchesi di Vico, nonché quella del Presepe, compieta-
mente oscura, sono divenute un indecente ripostiglio di
arredi sacri ed oggetti fuori uso; nè è a dire lo stato di
sporchizia e di abbandono in cui giacciono, senza che
nessuno provvegga, ad edificazione dei forestieri, che cre-
dendo di visitare un insigne monumento, trovano invece
una stalla.
Nel vol. V, pag. 96, di questa Rivista, si accennò ad un
affresco del Bonito, Gesù coi pellegrini di Emaus, esistente
nel chiostro di S. Pietro ad aravi, e rimasto poi, per i la-
vori del Risanamento, abbattuto quel chiostro, allo sco-
perto per parecchio tempo, finche non venne buttato giù.
Erroneamente se ne lesse la data del 1790, perchè il Bo-
nito, che l'aveva firmato, non più esisteva in quell'anno.
Di questo affresco tacciono tutti gli scrittori. Invece si
trova cenno della tela, che è copia od originale dell'af-
fresco, conservata sul ciborio delle monache della chiesa
delle cappuccine di S. Maria ad Jerusalem (2), e che è molto
simile ad un piccolo quadro del Luti, esposto nell'Acca-
demia di S. Luca di Roma. Vi si osservano le solite figure
del Bonito, dal caratteristico atteggiamento. Il quadro è
bello, soffuso dalla blanda luce dell'alto, e nobile ed ispi-
rata riesce la figura del Cristo. Qualche cura maggiore
potrebbe desiderarsi nei dettagli; ma è da osservare che
il Bonito, di regola, non finiva mai troppo. La tela in
esame non reca nè firma nè data, ma non v'ha dubbio
sull'attribuzione, oltre per quello che si è detto, special-
mente perchè assolutamente simile al distrutto affresco di
S. Pietro ad aram, come attestano persone che lo ricor-
dano bene.
Bellissimo è il quadro della prima cappella, a sinistra en-
trando, della chiesa di S. Paolo. Vi è rappresentato S. Gio-
vanni Nepomuceno che óra innanzi a S. Carlo Borromeo
rivolto allo Spirito Santo, che appare in alto tra angeli.
Dietro S. Giovanni è S. Irene, in piedi (0. Il quadro è
firmato, ma se noi fosse, l'atteggiamento delle figure ca-
ratterizzerebbe bene l'autore; esse sono belle e disegnate
con cura. Un po' più di finitezza sarebbe da desiderare nel
S. Giovanni, ove il colore tende al carico, ma il S. Carlo
è eseguito maestrevolmente, ed è oltremodo espressivo.
La luce che si spande dall'alto vi produce un sorpren-
dente effetto luminoso. Parmi sia questa l'opera del Bo-
nito che più direttamente scaturisca dalla imitazione del
Mengs, da cui, come in seguito vedremo, il Bonito prese
molto, specie negli ultimi suoi anni.
Si parla dal Sigismondo (2) anche di un quadro di S. Gen-
naro del Bonito, nella cappella del gran salone del Tribu-
nale di Commercio, che fu creato da Carlo III nel 1739
e smesso nel 1764, e che pare occupasse il secondo piano
del palazzo della Vicaria, presso il gran salone criminale (3).
Io ho cercato indarno la cappella ed il quadro. Come rac-
capezzarsi più dopo tanti rivolgimenti subiti dal palazzo,
non esclusi gli ultimi restauri, che ancor procedono?
Finalmente esiste nel duomo di Castellammare, nella
cappella del Battistero, il quadro Gesù che dà le chiavi a
S. Pietro, a cui si è accennato al principio di questo la-
voro. Sono parecchie figure al naturale, in mezzo a cui
spiccano le due principali, Gesù e S. Pietro, nella posa
caratteristica che abbiamo notata più volte. Anche questo
quadro ha una storia, che val la pena sia qui accennata
in breve.
Non saprei dire se il quadro fu fatto dal Bonito per
commissione e poi per qualche incidente non fu conse-
gnato, 0 se fosse lavoro tenuto pronto per alcuna subita
(1) I, p. 104.
(2) I, p. 151.
(3) Chiarini in Celano, II, p. 556.
(4) Sigismondo, o. c., I, p. 178.
(1) Sigismondo, o. c., I, p.
Galanti, o. c., p. 173.
(2) I, p. 83.
(3) Chiarini in Celano, II,
217; Chiarini in Celano, III, 241;
P. 390-