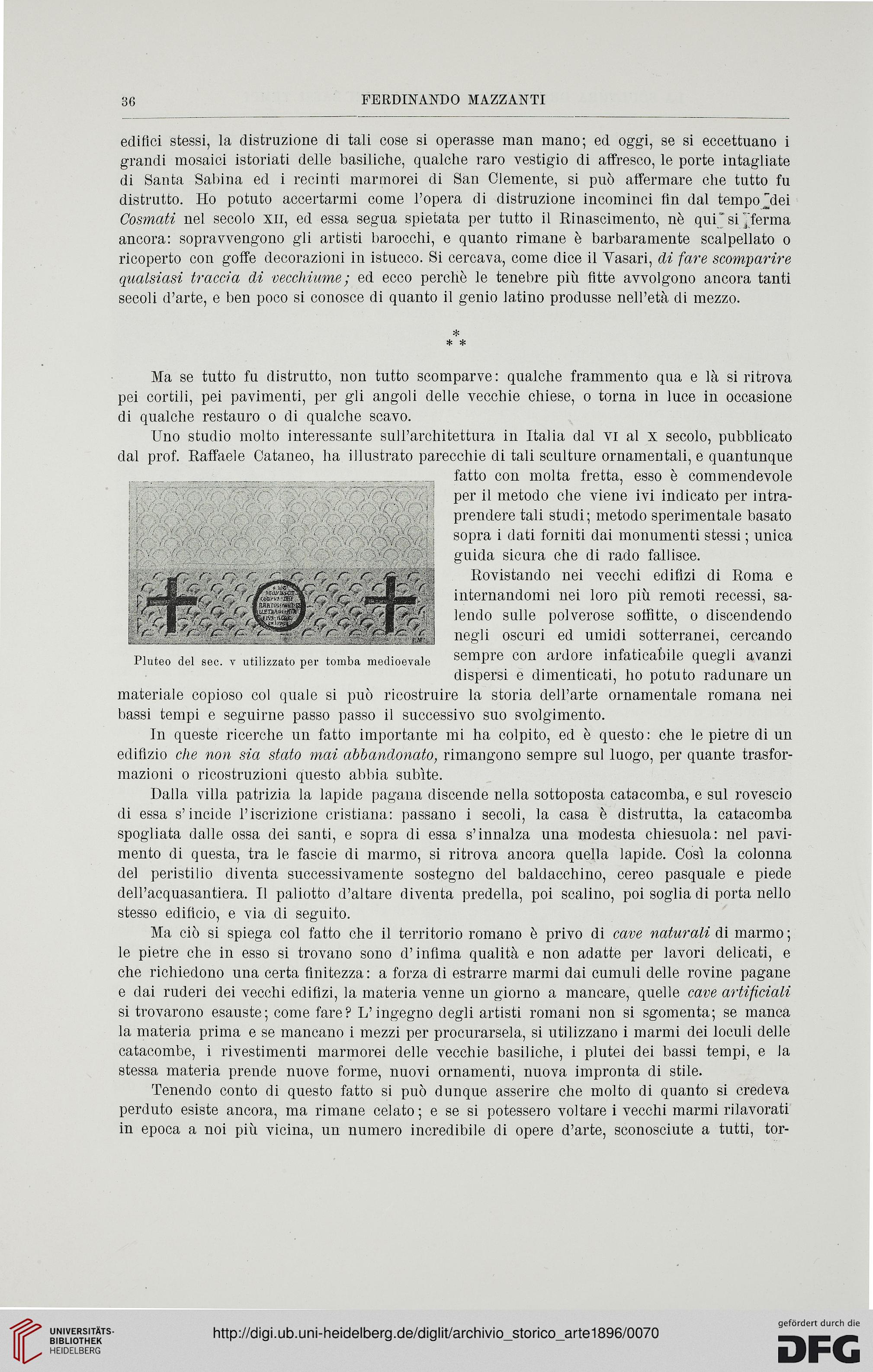36
FERDINANDO MAZZANTI
edifìci stessi, la distruzione di tali cose si operasse man mano; ed oggi, se si eccettuano i
grandi mosaici istoriati delle basiliche, qualche raro vestigio di affresco, le porte intagliate
di Santa Sabina ed i recioti marmorei di San Clemente, si può affermare che tutto fu
distrutto. Ho potuto accertarmi come l'opera di distruzione incominci fin dal tempo [[dei
Cosmati nel secolo xu, ed essa segua spietata per tutto il Rinascimento, nè qui"si ^ferma
ancora: sopravvengono gli artisti barocchi, e quanto rimane è barbaramente scalpellato o
ricoperto con goffe decorazioni in istucco. Si cercava, come dice il Yasari, di fare scomparire
qualsiasi traccia di vecchiume; ed ecco perchè le tenebre più fìtte avvolgono ancora tanti
secoli d'arte, e ben poco si conosce di quanto il genio latino produsse nell'età di mezzo.
*
* *
Pluteo del sec. v utilizzato per tomba medioevale
Ma se tutto fu distrutto, non tutto scomparve : qualche frammento qua e là si ritrova
pei cortili, pei pavimenti, per gli angoli delle vecchie chiese, o torna in luce in occasione
di qualche restauro o di qualche scavo.
Uno studio molto interessante sui l'architettura in Italia dal vi al x secolo, pubblicato
dal prof. Raffaele Cataneo, ha illustrato parecchie di tali sculture ornamentali, e quantunque
fatto con molta fretta, esso è commendevole
per il metodo che viene ivi indicato per intra-
prendere tali studi; metodo sperimentale basato
sopra i dati forniti dai monumenti stessi ; unica
guida sicura che di rado fallisce.
Rovistando nei vecchi edifìzi di Roma e
internandomi nei loro più remoti recessi, sa-
lendo sulle polverose soffitte, o discendendo
negli oscuri ed umidi sotterranei, cercando
sempre con ardore infaticabile quegli avanzi
dispersi e dimenticati, ho potuto radunare un
materiale copioso col quale si può ricostruire la storia dell'arte ornamentale romana nei
bassi tempi e seguirne passo passo il successivo suo svolgimento.
In queste ricerche un fatto importante mi ha colpito, ed è questo: che le pietre di un
edifìzio che non sia stato mai abbandonato, rimangono sempre sul luogo, per quante trasfor-
mazioni o ricostruzioni questo abbia subite.
Dalla villa patrizia la lapide pagana discende nella sottoposta catacomba, e sul rovescio
di essa s'incide l'iscrizione cristiana: passano i secoli, la casa è distrutta, la catacomba
spogliata dalle ossa dei santi, e sopra di essa s'innalza una modesta chiesuola: nel pavi-
mento di questa, tra le fascie di marmo, si ritrova ancora quella lapide. Così la colonna
del peristilio diventa successivamente sostegno del baldacchino, cereo pasquale e piede
dell'acquasantiera. Il paliotto d'altare diventa predella, poi scalino, poi soglia di porta nello
stesso edifìcio, e via di seguito.
Ma ciò si spiega col fatto che il territorio romano è privo di cave naturali di marmo ;
le pietre che in esso si trovano sono d'infima qualità e non adatte per lavori delicati, e
che richiedono una certa finitezza: a forza di estrarre marmi dai cumuli delle rovine pagane
e dai ruderi dei vecchi edifìzi, la materia venne un giorno a mancare, quelle cave artificiali
si trovarono esauste; come fare? L'ingegno degli artisti romani non si sgomenta; se manca
la materia prima e se mancano i mezzi per procurarsela, si utilizzano i marmi dei loculi delle
catacombe, i rivestimenti marmorei delle vecchie basiliche, i plutei dei bassi tempi, e la
stessa materia prende nuove forme, nuovi ornamenti, nuova impronta di stile.
Tenendo conto di questo fatto si può dunque asserire che molto di quanto si credeva
perduto esiste ancora, ma rimane celato; e se si potessero voltare i vecchi marmi rilavorati
in epoca a noi più vicina, un numero incredibile di opere d'arte, sconosciute a tutti, tor-
FERDINANDO MAZZANTI
edifìci stessi, la distruzione di tali cose si operasse man mano; ed oggi, se si eccettuano i
grandi mosaici istoriati delle basiliche, qualche raro vestigio di affresco, le porte intagliate
di Santa Sabina ed i recioti marmorei di San Clemente, si può affermare che tutto fu
distrutto. Ho potuto accertarmi come l'opera di distruzione incominci fin dal tempo [[dei
Cosmati nel secolo xu, ed essa segua spietata per tutto il Rinascimento, nè qui"si ^ferma
ancora: sopravvengono gli artisti barocchi, e quanto rimane è barbaramente scalpellato o
ricoperto con goffe decorazioni in istucco. Si cercava, come dice il Yasari, di fare scomparire
qualsiasi traccia di vecchiume; ed ecco perchè le tenebre più fìtte avvolgono ancora tanti
secoli d'arte, e ben poco si conosce di quanto il genio latino produsse nell'età di mezzo.
*
* *
Pluteo del sec. v utilizzato per tomba medioevale
Ma se tutto fu distrutto, non tutto scomparve : qualche frammento qua e là si ritrova
pei cortili, pei pavimenti, per gli angoli delle vecchie chiese, o torna in luce in occasione
di qualche restauro o di qualche scavo.
Uno studio molto interessante sui l'architettura in Italia dal vi al x secolo, pubblicato
dal prof. Raffaele Cataneo, ha illustrato parecchie di tali sculture ornamentali, e quantunque
fatto con molta fretta, esso è commendevole
per il metodo che viene ivi indicato per intra-
prendere tali studi; metodo sperimentale basato
sopra i dati forniti dai monumenti stessi ; unica
guida sicura che di rado fallisce.
Rovistando nei vecchi edifìzi di Roma e
internandomi nei loro più remoti recessi, sa-
lendo sulle polverose soffitte, o discendendo
negli oscuri ed umidi sotterranei, cercando
sempre con ardore infaticabile quegli avanzi
dispersi e dimenticati, ho potuto radunare un
materiale copioso col quale si può ricostruire la storia dell'arte ornamentale romana nei
bassi tempi e seguirne passo passo il successivo suo svolgimento.
In queste ricerche un fatto importante mi ha colpito, ed è questo: che le pietre di un
edifìzio che non sia stato mai abbandonato, rimangono sempre sul luogo, per quante trasfor-
mazioni o ricostruzioni questo abbia subite.
Dalla villa patrizia la lapide pagana discende nella sottoposta catacomba, e sul rovescio
di essa s'incide l'iscrizione cristiana: passano i secoli, la casa è distrutta, la catacomba
spogliata dalle ossa dei santi, e sopra di essa s'innalza una modesta chiesuola: nel pavi-
mento di questa, tra le fascie di marmo, si ritrova ancora quella lapide. Così la colonna
del peristilio diventa successivamente sostegno del baldacchino, cereo pasquale e piede
dell'acquasantiera. Il paliotto d'altare diventa predella, poi scalino, poi soglia di porta nello
stesso edifìcio, e via di seguito.
Ma ciò si spiega col fatto che il territorio romano è privo di cave naturali di marmo ;
le pietre che in esso si trovano sono d'infima qualità e non adatte per lavori delicati, e
che richiedono una certa finitezza: a forza di estrarre marmi dai cumuli delle rovine pagane
e dai ruderi dei vecchi edifìzi, la materia venne un giorno a mancare, quelle cave artificiali
si trovarono esauste; come fare? L'ingegno degli artisti romani non si sgomenta; se manca
la materia prima e se mancano i mezzi per procurarsela, si utilizzano i marmi dei loculi delle
catacombe, i rivestimenti marmorei delle vecchie basiliche, i plutei dei bassi tempi, e la
stessa materia prende nuove forme, nuovi ornamenti, nuova impronta di stile.
Tenendo conto di questo fatto si può dunque asserire che molto di quanto si credeva
perduto esiste ancora, ma rimane celato; e se si potessero voltare i vecchi marmi rilavorati
in epoca a noi più vicina, un numero incredibile di opere d'arte, sconosciute a tutti, tor-