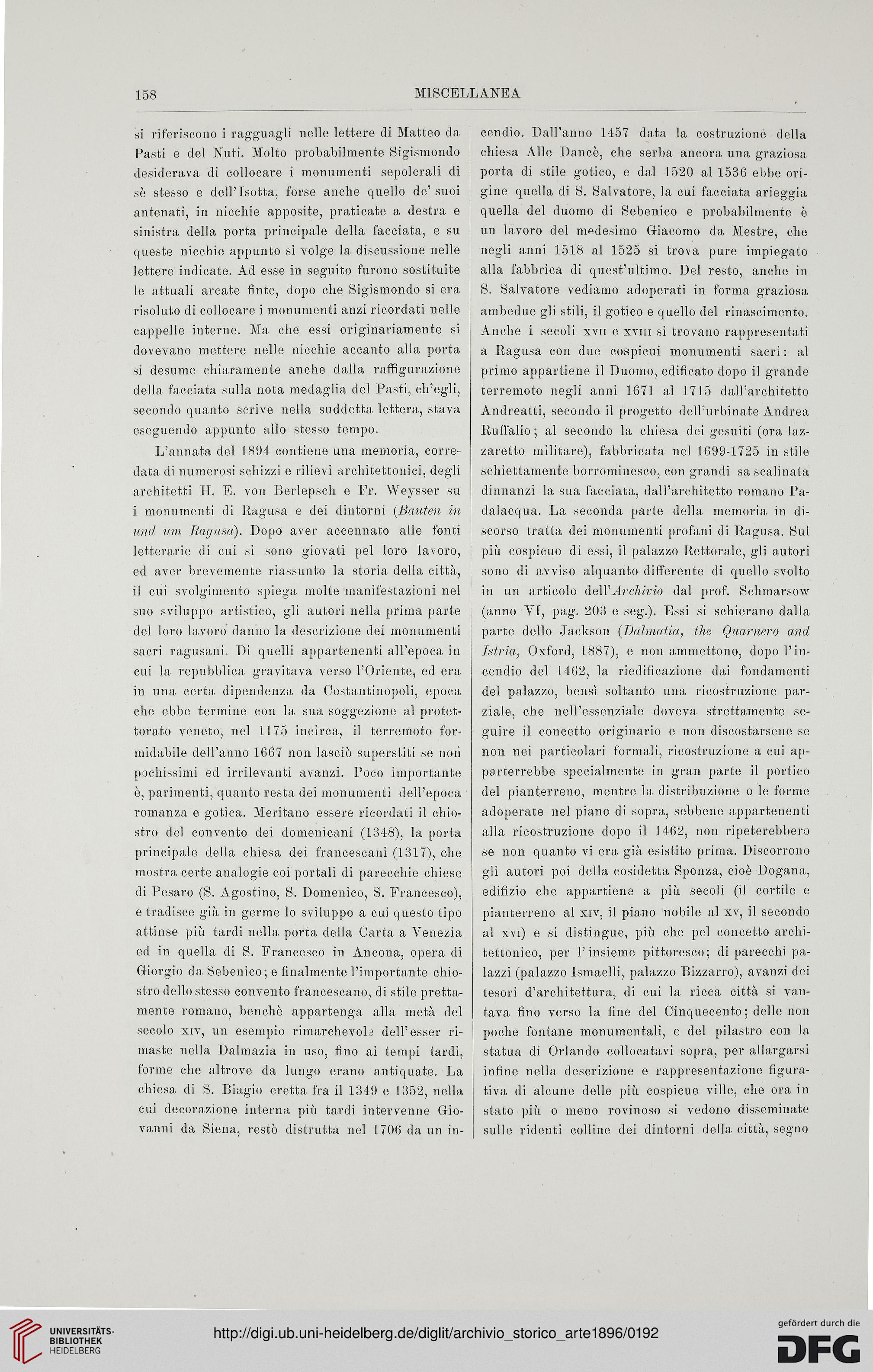158
si riferiscono i ragguagli nelle lettere di Matteo da
Pasti e del Nuti. Molto probabilmente Sigismondo
desiderava di collocare i monumenti sepolcrali di
se stesso e dell'Isotta, forse anche quello de' suoi
antenati, in nicchie apposite, praticate a destra e
sinistra della porta principale della facciata, e su
queste nicchie appunto si volge la discussione nelle
lettere indicate. Ad esse in seguito furono sostituite
le attuali arcate finte, dopo che Sigismondo si era
risoluto di collocare i monumenti anzi ricordati nelle
cappelle interne. Ma che essi originariamente si
dovevano mettere nelle nicchie accanto alla porta
si desume chiaramente anche dalla raffigurazione
della facciata sulla nota medaglia del Pasti, ch'egli,
secondo quanto scrive nella suddetta lettera, stava
eseguendo appunto allo stesso tempo.
L'annata del 1894 contiene una memoria, corre-
data di numerosi schizzi e rilievi architettonici, degli
architetti H. E. von Berlepsch e Fr. Weysser su
i monumenti di Ragusa e dei dintorni (Bauten in
unii um Ragusa). Dopo aver accennato alle fonti
letterarie di cui si sono giovati pel loro lavoro,
ed aver brevemente riassunto la storia della città,
il cui svolgimento spiega molte manifestazioni nel
suo sviluppo artistico, gli autori nella prima parte
del loro lavoro danno la descrizione dei monumenti
sacri ragusani. Di quelli appartenenti all'epoca in
cui la repubblica gravitava verso l'Oriente, ed era
in una certa dipendenza da Costantinopoli, epoca
che ebbe termine con la sua soggezione al protet-
torato veneto, nel 1175 incirca, il terremoto for-
midabile dell'anno 1667 non lasciò superstiti se non
pochissimi ed irrilevanti avanzi. Poco importante
è, parimenti, quanto resta dei monumenti dell'epoca
romanza e gotica. Meritano essere ricordati il chio-
stro del convento dei domenicani (1348), la porta
principale della chiesa dei francescani (1317), che
mostra certe analogie coi portali di parecchie chiese
di Pesaro (S. Agostino, S. Domenico, S. Francesco),
e tradisce già in germe lo sviluppo a cui questo tipo
attinse più tardi nella porta della Carta a Venezia
ed in quella di S. Francesco in Ancona, opera di
Giorgio da Sebenico; e finalmente l'importante chio-
stro dello stesso convento francescano, di stile pretta-
mente romano, benché appartenga alla metà del
secolo xiv, un esempio rimarchevole dell'esser ri-
maste nella Dalmazia in uso, fino ai tempi tardi,
forme che altrove da lungo erano antiquate. La
chiesa di S. Biagio eretta fra il 1349 e 1352, nella
cui decorazione interna più tardi intervenne Gio-
vanni da Siena, restò distrutta nel 1706 da un in-
uANEA
cendio. Dall'anno 1457 data la costruzioné della
chiesa Alle Dance, che serba ancora una graziosa
porta di stile gotico, e dal 1520 al 1536 ebbe ori-
gine quella di S. Salvatore, la cui facciata arieggia
quella del duomo di Sebenico e probabilmente è
un lavoro del medesimo Giacomo da Mestre, che
negli anni 1518 al 1525 si trova pure impiegato
alla fabbrica di quest'ultimo. Del resto, anche in
S. Salvatore vediamo adoperati in forma graziosa
ambedue gli stili, il gotico e quello del rinascimento.
Anche i secoli xvn e xviii si trovano rappresentati
a Ragusa con due cospicui monumenti sacri : al
primo appartiene il Duomo, edificato dopo il grande
terremoto negli anni 1671 al 1715 dall'architetto
Andreatti, secondo il progetto dell'urbinate Andrea
Ruffalio ; al secondo la chiesa dei gesuiti (ora laz-
zaretto militare), fabbricata nel 1699-1725 in stile
schiettamente borrominesco, con grandi sa scalinata
dinnanzi la sua facciata, dall'architetto romano Pa-
dalacqua. La seconda parte della memoria in di-
scorso tratta dei monumenti profani di Ragusa. Sul
più cospicuo di essi, il palazzo Pettorale, gli autori
sono di avviso alquanto differente di quello svolto
in un articolo doW Archivio dal prof. Schmarsow
(anno YI, pag. 203 e seg.). Essi si schierano dalla
parte dello Jackson (Dalmatia, the Quarnero and
Istria, Oxford, 1887), e non ammettono, dopo l'in-
cendio del 1462, la riedificazione dai fondamenti
del palazzo, bensì soltanto una ricostruzione par-
ziale, che nell'essenziale doveva strettamente se-
guire il concetto originario e non discostarsene se
non nei particolari formali, ricostruzione a cui ap-
parterrebbe specialmente in gran parte il portico
del pianterreno, mentre la distribuzione o le forme
adoperate nel piano di sopra, sebbene appartenenti
alla ricostruzione dopo il 1462, non ripeterebbero
se non quanto vi era già esistito prima. Discorrono
gli autori poi della cosidetta Sponza, cioè Dogana,
edifizio che appartiene a più secoli (il cortile e
pianterreno al xiv, il piano nobile al xv, il secondo
al xvi) e si distingue, più che pel concetto archi-
tettonico, per l'insieme pittoresco; di parecchi pa-
lazzi (palazzo Ismaelli, palazzo Bizzarro), avanzi dei
tesori d'architettura, di cui la ricca città si van-
tava fino verso la fine del Cinquecento; delle non
poche fontane monumentali, e del pilastro con la
statua di Orlando collocatavi sopra, per allargarsi
infine nella descrizione e rappresentazione figura-
tiva di alcune delle più cospicue ville, che ora in
stato più o meno rovinoso si vedono disseminate
sulle ridenti colline dei dintorni della città, seguo
si riferiscono i ragguagli nelle lettere di Matteo da
Pasti e del Nuti. Molto probabilmente Sigismondo
desiderava di collocare i monumenti sepolcrali di
se stesso e dell'Isotta, forse anche quello de' suoi
antenati, in nicchie apposite, praticate a destra e
sinistra della porta principale della facciata, e su
queste nicchie appunto si volge la discussione nelle
lettere indicate. Ad esse in seguito furono sostituite
le attuali arcate finte, dopo che Sigismondo si era
risoluto di collocare i monumenti anzi ricordati nelle
cappelle interne. Ma che essi originariamente si
dovevano mettere nelle nicchie accanto alla porta
si desume chiaramente anche dalla raffigurazione
della facciata sulla nota medaglia del Pasti, ch'egli,
secondo quanto scrive nella suddetta lettera, stava
eseguendo appunto allo stesso tempo.
L'annata del 1894 contiene una memoria, corre-
data di numerosi schizzi e rilievi architettonici, degli
architetti H. E. von Berlepsch e Fr. Weysser su
i monumenti di Ragusa e dei dintorni (Bauten in
unii um Ragusa). Dopo aver accennato alle fonti
letterarie di cui si sono giovati pel loro lavoro,
ed aver brevemente riassunto la storia della città,
il cui svolgimento spiega molte manifestazioni nel
suo sviluppo artistico, gli autori nella prima parte
del loro lavoro danno la descrizione dei monumenti
sacri ragusani. Di quelli appartenenti all'epoca in
cui la repubblica gravitava verso l'Oriente, ed era
in una certa dipendenza da Costantinopoli, epoca
che ebbe termine con la sua soggezione al protet-
torato veneto, nel 1175 incirca, il terremoto for-
midabile dell'anno 1667 non lasciò superstiti se non
pochissimi ed irrilevanti avanzi. Poco importante
è, parimenti, quanto resta dei monumenti dell'epoca
romanza e gotica. Meritano essere ricordati il chio-
stro del convento dei domenicani (1348), la porta
principale della chiesa dei francescani (1317), che
mostra certe analogie coi portali di parecchie chiese
di Pesaro (S. Agostino, S. Domenico, S. Francesco),
e tradisce già in germe lo sviluppo a cui questo tipo
attinse più tardi nella porta della Carta a Venezia
ed in quella di S. Francesco in Ancona, opera di
Giorgio da Sebenico; e finalmente l'importante chio-
stro dello stesso convento francescano, di stile pretta-
mente romano, benché appartenga alla metà del
secolo xiv, un esempio rimarchevole dell'esser ri-
maste nella Dalmazia in uso, fino ai tempi tardi,
forme che altrove da lungo erano antiquate. La
chiesa di S. Biagio eretta fra il 1349 e 1352, nella
cui decorazione interna più tardi intervenne Gio-
vanni da Siena, restò distrutta nel 1706 da un in-
uANEA
cendio. Dall'anno 1457 data la costruzioné della
chiesa Alle Dance, che serba ancora una graziosa
porta di stile gotico, e dal 1520 al 1536 ebbe ori-
gine quella di S. Salvatore, la cui facciata arieggia
quella del duomo di Sebenico e probabilmente è
un lavoro del medesimo Giacomo da Mestre, che
negli anni 1518 al 1525 si trova pure impiegato
alla fabbrica di quest'ultimo. Del resto, anche in
S. Salvatore vediamo adoperati in forma graziosa
ambedue gli stili, il gotico e quello del rinascimento.
Anche i secoli xvn e xviii si trovano rappresentati
a Ragusa con due cospicui monumenti sacri : al
primo appartiene il Duomo, edificato dopo il grande
terremoto negli anni 1671 al 1715 dall'architetto
Andreatti, secondo il progetto dell'urbinate Andrea
Ruffalio ; al secondo la chiesa dei gesuiti (ora laz-
zaretto militare), fabbricata nel 1699-1725 in stile
schiettamente borrominesco, con grandi sa scalinata
dinnanzi la sua facciata, dall'architetto romano Pa-
dalacqua. La seconda parte della memoria in di-
scorso tratta dei monumenti profani di Ragusa. Sul
più cospicuo di essi, il palazzo Pettorale, gli autori
sono di avviso alquanto differente di quello svolto
in un articolo doW Archivio dal prof. Schmarsow
(anno YI, pag. 203 e seg.). Essi si schierano dalla
parte dello Jackson (Dalmatia, the Quarnero and
Istria, Oxford, 1887), e non ammettono, dopo l'in-
cendio del 1462, la riedificazione dai fondamenti
del palazzo, bensì soltanto una ricostruzione par-
ziale, che nell'essenziale doveva strettamente se-
guire il concetto originario e non discostarsene se
non nei particolari formali, ricostruzione a cui ap-
parterrebbe specialmente in gran parte il portico
del pianterreno, mentre la distribuzione o le forme
adoperate nel piano di sopra, sebbene appartenenti
alla ricostruzione dopo il 1462, non ripeterebbero
se non quanto vi era già esistito prima. Discorrono
gli autori poi della cosidetta Sponza, cioè Dogana,
edifizio che appartiene a più secoli (il cortile e
pianterreno al xiv, il piano nobile al xv, il secondo
al xvi) e si distingue, più che pel concetto archi-
tettonico, per l'insieme pittoresco; di parecchi pa-
lazzi (palazzo Ismaelli, palazzo Bizzarro), avanzi dei
tesori d'architettura, di cui la ricca città si van-
tava fino verso la fine del Cinquecento; delle non
poche fontane monumentali, e del pilastro con la
statua di Orlando collocatavi sopra, per allargarsi
infine nella descrizione e rappresentazione figura-
tiva di alcune delle più cospicue ville, che ora in
stato più o meno rovinoso si vedono disseminate
sulle ridenti colline dei dintorni della città, seguo