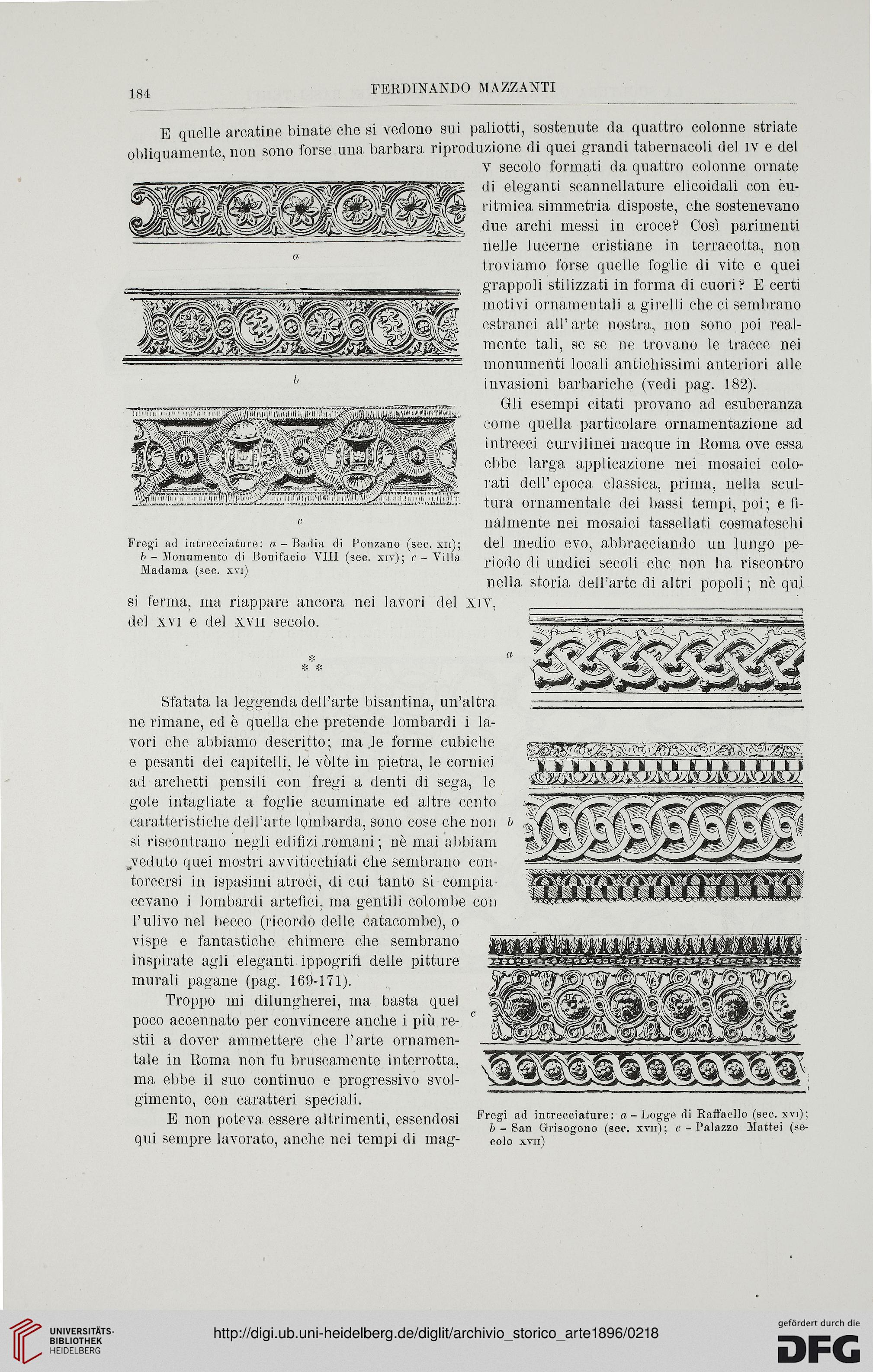184
FERDINANDO MAZZANTI
E quelle arcatine binate che si vedono sui paliotti, sostenute da quattro colonne striate
obliquamente, non sono forse una barbara riproduzione di quei grandi tabernacoli del iv e del
V secolo formati da quattro colonne ornate
di eleganti scannellature elicoidali con eu-
ritmica simmetria disposte, che sostenevano
due archi messi in croce? Così parimenti
nelle lucerne cristiane in terracotta, non
troviamo forse quelle foglie di vite e quei
grappoli stilizzati in forma di cuori? E certi
motivi ornamentali a girelli che ci sembrano
estranei all' arte nostra, non sono poi real-
mente tali, se se ne trovano le tracce nei
monumenti locali antichissimi anteriori alle
invasioni barbariche (vedi pag. 182).
Gli esempi citati provano ad esuberanza
come quella particolare ornamentazione ad
intrecci curvilinei nacque in Roma ove essa
ebbe larga applicazione nei mosaici colo-
rati dell'epoca classica, prima, nella scul-
tura ornamentale dei bassi tempi, poi; e fi-
6' nalmente nei mosaici tassellati cosmateschi
Fregi ad intrecciature: a - Badia di Ponzano (sec. xn); del medio evo, abbracciando Ull lllllgO pe-
b - Monumento di Bonifacio Vili (sec. xiv); e - Villa rj0C|0 di undici Secoli Che non Lia riscontro
Jj-LcLCIi\T11 £1 ( SGC» \ I )
nella storia dell'arte di altri popoli; nè qui
si ferma, ma riappare ancora nei lavori del xiv,
del xvi e del xvn secolo.
,-*6 i!J3W a sjriCXPU.i ■ Ò-.T5V _
*
* *
Sfatata la leggenda dell'arte bisantina, un'altra
ne rimane, ed è quella che pretende lombardi i la-
vori che abbiamo descritto; ma ,le forme cubiche
e pesanti dei capitelli, le vòlte in pietra, le cornici
ad archetti pensili con fregi a denti di sega, le
gole intagliate a foglie acuminate ed altre cento
caratteristiche dell'arte lombarda, sono cose che non
si riscontrano negli ed i fi zi .romani ; nè mai abbiam
.^veduto quei mostri avviticchiati che sembrano con-
torcersi in ispasimi atroci, di cui tanto si compia-
cevano i lombardi artefici, ma gentili colombe con
l'ulivo nel becco (ricordo delle catacombe), o
vispe e fantastiche chimere che sembrano
inspirate agli eleganti ippogrifì delle pitture
murali pagane (pag. 169-171).
Troppo mi dilungherei, ma basta quel
poco accennato per convincere anche i più re-
stii a dover ammettere che l'arte ornamen-
tale in Roma non fu bruscamente interrotta,
ma ebbe il suo continuo e progressivo svol-
gimento, con caratteri speciali.
E non poteva essere altrimenti, essendosi
qui sempre lavorato, anche nei tempi di mag-
Fregi ad intrecciature: «-Logge di Raffaello (sec. xvi);
b - San Grisogono (sec. xvix); c - Palazzo Mattei (se-
colo XVIl)
FERDINANDO MAZZANTI
E quelle arcatine binate che si vedono sui paliotti, sostenute da quattro colonne striate
obliquamente, non sono forse una barbara riproduzione di quei grandi tabernacoli del iv e del
V secolo formati da quattro colonne ornate
di eleganti scannellature elicoidali con eu-
ritmica simmetria disposte, che sostenevano
due archi messi in croce? Così parimenti
nelle lucerne cristiane in terracotta, non
troviamo forse quelle foglie di vite e quei
grappoli stilizzati in forma di cuori? E certi
motivi ornamentali a girelli che ci sembrano
estranei all' arte nostra, non sono poi real-
mente tali, se se ne trovano le tracce nei
monumenti locali antichissimi anteriori alle
invasioni barbariche (vedi pag. 182).
Gli esempi citati provano ad esuberanza
come quella particolare ornamentazione ad
intrecci curvilinei nacque in Roma ove essa
ebbe larga applicazione nei mosaici colo-
rati dell'epoca classica, prima, nella scul-
tura ornamentale dei bassi tempi, poi; e fi-
6' nalmente nei mosaici tassellati cosmateschi
Fregi ad intrecciature: a - Badia di Ponzano (sec. xn); del medio evo, abbracciando Ull lllllgO pe-
b - Monumento di Bonifacio Vili (sec. xiv); e - Villa rj0C|0 di undici Secoli Che non Lia riscontro
Jj-LcLCIi\T11 £1 ( SGC» \ I )
nella storia dell'arte di altri popoli; nè qui
si ferma, ma riappare ancora nei lavori del xiv,
del xvi e del xvn secolo.
,-*6 i!J3W a sjriCXPU.i ■ Ò-.T5V _
*
* *
Sfatata la leggenda dell'arte bisantina, un'altra
ne rimane, ed è quella che pretende lombardi i la-
vori che abbiamo descritto; ma ,le forme cubiche
e pesanti dei capitelli, le vòlte in pietra, le cornici
ad archetti pensili con fregi a denti di sega, le
gole intagliate a foglie acuminate ed altre cento
caratteristiche dell'arte lombarda, sono cose che non
si riscontrano negli ed i fi zi .romani ; nè mai abbiam
.^veduto quei mostri avviticchiati che sembrano con-
torcersi in ispasimi atroci, di cui tanto si compia-
cevano i lombardi artefici, ma gentili colombe con
l'ulivo nel becco (ricordo delle catacombe), o
vispe e fantastiche chimere che sembrano
inspirate agli eleganti ippogrifì delle pitture
murali pagane (pag. 169-171).
Troppo mi dilungherei, ma basta quel
poco accennato per convincere anche i più re-
stii a dover ammettere che l'arte ornamen-
tale in Roma non fu bruscamente interrotta,
ma ebbe il suo continuo e progressivo svol-
gimento, con caratteri speciali.
E non poteva essere altrimenti, essendosi
qui sempre lavorato, anche nei tempi di mag-
Fregi ad intrecciature: «-Logge di Raffaello (sec. xvi);
b - San Grisogono (sec. xvix); c - Palazzo Mattei (se-
colo XVIl)