Note: This is an additional scan to display the colour reference chart and scalebar.
0.5
1 cm
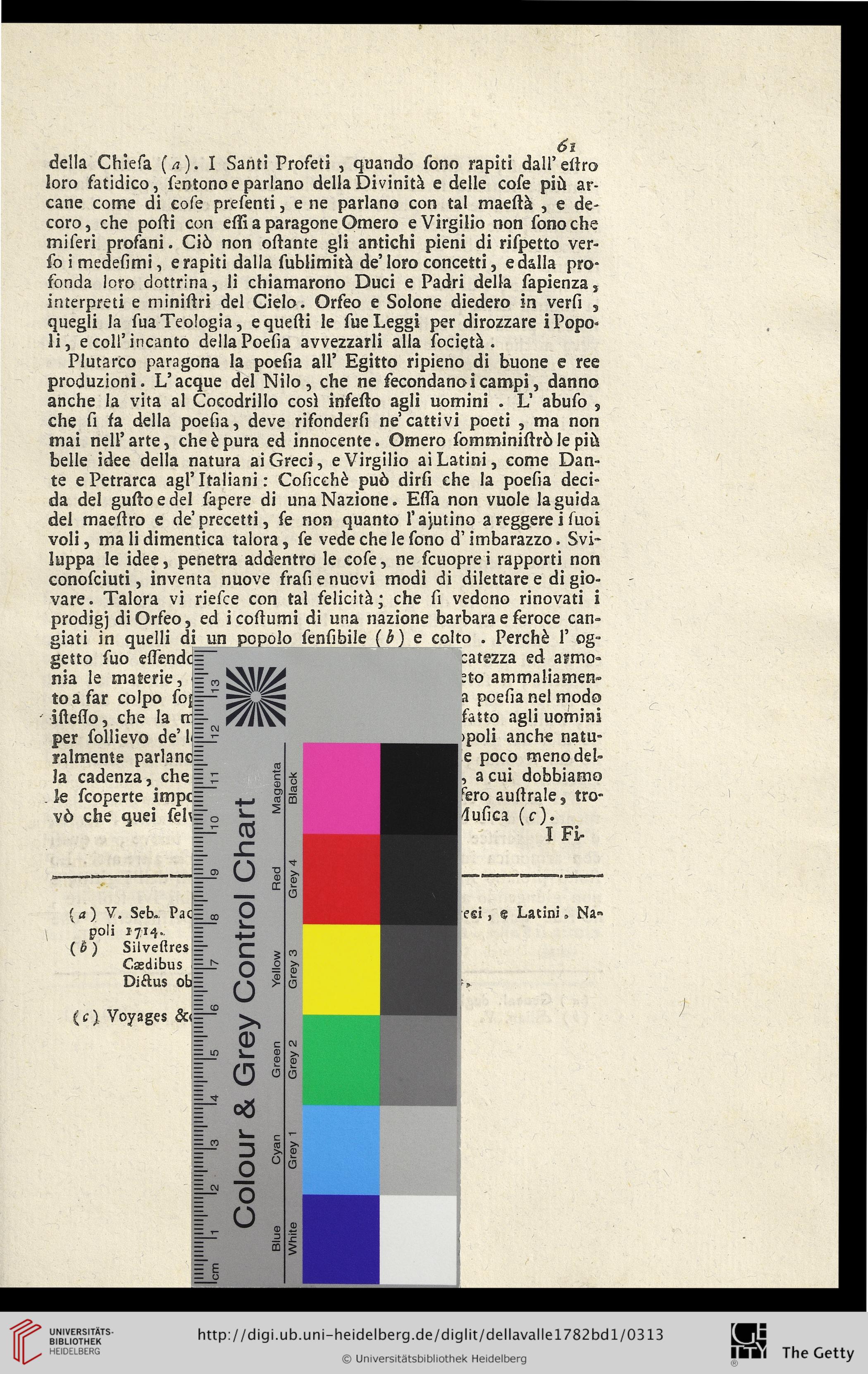
6i
della Ch iesa (/7). I Santi Profeti , qnando sono rapiti dall’ellro
loro fatidico, sentono e parlano della Divinità e delle cose più ar-
cane come di cose presenti, e ne parlano con tal maestà , e de-
coro, che posti con esìi a paragone Omero eVirgilio non sonoche
miseri profani. Ciò non ostante gli antichi pieni di rispetto ver-
so i medesimi, erapiti dalla sublimità de’ loro concetti, edalla pro»
fonda loro dottrina, li chiamarono Duci e Padri della sapienza,
interpreti e ministri del Cielo. Orseo e Solone diedero in versi ,
quegìi la suaTeoIogia, equesti le sue Leggi per dirozzare iPopo-
li, ecoll’incanto dellaPoesia avvezzarli alla società .
Plutarco paragona la poesia all’ Egitto ripieno di buone e ree
produzioni. L’acque del Nilo, che ne secondanoicampi, danno
anche Ia vita al CocodriIIo così insesto agli uomini . L’ abuso ,
che si fa della poesia, deve risonderfi ne cattivi poeti , ma non
mai nelf arte, cheèpura ed innocente. Omero somministrò le più
beìle idee della natura aiGreci, eVirgilio aiLatini, come Dan-
te e Petrarca agl’Italiani : Cosicchè può dirsi che la poesia deci»
da del gustoedel sapere di unaNazione. Esta non vuole laguida
del maestro e de’precetti, se non quanto l’ajutino a reggere i suoi
voli, ma li dimentica talora, se vede che le sono d’imbarazzo. Svi-
luppa Ie idee, penetra addentro le cose, ne scuopre i rapporti non
conosciuti, inventa nuove frasienucvi modi di dilettare e di gio-
vare. Talora vi riesce con taì felicità; che si vedono rinovati i
prodigj diOrfeo, ed icostumi di una nazione barbara e feroce can°
giati in quelli di un popolo sensibile (b) e colto . Perchè P og-
getto suo estendcjl- catezza ed armo-
nia Ie materie, = n ^to ammaliamen=>
toafar colpo sojl^ a pcesianelmodo
istesto, che Ia n]§- satto agli uomini
>poli anche natu-
e poco menodeb
, acui dobbiamo
sero australe, tro-
4usica (c).
I Fi-
per sollievo de’
ralmente parlanc-
la cadenza, che|
le scoperte impcE
vò che quei seh="o
( a ) V. Seb.. Pac
poli 1714.
(ù) Silvefìres
C.asdibus
Diftus ob
(c) Voyages &<§
eei, e Latini 9 Na«
della Ch iesa (/7). I Santi Profeti , qnando sono rapiti dall’ellro
loro fatidico, sentono e parlano della Divinità e delle cose più ar-
cane come di cose presenti, e ne parlano con tal maestà , e de-
coro, che posti con esìi a paragone Omero eVirgilio non sonoche
miseri profani. Ciò non ostante gli antichi pieni di rispetto ver-
so i medesimi, erapiti dalla sublimità de’ loro concetti, edalla pro»
fonda loro dottrina, li chiamarono Duci e Padri della sapienza,
interpreti e ministri del Cielo. Orseo e Solone diedero in versi ,
quegìi la suaTeoIogia, equesti le sue Leggi per dirozzare iPopo-
li, ecoll’incanto dellaPoesia avvezzarli alla società .
Plutarco paragona la poesia all’ Egitto ripieno di buone e ree
produzioni. L’acque del Nilo, che ne secondanoicampi, danno
anche Ia vita al CocodriIIo così insesto agli uomini . L’ abuso ,
che si fa della poesia, deve risonderfi ne cattivi poeti , ma non
mai nelf arte, cheèpura ed innocente. Omero somministrò le più
beìle idee della natura aiGreci, eVirgilio aiLatini, come Dan-
te e Petrarca agl’Italiani : Cosicchè può dirsi che la poesia deci»
da del gustoedel sapere di unaNazione. Esta non vuole laguida
del maestro e de’precetti, se non quanto l’ajutino a reggere i suoi
voli, ma li dimentica talora, se vede che le sono d’imbarazzo. Svi-
luppa Ie idee, penetra addentro le cose, ne scuopre i rapporti non
conosciuti, inventa nuove frasienucvi modi di dilettare e di gio-
vare. Talora vi riesce con taì felicità; che si vedono rinovati i
prodigj diOrfeo, ed icostumi di una nazione barbara e feroce can°
giati in quelli di un popolo sensibile (b) e colto . Perchè P og-
getto suo estendcjl- catezza ed armo-
nia Ie materie, = n ^to ammaliamen=>
toafar colpo sojl^ a pcesianelmodo
istesto, che Ia n]§- satto agli uomini
>poli anche natu-
e poco menodeb
, acui dobbiamo
sero australe, tro-
4usica (c).
I Fi-
per sollievo de’
ralmente parlanc-
la cadenza, che|
le scoperte impcE
vò che quei seh="o
( a ) V. Seb.. Pac
poli 1714.
(ù) Silvefìres
C.asdibus
Diftus ob
(c) Voyages &<§
eei, e Latini 9 Na«



