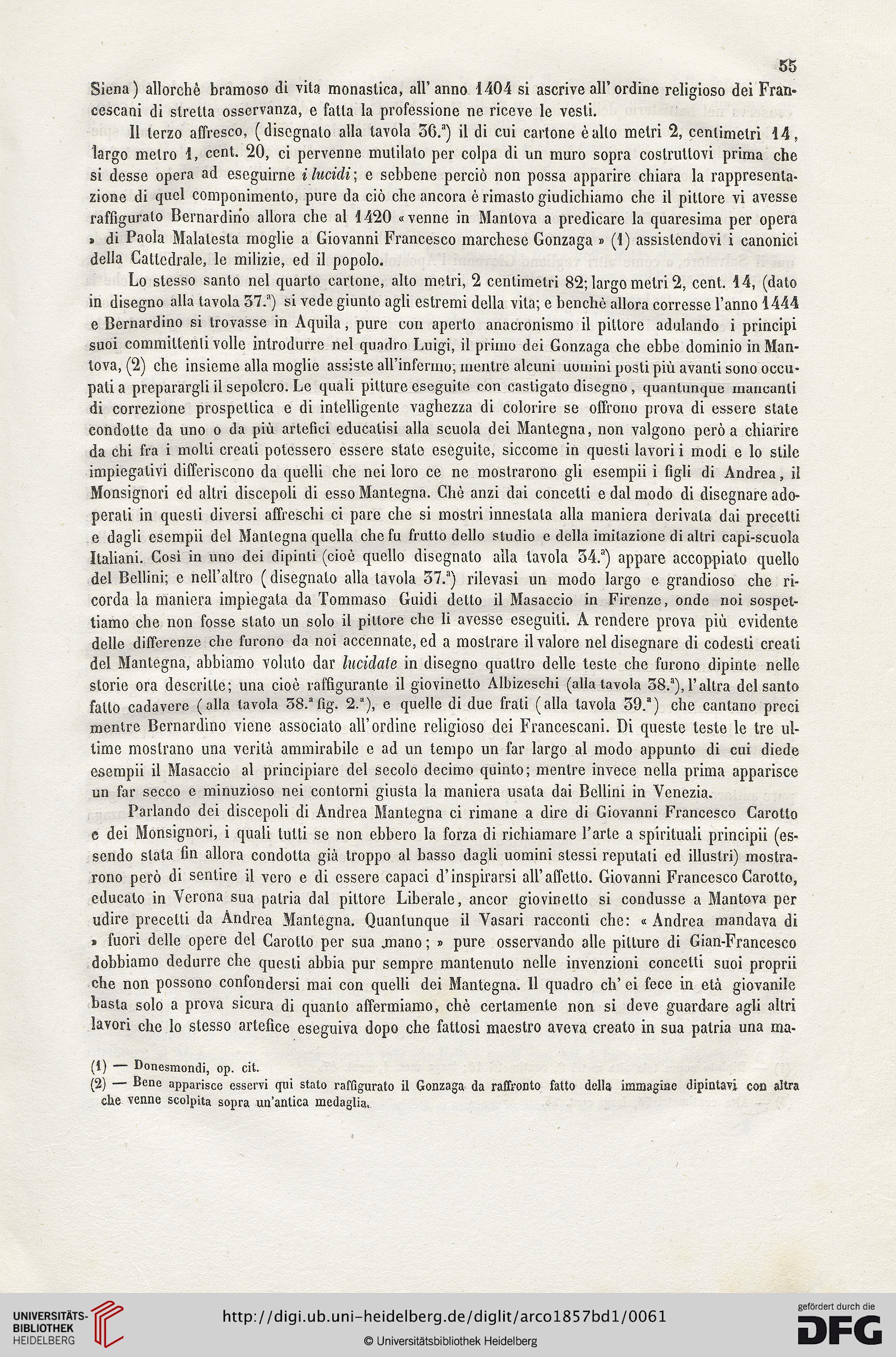55
Siena) allorchè bramoso di vita monastica, all’anno 1404 si ascrive all’ ordine religioso dei Fran-
cescani di stretta osservanza, e fatla la professione ne riceve le vesti.
11 lerzo affresco, (discgnato alla tavola 30. a) il di cui cartone èalto metri 2, centimetri 14,
largo melro 1, ccnt. 20, ci pervenne mutilalo per colpa di un muro sopra costruttovi prima che
si desse opera ad eseguirne i lucicli ; e sebbene perciò non possa apparire chiara la rappresenla-
zione di qucl componimento, pure da ciò chc ancora è rimasto giudichiamo che il pillore vi avesse
raffiguralo Bernardin’o allora che al 1420 «venne in Mantova a predicare la quaresima per opera
» di Paola Malatesta moglie a Giovanni Francesco marchesc Gonzaga » (1) assistcndovi i canonici
della Calledrale, lc milizie, ed il popolo.
Lo stesso santo nel quarto cartone, alto metri, 2 centimetri 82; largo metri 2, cent. 14, (dato
in disegno alla tavola 37. a) si vede giunto agli estremi della vita; e benchè allora corresse l’anno 1444
e Bernardino si trovasse in Aquila, pure con aperto anacronismo il piltore adulando i principi
suoi commiltenti volle introdurre nel quadro Luigi, il primo dei Gonzaga che ebbe dominio inMan-
lova, (2) che insicme alla moglie assiste all’infermo, mentre alcuni uomini posti più avanli sono occu-
pali a preparargli il sepolcro. Le quali pitture eseguile con casligato disegno , quantunque mancanti
di correzione prospetlica e di intelligente vaghezza di colorire se offrono prova di essere slate
eondotte da uno o da più artefici educatisi alla scuola dei Mantegna, non valgono però a chiarire
da chi fra i molti crcali potessero essere state eseguite, siccome in questi lavori i modi e lo stile
impiegativi differiscono da quelli che nci loro ce ne mostrarono gli esempii i figli di Andrea, il
Monsignori ed altri discepoli di esso Mantegna. Chè anzi dai concctti e dal modo di disegnare ado-
perali in questi diversi affreschi ci pare che si mostri inneslala alla maniera dcrivala dai precetti
e dagli esempii dcl Manlegna quella cliefu frutto dello studio e della imilazione di altri capi-scuola
Italiani. Così in uno dci dipimi (cioè qucllo disegnato alla tavola 54. a) appare accoppiato quello
del Bellini; e nell’altro ( disegnato alla lavola 57. a) rilevasi un modo largo c grandioso che ri-
corda la maniera impiegata da Tommaso Guidi dctto il Masaccio in Fircnzc, onde noi sospct-
tiamo che non fossc stato un solo il pittore che li avesse eseguiti. A rendere prova più evidente
delle differenze che furono da noi acccnnate, ed a moslrare il valore nel disegnare di codesti creati
del Mantegna, abbiamo voluto dar lucidate in disegno quattro delle tesle che furono dipinle nelle
storie ora descrilte; una cioè raffigurante il giovinetlo Albizeschi (alla tavola o8. a),l’altra del santo
fallo cadavere (alla lavola 38. afig. 2. a), e quelle di due frati (alla tavola 59. a) che cantano prcci
mcntre Bernardino viene associato all’ordine religioso dci Francescani. Di queste teste le tre ul-
time mostrano una verità ammirabile e ad un tenipo un far largo al modo appunto di cui diede
esempii il Masaccio al principiare del secolo decimo quinto; menlre invece nella prima apparisce
un far secco e minuzioso nei contorni giusta la manicra usata dai Bellini in Yenezia.
Parlando dei discepoli di Andrea Mantegna ci rimane a dire di Giovanni Francesco Carotto
c dei Monsignori, i quali tutti se non ebbero la forza di richiamare l’arte a spirituali principii (es-
sendo slata fin allora condolta già troppo al basso dagli uomini stessi reputati ed illustri) mostra-
rono però di sentire il vero e di cssere capaci d’inspirarsi all’ affetto. Giovanni Francesco Carotto,
educato in Verona sua palria dal pittore Liberale, ancor giovirtetto si condussc a Mantova per
udire precetti da Àndrea Mantegna. Quanlunque il Yasari racconti che: « Andrea mandava di
» fuori delle opere del Carotlo per sua jnano ; » pure osservando alle pillurc di Gian-Francesco
dobbiamo dedurre che quesli abbia pur sempre mantenuto nclle invenzioni concelti suoi proprii
che non possono confondersi mai con quelli dei Mantegna. 11 quadro ch’ ci fece in età giovanile
hasta solo a prova sicura di quanlo affermiamo, chè certamente non si deve guardare agli altri
lavori chc lo stesso artefice eseguiva dopo che fattosi macstro aveva creato in sua patria una ma-
(1) — Donesmondi, op. cit.
(2) — Bene apparisce esservi qui stato raffigurato it Gonzaga da raffronto fatto della immagine dipintavi con altra
che venne scolpita sopra un’antica medaglia.
Siena) allorchè bramoso di vita monastica, all’anno 1404 si ascrive all’ ordine religioso dei Fran-
cescani di stretta osservanza, e fatla la professione ne riceve le vesti.
11 lerzo affresco, (discgnato alla tavola 30. a) il di cui cartone èalto metri 2, centimetri 14,
largo melro 1, ccnt. 20, ci pervenne mutilalo per colpa di un muro sopra costruttovi prima che
si desse opera ad eseguirne i lucicli ; e sebbene perciò non possa apparire chiara la rappresenla-
zione di qucl componimento, pure da ciò chc ancora è rimasto giudichiamo che il pillore vi avesse
raffiguralo Bernardin’o allora che al 1420 «venne in Mantova a predicare la quaresima per opera
» di Paola Malatesta moglie a Giovanni Francesco marchesc Gonzaga » (1) assistcndovi i canonici
della Calledrale, lc milizie, ed il popolo.
Lo stesso santo nel quarto cartone, alto metri, 2 centimetri 82; largo metri 2, cent. 14, (dato
in disegno alla tavola 37. a) si vede giunto agli estremi della vita; e benchè allora corresse l’anno 1444
e Bernardino si trovasse in Aquila, pure con aperto anacronismo il piltore adulando i principi
suoi commiltenti volle introdurre nel quadro Luigi, il primo dei Gonzaga che ebbe dominio inMan-
lova, (2) che insicme alla moglie assiste all’infermo, mentre alcuni uomini posti più avanli sono occu-
pali a preparargli il sepolcro. Le quali pitture eseguile con casligato disegno , quantunque mancanti
di correzione prospetlica e di intelligente vaghezza di colorire se offrono prova di essere slate
eondotte da uno o da più artefici educatisi alla scuola dei Mantegna, non valgono però a chiarire
da chi fra i molti crcali potessero essere state eseguite, siccome in questi lavori i modi e lo stile
impiegativi differiscono da quelli che nci loro ce ne mostrarono gli esempii i figli di Andrea, il
Monsignori ed altri discepoli di esso Mantegna. Chè anzi dai concctti e dal modo di disegnare ado-
perali in questi diversi affreschi ci pare che si mostri inneslala alla maniera dcrivala dai precetti
e dagli esempii dcl Manlegna quella cliefu frutto dello studio e della imilazione di altri capi-scuola
Italiani. Così in uno dci dipimi (cioè qucllo disegnato alla tavola 54. a) appare accoppiato quello
del Bellini; e nell’altro ( disegnato alla lavola 57. a) rilevasi un modo largo c grandioso che ri-
corda la maniera impiegata da Tommaso Guidi dctto il Masaccio in Fircnzc, onde noi sospct-
tiamo che non fossc stato un solo il pittore che li avesse eseguiti. A rendere prova più evidente
delle differenze che furono da noi acccnnate, ed a moslrare il valore nel disegnare di codesti creati
del Mantegna, abbiamo voluto dar lucidate in disegno quattro delle tesle che furono dipinle nelle
storie ora descrilte; una cioè raffigurante il giovinetlo Albizeschi (alla tavola o8. a),l’altra del santo
fallo cadavere (alla lavola 38. afig. 2. a), e quelle di due frati (alla tavola 59. a) che cantano prcci
mcntre Bernardino viene associato all’ordine religioso dci Francescani. Di queste teste le tre ul-
time mostrano una verità ammirabile e ad un tenipo un far largo al modo appunto di cui diede
esempii il Masaccio al principiare del secolo decimo quinto; menlre invece nella prima apparisce
un far secco e minuzioso nei contorni giusta la manicra usata dai Bellini in Yenezia.
Parlando dei discepoli di Andrea Mantegna ci rimane a dire di Giovanni Francesco Carotto
c dei Monsignori, i quali tutti se non ebbero la forza di richiamare l’arte a spirituali principii (es-
sendo slata fin allora condolta già troppo al basso dagli uomini stessi reputati ed illustri) mostra-
rono però di sentire il vero e di cssere capaci d’inspirarsi all’ affetto. Giovanni Francesco Carotto,
educato in Verona sua palria dal pittore Liberale, ancor giovirtetto si condussc a Mantova per
udire precetti da Àndrea Mantegna. Quanlunque il Yasari racconti che: « Andrea mandava di
» fuori delle opere del Carotlo per sua jnano ; » pure osservando alle pillurc di Gian-Francesco
dobbiamo dedurre che quesli abbia pur sempre mantenuto nclle invenzioni concelti suoi proprii
che non possono confondersi mai con quelli dei Mantegna. 11 quadro ch’ ci fece in età giovanile
hasta solo a prova sicura di quanlo affermiamo, chè certamente non si deve guardare agli altri
lavori chc lo stesso artefice eseguiva dopo che fattosi macstro aveva creato in sua patria una ma-
(1) — Donesmondi, op. cit.
(2) — Bene apparisce esservi qui stato raffigurato it Gonzaga da raffronto fatto della immagine dipintavi con altra
che venne scolpita sopra un’antica medaglia.