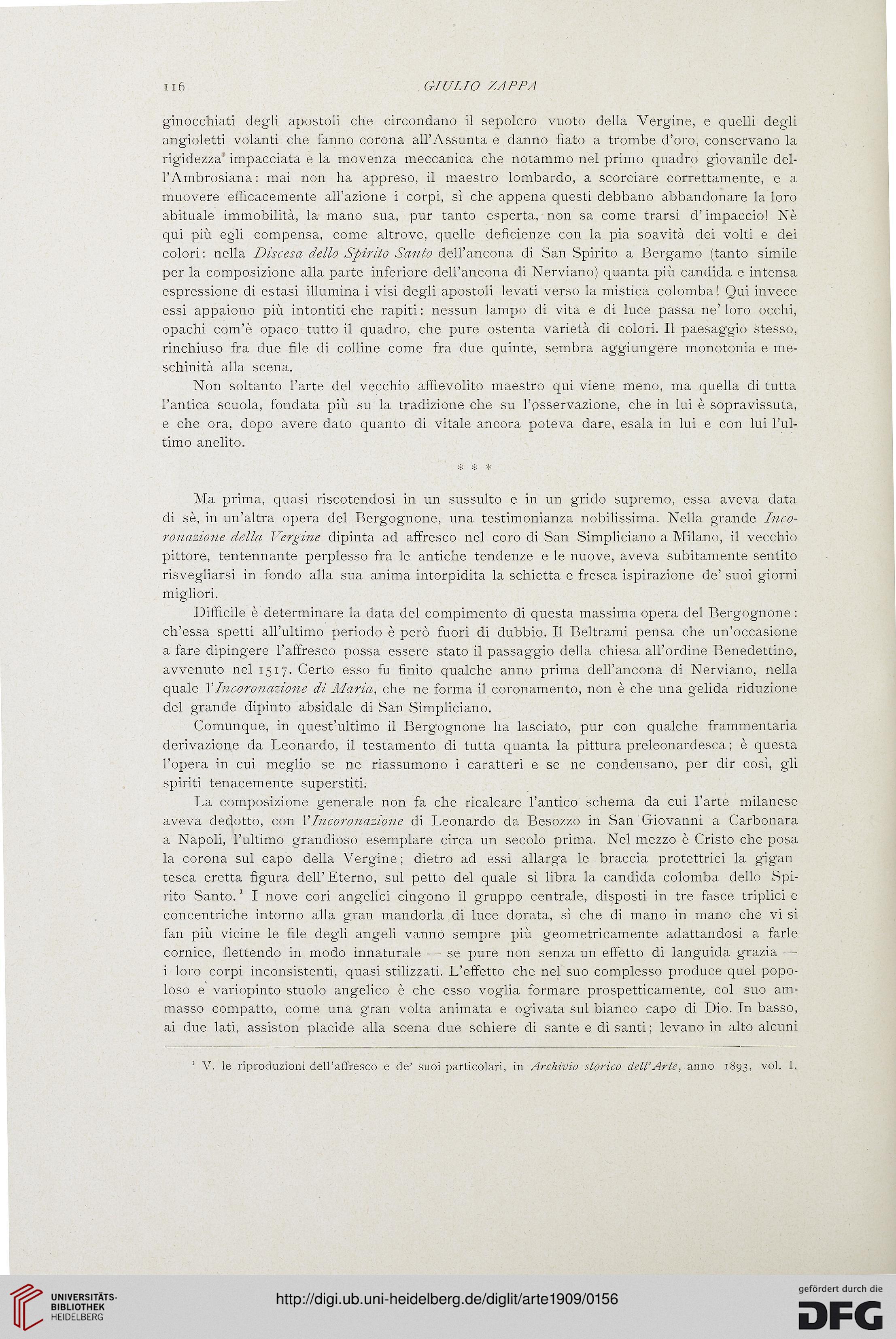GIULIO ZAPPA
116
ginocchiati degli apostoli che circondano il sepolcro vuoto della Vergine, e quelli degli
angioletti volanti che fanno corona all’Assunta e danno fiato a trombe d’oro, conservano la
rigidezza impacciata e la movenza meccanica che notammo nel primo quadro giovanile del-
l’Ambrosiana: mai non ha appreso, il maestro lombardo, a scorciare correttamente, e a
muovere efficacemente all’azione i corpi, sì che appena questi debbano abbandonare la loro
abituale immobilità, la mano sua, pur tanto esperta, non sa come trarsi d’impaccio! Nè
qui più egli compensa, come altrove, quelle deficienze con la pia soavità dei volti e dei
colori : nella Discesa dello Spirito Santo dell’ancona di San Spirito a Bergamo (tanto simile
per la composizione alla parte inferiore dell’ancona di Nerviano) quanta più candida e intensa
espressione di estasi illumina i visi degli apostoli levati verso la mistica colomba! Qui invece
essi appaiono più intontiti che rapiti : nessun lampo di vita e di luce passa ne’ loro occhi,
opachi com’è opaco tutto il quadro, che pure ostenta varietà di colori. Il paesaggio stesso,
rinchiuso fra due file di colline come fra due quinte, sembra aggiungere monotonia e me-
schinità alla scena.
Non soltanto l’arte del vecchio affievolito maestro qui viene meno, ma quella di tutta
l’antica scuola, fondata più su la tradizione che su l’osservazione, che in lui è sopravissuta,
e che ora, dopo avere dato quanto di vitale ancora poteva dare, esala in lui e con lui l’ul-
timo anelito.
Ma prima, quasi riscotendosi in un sussulto e in un grido supremo, essa aveva data
di sè, in un’altra opera del Bergognone, una testimonianza nobilissima. Nella grande Inco-
ronazione della Vergine dipinta ad affresco nel coro di San Simpliciano a Milano, il vecchio
pittore, tentennante perplesso fra le antiche tendenze e le nuove, aveva subitamente sentito
risvegliarsi in fondo alla sua anima intorpidita la schietta e fresca ispirazione de’ suoi giorni
migliori.
Difficile è determinare la data del compimento di questa massima opera del Bergognone :
ch’essa spetti all’ultimo periodo è però fuori di dubbio. Il Beltrami pensa che un’occasione
a fare dipingere l’affresco possa essere stato il passaggio della chiesa all’ordine Benedettino,
avvenuto nel 1517. Certo esso fu finito qualche anno prima dell’ancona di Nerviano, nella
quale l’Incoronazione di Maria, che ne forma il coronamento, non è che una gelida riduzione
del grande dipinto absidale di San Simpliciano.
Comunque, in quest’ultimo il Bergognone ha lasciato, pur con qualche frammentaria
derivazione da Leonardo, il testamento di tutta quanta la pittura preleonardesca ; è questa
l’opera in cui meglio se ne riassumono i caratteri e se ne condensano, per dir così, gli
spiriti tenacemente superstiti.
La composizione generale non fa che ricalcare l’antico schema da cui l’arte milanese
aveva dedotto, con l’Incoronazione di Leonardo da Besozzo in San Giovanni a Carbonara
a Napoli, l’ultimo grandioso esemplare circa un secolo prima. Nel mezzo è Cristo che posa
la corona sul capo della Vergine; dietro ad essi allarga, le braccia protettrici la gigan
tesca eretta figura dell’ Eterno, sul petto del quale si libra la candida colomba dello Spi-
rito Santo.1 I nove cori angelici cingono il gruppo centrale, disposti in tre fasce triplici e
concentriche intorno alla gran mandorla di luce dorata, sì che di mano in mano che vi si
fan più vicine le file degli angeli vanno sempre più geometricamente adattandosi a farle
cornice, flettendo in modo innaturale — se pure non senza un effetto di languida grazia —
i loro corpi inconsistenti, quasi stilizzati. L’effetto che nel suo complesso produce quel popo-
loso e variopinto stuolo angelico è che esso voglia formare prospetticamente, col suo am-
masso compatto, come una gran volta animata e ogivata sul bianco capo di Dio. In basso,
ai due lati, assiston placide alla scena due schiere di sante e di santi; levano in alto alcuni V.
V. le riproduzioni dell’affresco e de’ suoi particolari, in Archivio storico dell’Arte, anno 1893, voi. I,
116
ginocchiati degli apostoli che circondano il sepolcro vuoto della Vergine, e quelli degli
angioletti volanti che fanno corona all’Assunta e danno fiato a trombe d’oro, conservano la
rigidezza impacciata e la movenza meccanica che notammo nel primo quadro giovanile del-
l’Ambrosiana: mai non ha appreso, il maestro lombardo, a scorciare correttamente, e a
muovere efficacemente all’azione i corpi, sì che appena questi debbano abbandonare la loro
abituale immobilità, la mano sua, pur tanto esperta, non sa come trarsi d’impaccio! Nè
qui più egli compensa, come altrove, quelle deficienze con la pia soavità dei volti e dei
colori : nella Discesa dello Spirito Santo dell’ancona di San Spirito a Bergamo (tanto simile
per la composizione alla parte inferiore dell’ancona di Nerviano) quanta più candida e intensa
espressione di estasi illumina i visi degli apostoli levati verso la mistica colomba! Qui invece
essi appaiono più intontiti che rapiti : nessun lampo di vita e di luce passa ne’ loro occhi,
opachi com’è opaco tutto il quadro, che pure ostenta varietà di colori. Il paesaggio stesso,
rinchiuso fra due file di colline come fra due quinte, sembra aggiungere monotonia e me-
schinità alla scena.
Non soltanto l’arte del vecchio affievolito maestro qui viene meno, ma quella di tutta
l’antica scuola, fondata più su la tradizione che su l’osservazione, che in lui è sopravissuta,
e che ora, dopo avere dato quanto di vitale ancora poteva dare, esala in lui e con lui l’ul-
timo anelito.
Ma prima, quasi riscotendosi in un sussulto e in un grido supremo, essa aveva data
di sè, in un’altra opera del Bergognone, una testimonianza nobilissima. Nella grande Inco-
ronazione della Vergine dipinta ad affresco nel coro di San Simpliciano a Milano, il vecchio
pittore, tentennante perplesso fra le antiche tendenze e le nuove, aveva subitamente sentito
risvegliarsi in fondo alla sua anima intorpidita la schietta e fresca ispirazione de’ suoi giorni
migliori.
Difficile è determinare la data del compimento di questa massima opera del Bergognone :
ch’essa spetti all’ultimo periodo è però fuori di dubbio. Il Beltrami pensa che un’occasione
a fare dipingere l’affresco possa essere stato il passaggio della chiesa all’ordine Benedettino,
avvenuto nel 1517. Certo esso fu finito qualche anno prima dell’ancona di Nerviano, nella
quale l’Incoronazione di Maria, che ne forma il coronamento, non è che una gelida riduzione
del grande dipinto absidale di San Simpliciano.
Comunque, in quest’ultimo il Bergognone ha lasciato, pur con qualche frammentaria
derivazione da Leonardo, il testamento di tutta quanta la pittura preleonardesca ; è questa
l’opera in cui meglio se ne riassumono i caratteri e se ne condensano, per dir così, gli
spiriti tenacemente superstiti.
La composizione generale non fa che ricalcare l’antico schema da cui l’arte milanese
aveva dedotto, con l’Incoronazione di Leonardo da Besozzo in San Giovanni a Carbonara
a Napoli, l’ultimo grandioso esemplare circa un secolo prima. Nel mezzo è Cristo che posa
la corona sul capo della Vergine; dietro ad essi allarga, le braccia protettrici la gigan
tesca eretta figura dell’ Eterno, sul petto del quale si libra la candida colomba dello Spi-
rito Santo.1 I nove cori angelici cingono il gruppo centrale, disposti in tre fasce triplici e
concentriche intorno alla gran mandorla di luce dorata, sì che di mano in mano che vi si
fan più vicine le file degli angeli vanno sempre più geometricamente adattandosi a farle
cornice, flettendo in modo innaturale — se pure non senza un effetto di languida grazia —
i loro corpi inconsistenti, quasi stilizzati. L’effetto che nel suo complesso produce quel popo-
loso e variopinto stuolo angelico è che esso voglia formare prospetticamente, col suo am-
masso compatto, come una gran volta animata e ogivata sul bianco capo di Dio. In basso,
ai due lati, assiston placide alla scena due schiere di sante e di santi; levano in alto alcuni V.
V. le riproduzioni dell’affresco e de’ suoi particolari, in Archivio storico dell’Arte, anno 1893, voi. I,