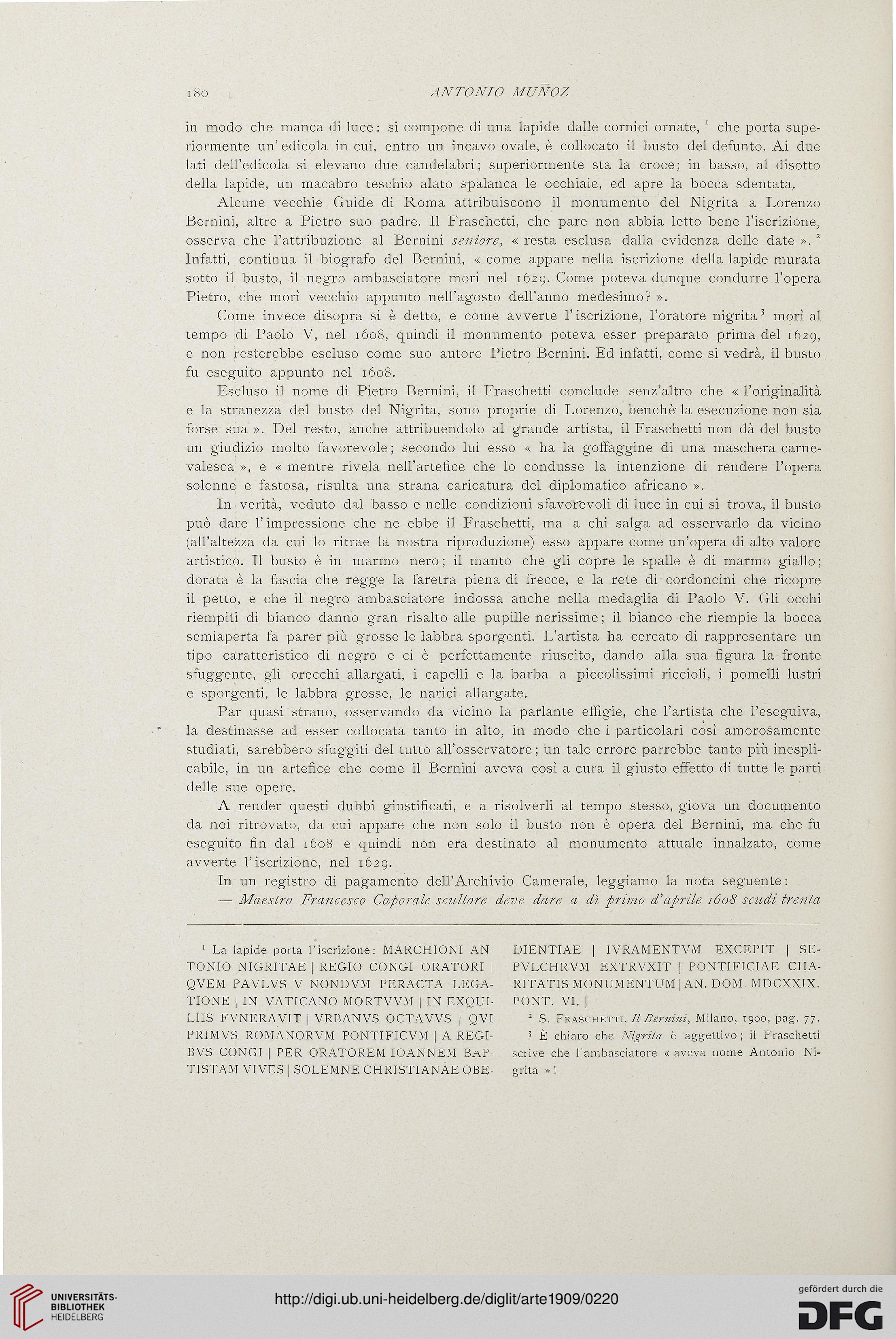ANTONIO MUNOZ
i So
in modo che manca di luce : si compone di una lapide dalle cornici ornate, 1 che porta supe-
riormente un’ edicola in cui, entro un incavo ovale, è collocato il busto del defunto. Ai due
lati dell’edicola si elevano due candelabri; superiormente sta la croce; in basso, al disotto
della lapide, un macabro teschio alato spalanca le occhiaie, ed apre la bocca sdentata,
Alcune vecchie Guide di Roma attribuiscono il monumento del Nigrita a Lorenzo
Bernini, altre a Pietro suo padre. Il Fraschetti, che pare non abbia letto bene l’iscrizione,
osserva che l’attribuzione al Bernini seniore, « resta esclusa dalla evidenza delle date ». 2
Infatti, continua il biografo del Bernini, « come appare nella iscrizione della lapide murata
sotto il busto, il negro ambasciatore morì nel 1629. Come poteva dunque condurre l’opera
Pietro, che morì vecchio appunto nell’agosto dell’anno medesimo? ».
Come invece disopra si è detto, e come avverte l’iscrizione, l’oratore nigrita3 morì al
tempo di Paolo V, nel 1608, quindi il monumento poteva esser preparato prima del 1629,
e non resterebbe escluso come suo autore Pietro Bernini. Ed infatti, come si vedrà, il busto
fu eseguito appunto nel 1608.
Escluso il nome di Pietro Bernini, il Fraschetti conclude senz’altro che « l’originalità
e la stranezza del busto del Nigrita, sono proprie di Lorenzo, benché la esecuzione non sia
forse sua ». Del resto, anche attribuendolo al grande artista, il Fraschetti non dà del busto
un giudizio molto favorevole; secondo lui esso « ha la goffaggine di una maschera carne-
valesca », e « mentre rivela nell’artefice che lo condusse la intenzione di rendere l’opera
solenne e fastosa, risulta una strana caricatura del diplomatico africano ».
In verità, veduto dal basso e nelle condizioni sfavorevoli di luce in cui si trova, il busto
può dare l’impressione che ne ebbe il Fraschetti, ma a chi salga ad osservarlo da vicino
(all’altezza da cui lo ritrae la nostra riproduzione) esso appare come un’opera di alto valore
artistico. Il busto è in marmo nero; il manto che gli copre le spalle è di marmo giallo;
dorata è la fascia che regge la faretra piena di frecce, e la rete di cordoncini che ricopre
il petto, e che il negro ambasciatore indossa anche nella medaglia di Paolo V. Gli occhi
riempiti di bianco danno gran risalto alle pupille nerissime ; il bianco che riempie la bocca
semiaperta fa parer più grosse le labbra sporgenti. L’artista ha cercato di rappresentare un
tipo caratteristico di negro e ci è perfettamente riuscito, dando alla sua figura la fronte
sfuggente, gli orecchi allargati, i capelli e la barba a piccolissimi riccioli, i pomelli lustri
e sporgenti, le labbra grosse, le narici allargate.
Par quasi strano, osservando da vicino la parlante effigie, che l’artista che l’eseguiva,
la destinasse ad esser collocata tanto in alto, in modo che i particolari così amorosamente
studiati, sarebbero sfuggiti del tutto all’osservatore; un tale errore parrebbe tanto più inespli-
cabile, in un artefice che come il Bernini aveva così a cura il giusto effetto di tutte le parti
delle sue opere.
A render questi dubbi giustificati, e a risolverli al tempo stesso, giova un documento
da noi ritrovato, da cui appare che non solo il busto non è opera del Bernini, ma che fu
eseguito fin dal 1608 e quindi non era destinato al monumento attuale innalzato, come
avverte l’iscrizione, nel 1629.
In un registro di pagamento dell’Archivio Camerale, leggiamo la nota seguente:
— Maestro Francesco Caporale scultore deve dare a dì primo d'aprile 1608 scudi trenta
1 La lapide porta l’iscrizione: MARCHIONI AN-
TONIO NIGRITAE | REGIO CONGI ORATORI
QVEM PAVLVS V NONDVM PERACTA LEGA-
TIONE | IN VATICANO IMORTVVIVI | IN EXQUI-
LIIS FVNERAVIT | VRBANVS OCTAVVS | QVI
PRIMVS ROMANORVM PONTIFICVM | A REGI-
BVS CONGI | PER ORATOREM IOANNEM BaP-
TISTAM VIVES j SOLEMNE CHRISTIANAE OBE-
DIENTIAE | 1VRAMENTVM EXCEPIT | SE-
PVLCHRVM EXTRVXIT | PONTI ITCIAE CHA-
RITATIS MONUMENTUM | AN. DOM MDCXXIX.
PONT. VI. |
2 S. Fraschetti, Il Bernini, Milano, 1900, pag. 77.
3 È chiaro che Nigrita è aggettivo; il Fraschetti
scrive che l'ambasciatore « aveva nome Antonio Ni-
grita » !
i So
in modo che manca di luce : si compone di una lapide dalle cornici ornate, 1 che porta supe-
riormente un’ edicola in cui, entro un incavo ovale, è collocato il busto del defunto. Ai due
lati dell’edicola si elevano due candelabri; superiormente sta la croce; in basso, al disotto
della lapide, un macabro teschio alato spalanca le occhiaie, ed apre la bocca sdentata,
Alcune vecchie Guide di Roma attribuiscono il monumento del Nigrita a Lorenzo
Bernini, altre a Pietro suo padre. Il Fraschetti, che pare non abbia letto bene l’iscrizione,
osserva che l’attribuzione al Bernini seniore, « resta esclusa dalla evidenza delle date ». 2
Infatti, continua il biografo del Bernini, « come appare nella iscrizione della lapide murata
sotto il busto, il negro ambasciatore morì nel 1629. Come poteva dunque condurre l’opera
Pietro, che morì vecchio appunto nell’agosto dell’anno medesimo? ».
Come invece disopra si è detto, e come avverte l’iscrizione, l’oratore nigrita3 morì al
tempo di Paolo V, nel 1608, quindi il monumento poteva esser preparato prima del 1629,
e non resterebbe escluso come suo autore Pietro Bernini. Ed infatti, come si vedrà, il busto
fu eseguito appunto nel 1608.
Escluso il nome di Pietro Bernini, il Fraschetti conclude senz’altro che « l’originalità
e la stranezza del busto del Nigrita, sono proprie di Lorenzo, benché la esecuzione non sia
forse sua ». Del resto, anche attribuendolo al grande artista, il Fraschetti non dà del busto
un giudizio molto favorevole; secondo lui esso « ha la goffaggine di una maschera carne-
valesca », e « mentre rivela nell’artefice che lo condusse la intenzione di rendere l’opera
solenne e fastosa, risulta una strana caricatura del diplomatico africano ».
In verità, veduto dal basso e nelle condizioni sfavorevoli di luce in cui si trova, il busto
può dare l’impressione che ne ebbe il Fraschetti, ma a chi salga ad osservarlo da vicino
(all’altezza da cui lo ritrae la nostra riproduzione) esso appare come un’opera di alto valore
artistico. Il busto è in marmo nero; il manto che gli copre le spalle è di marmo giallo;
dorata è la fascia che regge la faretra piena di frecce, e la rete di cordoncini che ricopre
il petto, e che il negro ambasciatore indossa anche nella medaglia di Paolo V. Gli occhi
riempiti di bianco danno gran risalto alle pupille nerissime ; il bianco che riempie la bocca
semiaperta fa parer più grosse le labbra sporgenti. L’artista ha cercato di rappresentare un
tipo caratteristico di negro e ci è perfettamente riuscito, dando alla sua figura la fronte
sfuggente, gli orecchi allargati, i capelli e la barba a piccolissimi riccioli, i pomelli lustri
e sporgenti, le labbra grosse, le narici allargate.
Par quasi strano, osservando da vicino la parlante effigie, che l’artista che l’eseguiva,
la destinasse ad esser collocata tanto in alto, in modo che i particolari così amorosamente
studiati, sarebbero sfuggiti del tutto all’osservatore; un tale errore parrebbe tanto più inespli-
cabile, in un artefice che come il Bernini aveva così a cura il giusto effetto di tutte le parti
delle sue opere.
A render questi dubbi giustificati, e a risolverli al tempo stesso, giova un documento
da noi ritrovato, da cui appare che non solo il busto non è opera del Bernini, ma che fu
eseguito fin dal 1608 e quindi non era destinato al monumento attuale innalzato, come
avverte l’iscrizione, nel 1629.
In un registro di pagamento dell’Archivio Camerale, leggiamo la nota seguente:
— Maestro Francesco Caporale scultore deve dare a dì primo d'aprile 1608 scudi trenta
1 La lapide porta l’iscrizione: MARCHIONI AN-
TONIO NIGRITAE | REGIO CONGI ORATORI
QVEM PAVLVS V NONDVM PERACTA LEGA-
TIONE | IN VATICANO IMORTVVIVI | IN EXQUI-
LIIS FVNERAVIT | VRBANVS OCTAVVS | QVI
PRIMVS ROMANORVM PONTIFICVM | A REGI-
BVS CONGI | PER ORATOREM IOANNEM BaP-
TISTAM VIVES j SOLEMNE CHRISTIANAE OBE-
DIENTIAE | 1VRAMENTVM EXCEPIT | SE-
PVLCHRVM EXTRVXIT | PONTI ITCIAE CHA-
RITATIS MONUMENTUM | AN. DOM MDCXXIX.
PONT. VI. |
2 S. Fraschetti, Il Bernini, Milano, 1900, pag. 77.
3 È chiaro che Nigrita è aggettivo; il Fraschetti
scrive che l'ambasciatore « aveva nome Antonio Ni-
grita » !