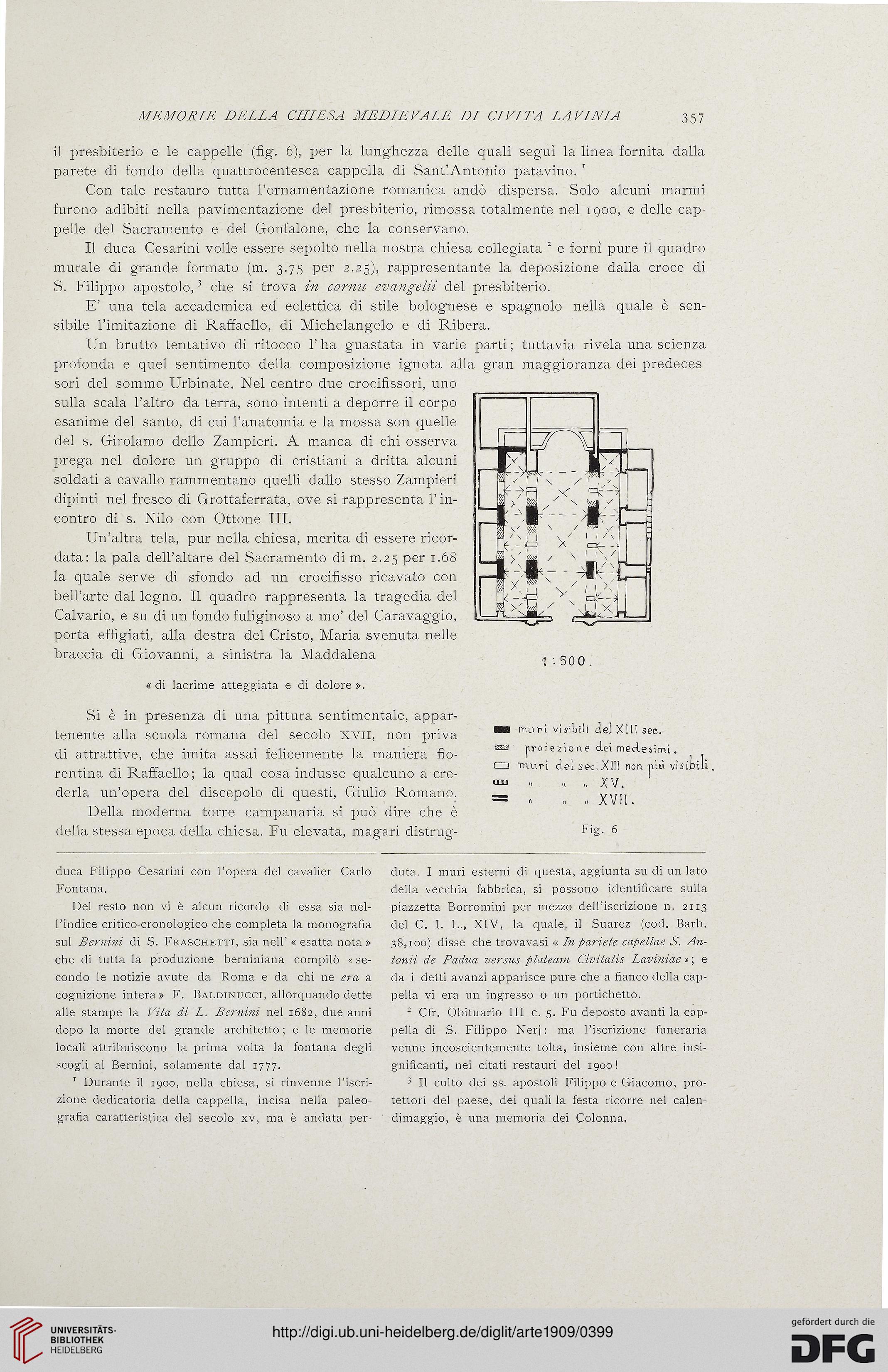MEMORIE DELLA CHIESA MEDIEVALE DI CIVITA LAVINIA
357
il presbiterio e le cappelle (fig. 6), per la lunghezza delle quali seguì la linea fornita dalla
parete di fondo della quattrocentesca cappella di Sant’Antonio patavino. 1
Con tale restauro tutta l’ornamentazione romanica andò dispersa. Solo alcuni marmi
furono adibiti nella pavimentazione del presbiterio, rimossa totalmente nel 1900, e delle cap-
pelle del Sacramento e del Gonfalone, che la conservano.
Il duca Cesarmi volle essere sepolto nella nostra chiesa collegiata 2 e fornì pure il quadro
murale di grande formato (m. 3.73 per 2.25), rappresentante la deposizione dalla croce di
S. Filippo apostolo,3 che si trova in cornu evangelii del presbiterio.
E’ una tela accademica ed eclettica di stile bolognese e spagnolo nella quale è sen-
sibile l’imitazione di Raffaello, di Michelangelo e di Ribera.
Un brutto tentativo di ritocco l’ha guastata in varie parti ; tuttavia rivela una scienza
profonda e quel sentimento della composizione ignota alla gran maggioranza dei predeces
sori del sommo Urbinate. Nel centro due crocifissori, uno
sulla scala l’altro da terra, sono intenti a deporre il corpo
esanime del santo, di cui l’anatomia e la mossa son quelle
del s. Girolamo dello Zampieri. A manca di chi osserva
prega nel dolore un gruppo di cristiani a dritta alcuni
soldati a cavallo rammentano quelli dallo stesso Zampieri
dipinti nel fresco di Grottaferrata, ove si rappresenta l’in-
contro di s. Nilo con Ottone III.
Un’altra tela, pur nella chiesa, merita di essere ricor-
data: la pala dell’altare del Sacramento di m. 2.25 per 1.68
la quale serve di sfondo ad un crocifisso ricavato con
bell’arte dal legno. Il quadro rappresenta la tragedia del
Calvario, e su di un fondo fuliginoso a mo’ del Caravaggio,
porta effigiati, alla destra del Cristo, Maria svenuta nelle
braccia di Giovanni, a sinistra la Maddalena
«di lacrime atteggiata e di dolore».
Si è in presenza di una pittura sentimentale, appar-
tenente alla scuola romana del secolo XVII, non priva
di attrattive, che imita assai felicemente la maniera fio-
rentina di Raffaello; la qual cosa indusse qualcuno a cre-
derla un’opera del discepolo di questi, Giulio Romano.
Della moderna torre campanaria si può dire che è
della stessa epoca della chiesa. Fu elevata, magari distrug-
na mirri visibìli del XII! sec.
^3 Jtrorezione dei medesimi.
cn Tauri del sec.XH! non imi visitili.
™ « .« .. XV.
= .XVII.
Fig. 6
duca Filippo Cesarini con l’opera del cavalier Carlo
Fontana.
Del resto non vi è alcun ricordo di essa sia nel-
l’indice critico-cronologico che completa la monografia
sul Bernini di S. Fraschetta sia nell’ « esatta nota »
che di tutta la produzione berniniana compilò «se-
condo le notizie avute da Roma e da chi ne era a
cognizione intera» F. Baldinucci, allorquando dette
alle stampe la Vita di L. Bernini nel 1682, due anni
dopo la morte del grande architetto ; e le memorie
locali attribuiscono la prima volta la fontana degli
scogli al Bernini, solamente dal 1777.
1 Durante il 1900, nella chiesa, si rinvenne l’iscri-
zione dedicatoria della cappella, incisa nella paleo-
grafia caratteristica del secolo xv, ma è andata per-
duta. I muri esterni di questa, aggiunta su di un lato
della vecchia fabbrica, si possono identificare sulla
piazzetta Borromini per mezzo dell’iscrizione n. 2113
del C. I. L., XIV, la quale, il Suarez (cod. Barb.
38,100) disse che trovavasi « In parie te capellae S. An-
tonii de Padua versus plateam Civitatis Laviniae » ; e
da i detti avanzi apparisce pure che a fianco della cap-
pella vi era un ingresso o un portichetto.
2 Cfr. Obituario III c. 5. Fu deposto avanti la cap-
pella di S. Filippo Nerj : ma l’iscrizione funeraria
venne incoscientemente tolta, insieme con altre insi-
gnificanti, nei citati restauri del 1900!
3 II culto dei ss. apostoli Filippo e Giacomo, pro-
tettori del paese, dei quali la festa ricorre nel calen-
dimaggio, è una memoria dei Colonna,
357
il presbiterio e le cappelle (fig. 6), per la lunghezza delle quali seguì la linea fornita dalla
parete di fondo della quattrocentesca cappella di Sant’Antonio patavino. 1
Con tale restauro tutta l’ornamentazione romanica andò dispersa. Solo alcuni marmi
furono adibiti nella pavimentazione del presbiterio, rimossa totalmente nel 1900, e delle cap-
pelle del Sacramento e del Gonfalone, che la conservano.
Il duca Cesarmi volle essere sepolto nella nostra chiesa collegiata 2 e fornì pure il quadro
murale di grande formato (m. 3.73 per 2.25), rappresentante la deposizione dalla croce di
S. Filippo apostolo,3 che si trova in cornu evangelii del presbiterio.
E’ una tela accademica ed eclettica di stile bolognese e spagnolo nella quale è sen-
sibile l’imitazione di Raffaello, di Michelangelo e di Ribera.
Un brutto tentativo di ritocco l’ha guastata in varie parti ; tuttavia rivela una scienza
profonda e quel sentimento della composizione ignota alla gran maggioranza dei predeces
sori del sommo Urbinate. Nel centro due crocifissori, uno
sulla scala l’altro da terra, sono intenti a deporre il corpo
esanime del santo, di cui l’anatomia e la mossa son quelle
del s. Girolamo dello Zampieri. A manca di chi osserva
prega nel dolore un gruppo di cristiani a dritta alcuni
soldati a cavallo rammentano quelli dallo stesso Zampieri
dipinti nel fresco di Grottaferrata, ove si rappresenta l’in-
contro di s. Nilo con Ottone III.
Un’altra tela, pur nella chiesa, merita di essere ricor-
data: la pala dell’altare del Sacramento di m. 2.25 per 1.68
la quale serve di sfondo ad un crocifisso ricavato con
bell’arte dal legno. Il quadro rappresenta la tragedia del
Calvario, e su di un fondo fuliginoso a mo’ del Caravaggio,
porta effigiati, alla destra del Cristo, Maria svenuta nelle
braccia di Giovanni, a sinistra la Maddalena
«di lacrime atteggiata e di dolore».
Si è in presenza di una pittura sentimentale, appar-
tenente alla scuola romana del secolo XVII, non priva
di attrattive, che imita assai felicemente la maniera fio-
rentina di Raffaello; la qual cosa indusse qualcuno a cre-
derla un’opera del discepolo di questi, Giulio Romano.
Della moderna torre campanaria si può dire che è
della stessa epoca della chiesa. Fu elevata, magari distrug-
na mirri visibìli del XII! sec.
^3 Jtrorezione dei medesimi.
cn Tauri del sec.XH! non imi visitili.
™ « .« .. XV.
= .XVII.
Fig. 6
duca Filippo Cesarini con l’opera del cavalier Carlo
Fontana.
Del resto non vi è alcun ricordo di essa sia nel-
l’indice critico-cronologico che completa la monografia
sul Bernini di S. Fraschetta sia nell’ « esatta nota »
che di tutta la produzione berniniana compilò «se-
condo le notizie avute da Roma e da chi ne era a
cognizione intera» F. Baldinucci, allorquando dette
alle stampe la Vita di L. Bernini nel 1682, due anni
dopo la morte del grande architetto ; e le memorie
locali attribuiscono la prima volta la fontana degli
scogli al Bernini, solamente dal 1777.
1 Durante il 1900, nella chiesa, si rinvenne l’iscri-
zione dedicatoria della cappella, incisa nella paleo-
grafia caratteristica del secolo xv, ma è andata per-
duta. I muri esterni di questa, aggiunta su di un lato
della vecchia fabbrica, si possono identificare sulla
piazzetta Borromini per mezzo dell’iscrizione n. 2113
del C. I. L., XIV, la quale, il Suarez (cod. Barb.
38,100) disse che trovavasi « In parie te capellae S. An-
tonii de Padua versus plateam Civitatis Laviniae » ; e
da i detti avanzi apparisce pure che a fianco della cap-
pella vi era un ingresso o un portichetto.
2 Cfr. Obituario III c. 5. Fu deposto avanti la cap-
pella di S. Filippo Nerj : ma l’iscrizione funeraria
venne incoscientemente tolta, insieme con altre insi-
gnificanti, nei citati restauri del 1900!
3 II culto dei ss. apostoli Filippo e Giacomo, pro-
tettori del paese, dei quali la festa ricorre nel calen-
dimaggio, è una memoria dei Colonna,