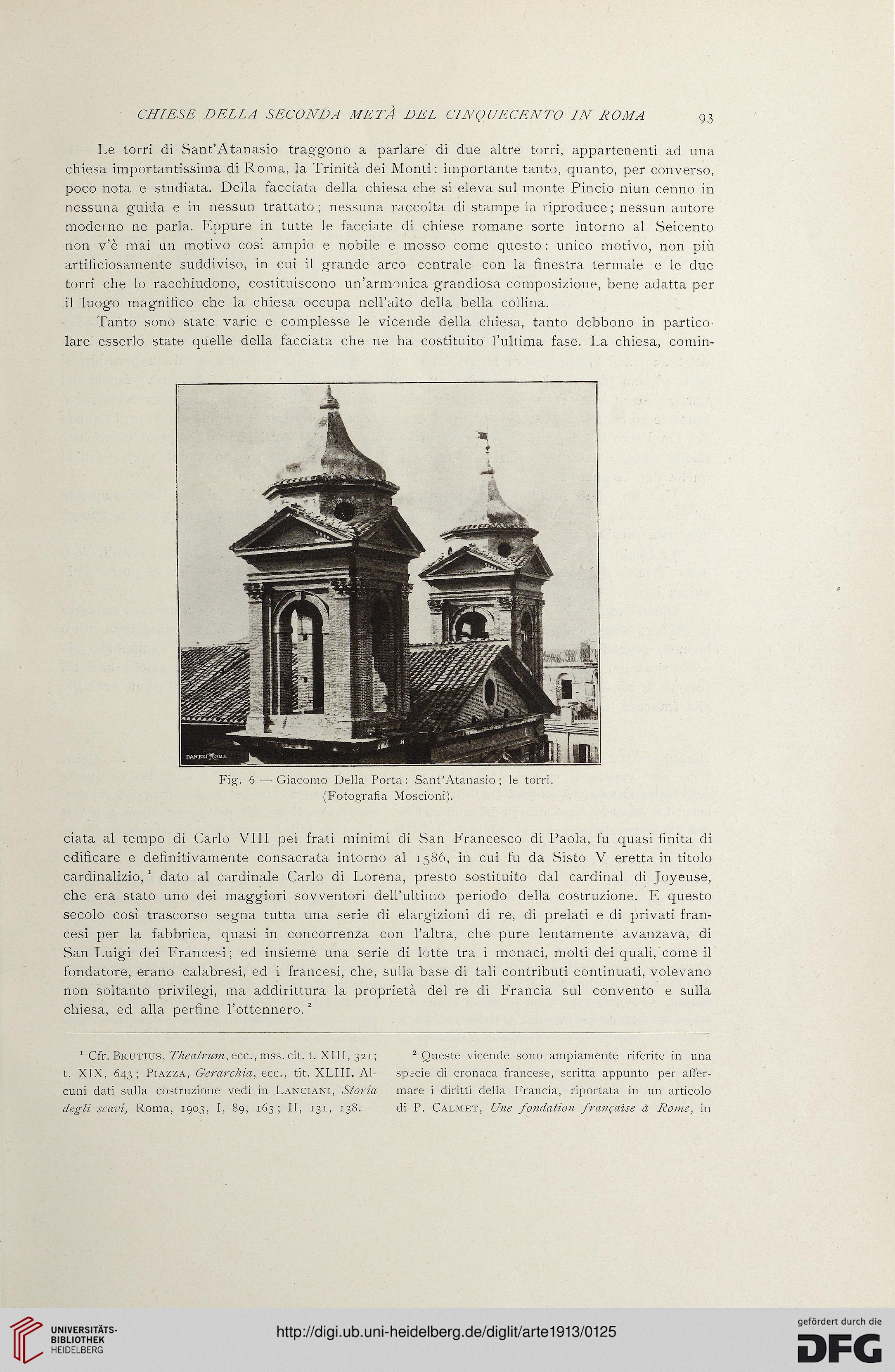CHIESE DELLA SECONDA METÀ DEL CINQUECENTO IN ROMA
93
Le torri di Sant’Atanasio traggono a parlare di due altre torri, appartenenti ad una
chiesa importantissima di Roma, la Trinità dei Monti: importante tanto, quanto, per converso,
poco nota e studiata. Della facciata della chiesa che si eleva sul monte Pincio niun cenno in
nessuna guida e in nessun trattato; nessuna raccolta di stampe la riproduce; nessun autore
moderno ne parla. Eppure in tutte le facciate di chiese romane sorte intorno al Seicento
non v’è mai un motivo così ampio e nobile e mosso come questo : unico motivo, non più
artificiosamente suddiviso, in cui il grande arco centrale con la finestra termale e le due
torri che lo racchiudono, costituiscono un’armonica grandiosa composizione, bene adatta per
il luogo magnifico che la chiesa occupa nell’alto della bella collina.
Tanto sono state varie e complesse le vicende della chiesa, tanto debbono in partico-
lare esserlo state quelle della facciata che ne ha costituito l’ultima fase. La chiesa, comin-
Fig. 6 — Giacomo Della Porta: Sant’Atanasio; le torri.
(Fotografia Moscioni).
ciata al tempo di Carlo Vili pei frati minimi di San Francesco di Paola, fu quasi finita di
edificare e definitivamente consacrata intorno al 1586, in cui fu da Sisto V eretta in titolo
cardinalizio, 1 dato al cardinale Carlo di Lorena, presto sostituito dal Cardinal di Joyeuse,
che era stato uno dei maggiori sovventori dell’ultimo periodo della costruzione. E questo
secolo così trascorso segna tutta una serie di elargizioni di re, di prelati e di privati fran-
cesi per la fabbrica, quasi in concorrenza con l’altra, che pure lentamente avanzava, di
San Luigi dei Francesi; ed insieme una serie di lotte tra i monaci, molti dei quali, come il
fondatore, erano calabresi, ed i francesi, che, sulla base di tali contributi continuati, volevano
non soltanto privilegi, ma addirittura la proprietà del re di Francia sul convento e sulla
chiesa, ed alla perfine l’ottennero.2
1 Cfr. Brutius, Theatrum, ecc., mss. cit. t. XIII, 321;
t. XIX, 643; Piazza, Gerarchia, ecc., tit. XLIII. Al-
cuni dati sulla costruzione vedi in Lanciami, Storia
degli scavi, Roma, 1903, I, 89, 163; II, 131, 138.
2 Queste vicende sono ampiamente riferite in una
specie di cronaca francese, scritta appunto per affer-
mare i diritti della Francia, riportata in un articolo
di P. Calmet, Une fondation frangaise à Rome, in
93
Le torri di Sant’Atanasio traggono a parlare di due altre torri, appartenenti ad una
chiesa importantissima di Roma, la Trinità dei Monti: importante tanto, quanto, per converso,
poco nota e studiata. Della facciata della chiesa che si eleva sul monte Pincio niun cenno in
nessuna guida e in nessun trattato; nessuna raccolta di stampe la riproduce; nessun autore
moderno ne parla. Eppure in tutte le facciate di chiese romane sorte intorno al Seicento
non v’è mai un motivo così ampio e nobile e mosso come questo : unico motivo, non più
artificiosamente suddiviso, in cui il grande arco centrale con la finestra termale e le due
torri che lo racchiudono, costituiscono un’armonica grandiosa composizione, bene adatta per
il luogo magnifico che la chiesa occupa nell’alto della bella collina.
Tanto sono state varie e complesse le vicende della chiesa, tanto debbono in partico-
lare esserlo state quelle della facciata che ne ha costituito l’ultima fase. La chiesa, comin-
Fig. 6 — Giacomo Della Porta: Sant’Atanasio; le torri.
(Fotografia Moscioni).
ciata al tempo di Carlo Vili pei frati minimi di San Francesco di Paola, fu quasi finita di
edificare e definitivamente consacrata intorno al 1586, in cui fu da Sisto V eretta in titolo
cardinalizio, 1 dato al cardinale Carlo di Lorena, presto sostituito dal Cardinal di Joyeuse,
che era stato uno dei maggiori sovventori dell’ultimo periodo della costruzione. E questo
secolo così trascorso segna tutta una serie di elargizioni di re, di prelati e di privati fran-
cesi per la fabbrica, quasi in concorrenza con l’altra, che pure lentamente avanzava, di
San Luigi dei Francesi; ed insieme una serie di lotte tra i monaci, molti dei quali, come il
fondatore, erano calabresi, ed i francesi, che, sulla base di tali contributi continuati, volevano
non soltanto privilegi, ma addirittura la proprietà del re di Francia sul convento e sulla
chiesa, ed alla perfine l’ottennero.2
1 Cfr. Brutius, Theatrum, ecc., mss. cit. t. XIII, 321;
t. XIX, 643; Piazza, Gerarchia, ecc., tit. XLIII. Al-
cuni dati sulla costruzione vedi in Lanciami, Storia
degli scavi, Roma, 1903, I, 89, 163; II, 131, 138.
2 Queste vicende sono ampiamente riferite in una
specie di cronaca francese, scritta appunto per affer-
mare i diritti della Francia, riportata in un articolo
di P. Calmet, Une fondation frangaise à Rome, in