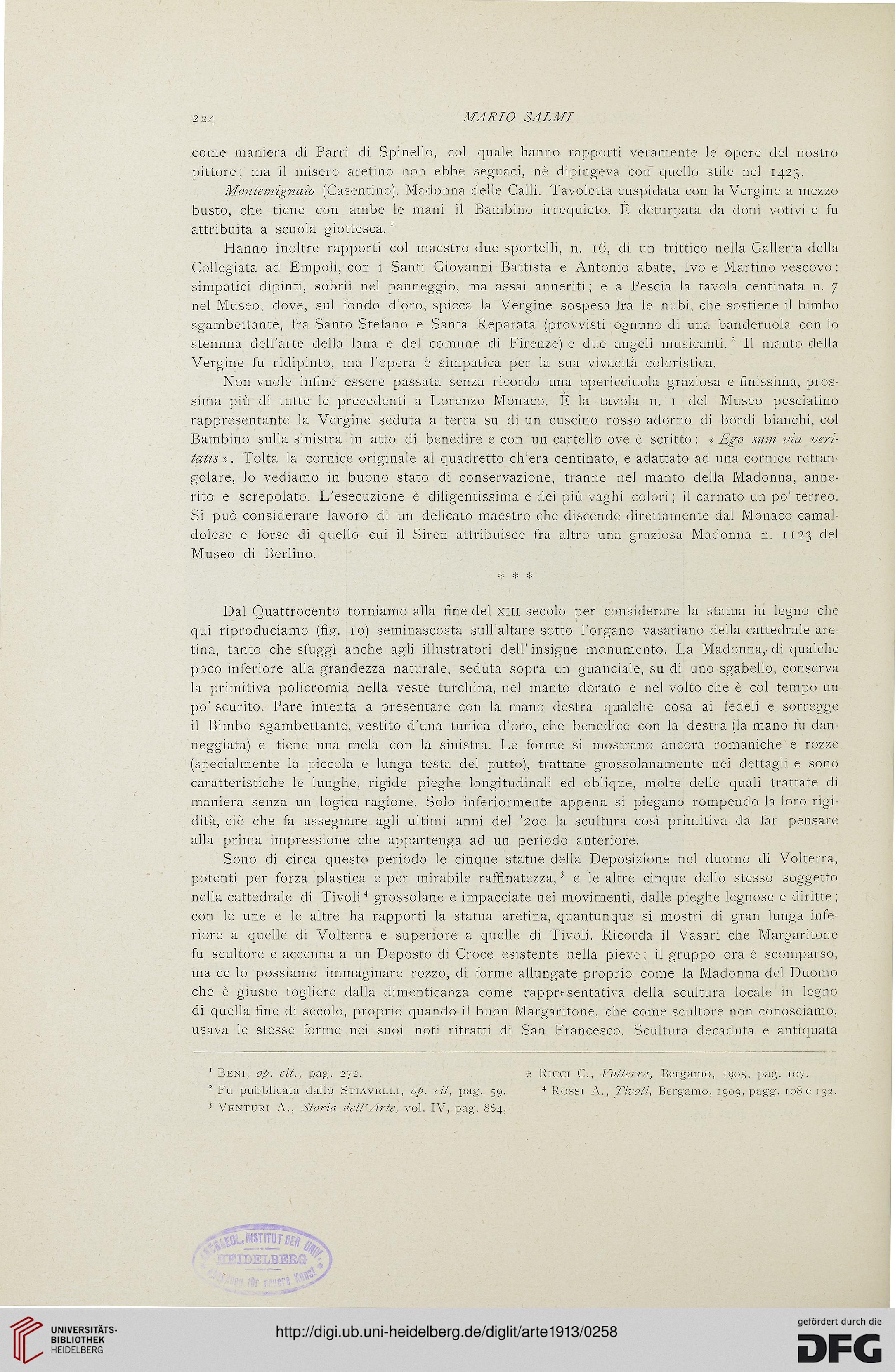224
MARIO SALMI
come maniera di Parri di Spinello, col quale hanno rapporti veramente le opere del nostro
pittore; ma il misero aretino non ebbe seguaci, nè dipingeva con quello stile nel 1423.
Montemignaio (Casentino). Madonna delle Calli. Tavoletta cuspidata con la Vergine a mezzo
busto, che tiene con ambe le mani il Bambino irrequieto. È deturpata da doni votivi e fu
attribuita a scuola giottesca. 1
Hanno inoltre rapporti col maestro due sportelli, n. 16, di un trittico nella Galleria della
Collegiata ad Empoli, con i Santi Giovanni Battista e Antonio abate, Ivo e Martino vescovo :
simpatici dipinti, sobrii nel panneggio, ma assai anneriti ; e a Pescia la tavola centinata n. 7
nel Museo, dove, sul fondo d’oro, spicca la Vergine sospesa fra le nubi, che sostiene il bimbo
sgambettante, fra Santo Stefano e Santa Reparata (provvisti ognuno di una banderuola con lo
stemma dell’arte della lana e del comune di Firenze) e due angeli musicanti.2 II manto della
Vergine fu ridipinto, ma l'opera è simpatica per la sua vivacità coloristica.
Non vuole infine essere passata senza ricordo una opericciuola graziosa e finissima, pros-
sima più di tutte le precedenti a Lorenzo Monaco. E la tavola n. 1 del Museo posdatino
rappresentante la Vergine seduta a terra su di un cuscino rosso adorno di bordi bianchi, col
Bambino sulla sinistra in atto di benedire e con un cartello ove è scritto: «Ego sum via ven-
tatisi. Tolta la cornice originale al quadretto ch’era centinato, e adattato ad una cornice rettan-
golare, lo vediamo in buono stato di conservazione, tranne nel manto della Madonna, anne-
rito e screpolato. L’esecuzione è diligentissima e dei più vaghi colori ; il carnato un po’ terreo.
Si può considerare lavoro di un delicato maestro che discende direttamente dal Monaco camal-
dolese e forse di quello cui il Siren attribuisce fra altro una graziosa Madonna n. 1123 del
Museo di Berlino.
* * *
Dal Quattrocento torniamo alla fine del XIII secolo per considerare la statua in legno che
qui riproduciamo (fig. io) seminascosta sull'altare sotto l’organo vasariano della cattedrale are-
tina, tanto che sfuggì anche agli illustratori dell’insigne monumento. La Madonna,-di qualche
poco inferiore alla grandezza naturale, seduta sopra un guanciale, su di uno sgabello, conserva
la primitiva policromia nella veste turchina, nel manto dorato e nel volto che è col tempo un
po’ scurito. Pare intenta a presentare con la mano destra qualche cosa ai fedeli e sorregge
il Bimbo sgambettante, vestito d’una tunica d’oro, che benedice con la destra (la mano fu dan-
neggiata) e tiene una mela con la sinistra. Le forme si mostrano ancora romaniche e rozze
(specialmente la piccola e lunga testa del putto), trattate grossolanamente nei dettagli e sono
caratteristiche le lunghe, rigide pieghe longitudinali ed oblique, molte delle quali trattate di
maniera senza un logica ragione. Solo inferiormente appena si piegano rompendo la loro rigi-
dità, ciò che fa assegnare agli ultimi anni del ’2oo la scultura così primitiva da far pensare
alla prima impressione che appartenga ad un periodo anteriore.
Sono di circa questo periodo le cinque statue della Deposizione nel duomo di Volterra,
potenti per forza plastica e per mirabile raffinatezza, 3 e le altre cinque dello stesso soggetto
nella cattedrale di Tivoli4 grossolane e impacciate nei movimenti, dalle pieghe legnose e diritte;
con le une e le altre ha rapporti la statua aretina, quantunque si mostri di gran lunga infe-
riore a quelle di Volterra e superiore a quelle di Tivoli. Ricorda il Vasari che Margaritone
fu scultore e accenna a un Deposto di Croce esistente nella pieve ; il gruppo ora è scomparso,
ma ce lo possiamo immaginare rozzo, di forme allungate proprio come la Madonna del Duomo
che è giusto togliere dalla dimenticanza come rappresentativa della scultura locale in legno
di quella fine di secolo, proprio quando il buon Margaritone, che come scultore non conosciamo,
usava le stesse forme nei suoi noti ritratti di San Francesco. Scultura decaduta e antiquata
1 Beni, op. cit., pag. 272. e Ricci C., Volterra, Bergamo, 1905, pag. 107.
2 Fu pubblicata dallo Stiavelli, op. cit, pag. 59. 4 Rossi A., Tivoli, Bergamo, 1909, pagg. 108 e 132.
3 Venturi A., Storia dell’Arte, voi. IV, pag. 864,
j ÌI7/R151R
MARIO SALMI
come maniera di Parri di Spinello, col quale hanno rapporti veramente le opere del nostro
pittore; ma il misero aretino non ebbe seguaci, nè dipingeva con quello stile nel 1423.
Montemignaio (Casentino). Madonna delle Calli. Tavoletta cuspidata con la Vergine a mezzo
busto, che tiene con ambe le mani il Bambino irrequieto. È deturpata da doni votivi e fu
attribuita a scuola giottesca. 1
Hanno inoltre rapporti col maestro due sportelli, n. 16, di un trittico nella Galleria della
Collegiata ad Empoli, con i Santi Giovanni Battista e Antonio abate, Ivo e Martino vescovo :
simpatici dipinti, sobrii nel panneggio, ma assai anneriti ; e a Pescia la tavola centinata n. 7
nel Museo, dove, sul fondo d’oro, spicca la Vergine sospesa fra le nubi, che sostiene il bimbo
sgambettante, fra Santo Stefano e Santa Reparata (provvisti ognuno di una banderuola con lo
stemma dell’arte della lana e del comune di Firenze) e due angeli musicanti.2 II manto della
Vergine fu ridipinto, ma l'opera è simpatica per la sua vivacità coloristica.
Non vuole infine essere passata senza ricordo una opericciuola graziosa e finissima, pros-
sima più di tutte le precedenti a Lorenzo Monaco. E la tavola n. 1 del Museo posdatino
rappresentante la Vergine seduta a terra su di un cuscino rosso adorno di bordi bianchi, col
Bambino sulla sinistra in atto di benedire e con un cartello ove è scritto: «Ego sum via ven-
tatisi. Tolta la cornice originale al quadretto ch’era centinato, e adattato ad una cornice rettan-
golare, lo vediamo in buono stato di conservazione, tranne nel manto della Madonna, anne-
rito e screpolato. L’esecuzione è diligentissima e dei più vaghi colori ; il carnato un po’ terreo.
Si può considerare lavoro di un delicato maestro che discende direttamente dal Monaco camal-
dolese e forse di quello cui il Siren attribuisce fra altro una graziosa Madonna n. 1123 del
Museo di Berlino.
* * *
Dal Quattrocento torniamo alla fine del XIII secolo per considerare la statua in legno che
qui riproduciamo (fig. io) seminascosta sull'altare sotto l’organo vasariano della cattedrale are-
tina, tanto che sfuggì anche agli illustratori dell’insigne monumento. La Madonna,-di qualche
poco inferiore alla grandezza naturale, seduta sopra un guanciale, su di uno sgabello, conserva
la primitiva policromia nella veste turchina, nel manto dorato e nel volto che è col tempo un
po’ scurito. Pare intenta a presentare con la mano destra qualche cosa ai fedeli e sorregge
il Bimbo sgambettante, vestito d’una tunica d’oro, che benedice con la destra (la mano fu dan-
neggiata) e tiene una mela con la sinistra. Le forme si mostrano ancora romaniche e rozze
(specialmente la piccola e lunga testa del putto), trattate grossolanamente nei dettagli e sono
caratteristiche le lunghe, rigide pieghe longitudinali ed oblique, molte delle quali trattate di
maniera senza un logica ragione. Solo inferiormente appena si piegano rompendo la loro rigi-
dità, ciò che fa assegnare agli ultimi anni del ’2oo la scultura così primitiva da far pensare
alla prima impressione che appartenga ad un periodo anteriore.
Sono di circa questo periodo le cinque statue della Deposizione nel duomo di Volterra,
potenti per forza plastica e per mirabile raffinatezza, 3 e le altre cinque dello stesso soggetto
nella cattedrale di Tivoli4 grossolane e impacciate nei movimenti, dalle pieghe legnose e diritte;
con le une e le altre ha rapporti la statua aretina, quantunque si mostri di gran lunga infe-
riore a quelle di Volterra e superiore a quelle di Tivoli. Ricorda il Vasari che Margaritone
fu scultore e accenna a un Deposto di Croce esistente nella pieve ; il gruppo ora è scomparso,
ma ce lo possiamo immaginare rozzo, di forme allungate proprio come la Madonna del Duomo
che è giusto togliere dalla dimenticanza come rappresentativa della scultura locale in legno
di quella fine di secolo, proprio quando il buon Margaritone, che come scultore non conosciamo,
usava le stesse forme nei suoi noti ritratti di San Francesco. Scultura decaduta e antiquata
1 Beni, op. cit., pag. 272. e Ricci C., Volterra, Bergamo, 1905, pag. 107.
2 Fu pubblicata dallo Stiavelli, op. cit, pag. 59. 4 Rossi A., Tivoli, Bergamo, 1909, pagg. 108 e 132.
3 Venturi A., Storia dell’Arte, voi. IV, pag. 864,
j ÌI7/R151R