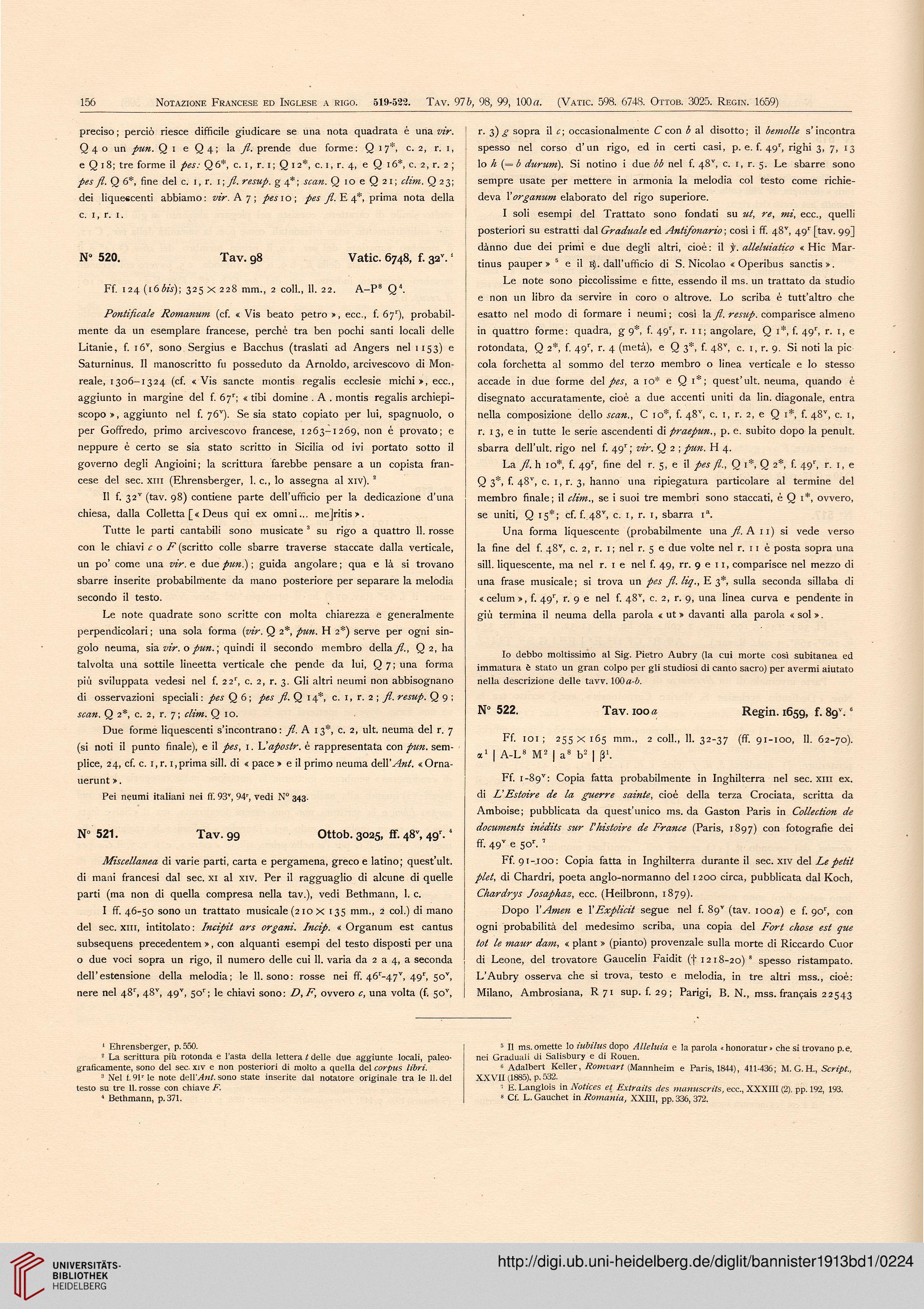156
Notazione Francese ed Inglese a rigo. 519-522. Tav. 976, 98, 99, 100 a. (Vatic. 598. 6748. Ottob. 3025. Regin. 1659)
preciso ; perciò riesce difficile giudicare se una nota quadrata è una vir.
Q 4 o un pun. Q i e Q 4; la fi. prende due forme: Q 17*, c. 2, r. 1,
e Q 18; tre forme il pes: Q6* ci, r.i; Q12*, c.i.r. 4, e Q 16*, c. 2, r. 2 ;
pes fi. Q 6*, fine del c. 1, r. 1 ; fi. resup. g 4*; scan. Q 10 e Q 21; clim. Q 23;
dei lique«centi abbiamo: vir. A 7 ; pes 10; pes fi. E 4*, prima nota della
c. 1, r. 1.
N° 520. Tav. 98 Vatic. 6748, f. 32".1
Ff. 124 (16ÒÙ); 325 x 228 mm., 2 coli., 11. 22. A-P8 Q4.
Pontificale Romanum (cf. « Vis beato petro », ecc., f. 6jr), probabil-
mente da un esemplare francese, perchè tra ben pochi santi locali delle
Litanie, f. i6v, sono Sergius e Bacchus (traslati ad Angers nel 1153) e
Saturninus. Il manoscritto fu posseduto da Arnoldo, arcivescovo di Mon-
reale, 1306-1324 (cf. «Vis sancte montis regalis ecclesie michi >, ecc.,
aggiunto in margine del f. 6yr; « tibi domine . A . montis regalis archiepi-
scopo », aggiunto nel f. 76^). Se sia stato copiato per lui, spagnuolo, o
per Goffredo, primo arcivescovo francese, 1263-1269, non è provato; e
neppure è certo se sia stato scritto in Sicilia od ivi portato sotto il
governo degli Angioini; la scrittura farebbe pensare a un copista fran-
cese del sec. xm (Ehrensberger, 1. e, lo assegna al xiv). 2
Il f. 32v (tav. 98) contiene parte dell'ufficio per la dedicazione d'una
chiesa, dalla Colletta [« Deus qui ex omni... mejritis».
Tutte le parti cantabili sono musicate 3 su rigo a quattro 11. rosse
con le chiavi c o F (scritto colle sbarre traverse staccate dalla verticale,
un po' come una vir. e due pun.) ; guida angolare ; qua e là si trovano
sbarre inserite probabilmente da mano posteriore per separare la melodia
secondo il testo.
Le note quadrate sono scritte con molta chiarezza e generalmente
perpendicolari ; una sola forma {vir. Q 2*, pun. H 2*) serve per ogni sin-
golo neuma, sia vir. o pun.\ quindi il secondo membro della fi., Q 2, ha
talvolta una sottile lineetta verticale che pende da lui, Q 7 ; una forma
più sviluppata vedesi nel f. 22r, c. 2, r. 3. Gli altri neumi non abbisognano
di osservazioni speciali : pes Q 6 ; pes fi. Q 14*, c. 1, r. 2 ; fi. resup. Q 9 ;
scan. Q 2*, c. 2, r. 7; clim. Q 10.
Due forme liquescenti s'incontrano: fi. A 13*, c. 2, ult. neuma del r. 7
(si noti il punto finale), e il pes, 1. L'apostr. è rappresentata con pun. sem-
plice, 24, cf. c. i,r. 1,prima sili, di « pace » e il primo neuma dell'Ani. «Orna-
uerunt ».
Pei neumi italiani nei ff. 93v, 94r, vedi N° 343.
N° 521. Tav. 99 Ottob. 3025, ff. 48v, 49r.4
Miscellanea di varie parti, carta e pergamena, greco e latino; quest'ult.
di mani francesi dal sec. xi al xiv. Per il ragguaglio di alcune di quelle
parti (ma non di quella compresa nella tav.), vedi Bethmann, l. c.
I ff. 46-50 sono un trattato musicale (2 10 x 135 mm., 2 col.) di mano
del sec. xm, intitolato : Incipit ars organi. Incip. « Organum est cantus
subsequens precedentem », con alquanti esempi del testo disposti per una
o due voci sopra un rigo, il numero delle cui 11. varia da 2 a 4, a seconda
dell'estensione della melodia; le 11. sono: rosse nei ff. 46^47v, 49r, 50",
nere nel 48r, 48v, 49v, 5or; le chiavi sono: D, F, ovvero c, una volta (f. 5ov,
1 Ehrensberger, p. 550.
2 La scrittura più rotonda e l'asta della lettera t delle due aggiunte locali, paleo-
graficamente, sono del sec xiv e non posteriori di molto a quella del corpus libri.
3 Nel f. 91r le note dell'Ant. sono state inserite dal notatore originale tra le 11. del
testo su tre 11. rosse con chiave F.
4 Bethmann, p.371.
r- 3) £ sopra il c; occasionalmente C con b al disotto; il bemolle s'incontra
spesso nel corso d'un rigo, ed in certi casi, p. e. f. 49', righi 3, 7, 13
lo h (= b durum). Si notino i due bb nel f. 48v, c. 1, r. 5. Le sbarre sono
sempre usate per mettere in armonia la melodia col testo come richie-
deva Xorganum elaborato del rigo superiore.
I soli esempi del Trattato sono fondati su ut, re, mi, ecc., quelli
posteriori su estratti dal Graduale ed Antifonario; così i ff. 48v, 49*" [tav. 99]
dànno due dei primi e due degli altri, cioè : il f. alleluiatico < Hic Mar-
tinus pauper » 5 e il dall'ufficio di S. Nicolao « Operibus sanctis».
Le note sono piccolissime e fitte, essendo il ms. un trattato da studio
e non un libro da servire in coro o altrove. Lo scriba è tutt'altro che
esatto nel modo di formare i neumi ; così la fi. res^cp. comparisce almeno
in quattro forme: quadra, g 9*, f. 49r, r. 11; angolare, Q 1*, f. 49*", r. 1, e
rotondata, Q 2*, f. 49*", r. 4 (metà), e Q 3*, f. 48v, c. 1, r. 9. Si noti la pie
cola forchetta al sommo del terzo membro o linea verticale e lo stesso
accade in due forme del pes, a 10* e Qi*; quest'ult. neuma, quando è
disegnato accuratamente, cioè a due accenti uniti da lin. diagonale, entra
nella composizione dello scan., C io*, f. 48v, c. 1, r. 2, e Q 1* f. 48", c. 1,
r. 13, e in tutte le serie ascendenti di praepun., p. e. subito dopo la penult.
sbarra dell'ult. rigo nel f. 49*"; vir. Q 2 ; pun. H 4.
La fi. h 10* f. 49r, fine del r. 5, e il pes fi., Q 1* Q 2* f. 49r, r. 1, e
Q 3*, f. 48v, c. 1, r. 3, hanno una ripiegatura particolare al termine del
membro finale; il clim., se i suoi tre membri sono staccati, è Q 1*, ovvero,
se uniti, Q 15*; cf. f. 48v, c. 1, r. 1, sbarra ia.
Una forma liquescente (probabilmente una fi. A 11) si vede verso
la fine del f. 48v, c. 2, r. 1; nel r. 5 e due volte nel r. 11 è posta sopra una
sili, liquescente, ma nel r. 1 e nel f. 49, rr. 9 e 11, comparisce nel mezzo di
una frase musicale; si trova un pes fi. liq., E 3*, sulla seconda sillaba di
«celum», f. 49r, r. 9 e nel f. 48v, c. 2, r. 9, una linea curva e pendente in
giù termina il neuma della parola « ut » davanti alla parola « sol ».
Io debbo moltissimo al Sig. Pietro Aubry (la cui morte così subitanea ed
immatura è stato un gran colpo per gli studiosi di canto sacro) per avermi aiutato
nella descrizione delle tavv. 100 a-b.
N° 522. Tav. 100 « Regin. 1659, f. 8gv.6
Ff. 101 ; 255x165 mm., 2 coli., 11. 32-37 (ff. 91-100, 11. 62-70).
a1 | A-L8 M2 | a8 b2 | 01.
Ff. i-89v: Copia fatta probabilmente in Inghilterra nel sec. xm ex.
di L'Estoire de la guerre sainte, cioè della terza Crociata, scritta da
Amboise; pubblicata da quest'unico ms. da Gaston Paris in Collection de
documents inédits sur l'histoire de France (Paris, 1897) con fotografie dei
ff. 49v e 5or. 7
Ff. 91-100: Copia fatta in Inghilterra durante il sec. xiv del Le petit
plet, di Chardri, poeta anglo-normanno del 1200 circa, pubblicata dal Koch,
Chardrys Josaphaz, ecc. (Heilbronn, 1879).
Dopo XAmen e XExplicit segue nel f. 89^ (tav. \ooà) e f. 90r, con
ogni probabilità del medesimo scriba, una copia del Fort chose est que
tot le maur dam, « plant » (pianto) provenzale sulla morte di Riccardo Cuor
di Leone, del trovatore Gaucelin Faidit (f 1218-20) 8 spesso ristampato.
L'Aubry osserva che si trova, testo e melodia, in tre altri mss., cioè:
Milano, Ambrosiana, R71 sup. f. 29; Parigi, B. N., mss. francais 22543
5 II ms. omette lo iubilus dopo Alleluia e la parola «honoratur» che si trovano p.e.
nei Graduali di Salisbury e di Rouen.
c Adalbert Keller, Romvart (Mannheim e Paris, 1844), 411-436; M. G.H., Script.,
XXVII (1885), p. 532.
■ E. Langlois in Notices et Extraits des manuscrits, ecc., XXXIII (2), pp. 192, 193.
8 Cf. L. Gauchet in Romania, XXIII, pp. 336, 372.
Notazione Francese ed Inglese a rigo. 519-522. Tav. 976, 98, 99, 100 a. (Vatic. 598. 6748. Ottob. 3025. Regin. 1659)
preciso ; perciò riesce difficile giudicare se una nota quadrata è una vir.
Q 4 o un pun. Q i e Q 4; la fi. prende due forme: Q 17*, c. 2, r. 1,
e Q 18; tre forme il pes: Q6* ci, r.i; Q12*, c.i.r. 4, e Q 16*, c. 2, r. 2 ;
pes fi. Q 6*, fine del c. 1, r. 1 ; fi. resup. g 4*; scan. Q 10 e Q 21; clim. Q 23;
dei lique«centi abbiamo: vir. A 7 ; pes 10; pes fi. E 4*, prima nota della
c. 1, r. 1.
N° 520. Tav. 98 Vatic. 6748, f. 32".1
Ff. 124 (16ÒÙ); 325 x 228 mm., 2 coli., 11. 22. A-P8 Q4.
Pontificale Romanum (cf. « Vis beato petro », ecc., f. 6jr), probabil-
mente da un esemplare francese, perchè tra ben pochi santi locali delle
Litanie, f. i6v, sono Sergius e Bacchus (traslati ad Angers nel 1153) e
Saturninus. Il manoscritto fu posseduto da Arnoldo, arcivescovo di Mon-
reale, 1306-1324 (cf. «Vis sancte montis regalis ecclesie michi >, ecc.,
aggiunto in margine del f. 6yr; « tibi domine . A . montis regalis archiepi-
scopo », aggiunto nel f. 76^). Se sia stato copiato per lui, spagnuolo, o
per Goffredo, primo arcivescovo francese, 1263-1269, non è provato; e
neppure è certo se sia stato scritto in Sicilia od ivi portato sotto il
governo degli Angioini; la scrittura farebbe pensare a un copista fran-
cese del sec. xm (Ehrensberger, 1. e, lo assegna al xiv). 2
Il f. 32v (tav. 98) contiene parte dell'ufficio per la dedicazione d'una
chiesa, dalla Colletta [« Deus qui ex omni... mejritis».
Tutte le parti cantabili sono musicate 3 su rigo a quattro 11. rosse
con le chiavi c o F (scritto colle sbarre traverse staccate dalla verticale,
un po' come una vir. e due pun.) ; guida angolare ; qua e là si trovano
sbarre inserite probabilmente da mano posteriore per separare la melodia
secondo il testo.
Le note quadrate sono scritte con molta chiarezza e generalmente
perpendicolari ; una sola forma {vir. Q 2*, pun. H 2*) serve per ogni sin-
golo neuma, sia vir. o pun.\ quindi il secondo membro della fi., Q 2, ha
talvolta una sottile lineetta verticale che pende da lui, Q 7 ; una forma
più sviluppata vedesi nel f. 22r, c. 2, r. 3. Gli altri neumi non abbisognano
di osservazioni speciali : pes Q 6 ; pes fi. Q 14*, c. 1, r. 2 ; fi. resup. Q 9 ;
scan. Q 2*, c. 2, r. 7; clim. Q 10.
Due forme liquescenti s'incontrano: fi. A 13*, c. 2, ult. neuma del r. 7
(si noti il punto finale), e il pes, 1. L'apostr. è rappresentata con pun. sem-
plice, 24, cf. c. i,r. 1,prima sili, di « pace » e il primo neuma dell'Ani. «Orna-
uerunt ».
Pei neumi italiani nei ff. 93v, 94r, vedi N° 343.
N° 521. Tav. 99 Ottob. 3025, ff. 48v, 49r.4
Miscellanea di varie parti, carta e pergamena, greco e latino; quest'ult.
di mani francesi dal sec. xi al xiv. Per il ragguaglio di alcune di quelle
parti (ma non di quella compresa nella tav.), vedi Bethmann, l. c.
I ff. 46-50 sono un trattato musicale (2 10 x 135 mm., 2 col.) di mano
del sec. xm, intitolato : Incipit ars organi. Incip. « Organum est cantus
subsequens precedentem », con alquanti esempi del testo disposti per una
o due voci sopra un rigo, il numero delle cui 11. varia da 2 a 4, a seconda
dell'estensione della melodia; le 11. sono: rosse nei ff. 46^47v, 49r, 50",
nere nel 48r, 48v, 49v, 5or; le chiavi sono: D, F, ovvero c, una volta (f. 5ov,
1 Ehrensberger, p. 550.
2 La scrittura più rotonda e l'asta della lettera t delle due aggiunte locali, paleo-
graficamente, sono del sec xiv e non posteriori di molto a quella del corpus libri.
3 Nel f. 91r le note dell'Ant. sono state inserite dal notatore originale tra le 11. del
testo su tre 11. rosse con chiave F.
4 Bethmann, p.371.
r- 3) £ sopra il c; occasionalmente C con b al disotto; il bemolle s'incontra
spesso nel corso d'un rigo, ed in certi casi, p. e. f. 49', righi 3, 7, 13
lo h (= b durum). Si notino i due bb nel f. 48v, c. 1, r. 5. Le sbarre sono
sempre usate per mettere in armonia la melodia col testo come richie-
deva Xorganum elaborato del rigo superiore.
I soli esempi del Trattato sono fondati su ut, re, mi, ecc., quelli
posteriori su estratti dal Graduale ed Antifonario; così i ff. 48v, 49*" [tav. 99]
dànno due dei primi e due degli altri, cioè : il f. alleluiatico < Hic Mar-
tinus pauper » 5 e il dall'ufficio di S. Nicolao « Operibus sanctis».
Le note sono piccolissime e fitte, essendo il ms. un trattato da studio
e non un libro da servire in coro o altrove. Lo scriba è tutt'altro che
esatto nel modo di formare i neumi ; così la fi. res^cp. comparisce almeno
in quattro forme: quadra, g 9*, f. 49r, r. 11; angolare, Q 1*, f. 49*", r. 1, e
rotondata, Q 2*, f. 49*", r. 4 (metà), e Q 3*, f. 48v, c. 1, r. 9. Si noti la pie
cola forchetta al sommo del terzo membro o linea verticale e lo stesso
accade in due forme del pes, a 10* e Qi*; quest'ult. neuma, quando è
disegnato accuratamente, cioè a due accenti uniti da lin. diagonale, entra
nella composizione dello scan., C io*, f. 48v, c. 1, r. 2, e Q 1* f. 48", c. 1,
r. 13, e in tutte le serie ascendenti di praepun., p. e. subito dopo la penult.
sbarra dell'ult. rigo nel f. 49*"; vir. Q 2 ; pun. H 4.
La fi. h 10* f. 49r, fine del r. 5, e il pes fi., Q 1* Q 2* f. 49r, r. 1, e
Q 3*, f. 48v, c. 1, r. 3, hanno una ripiegatura particolare al termine del
membro finale; il clim., se i suoi tre membri sono staccati, è Q 1*, ovvero,
se uniti, Q 15*; cf. f. 48v, c. 1, r. 1, sbarra ia.
Una forma liquescente (probabilmente una fi. A 11) si vede verso
la fine del f. 48v, c. 2, r. 1; nel r. 5 e due volte nel r. 11 è posta sopra una
sili, liquescente, ma nel r. 1 e nel f. 49, rr. 9 e 11, comparisce nel mezzo di
una frase musicale; si trova un pes fi. liq., E 3*, sulla seconda sillaba di
«celum», f. 49r, r. 9 e nel f. 48v, c. 2, r. 9, una linea curva e pendente in
giù termina il neuma della parola « ut » davanti alla parola « sol ».
Io debbo moltissimo al Sig. Pietro Aubry (la cui morte così subitanea ed
immatura è stato un gran colpo per gli studiosi di canto sacro) per avermi aiutato
nella descrizione delle tavv. 100 a-b.
N° 522. Tav. 100 « Regin. 1659, f. 8gv.6
Ff. 101 ; 255x165 mm., 2 coli., 11. 32-37 (ff. 91-100, 11. 62-70).
a1 | A-L8 M2 | a8 b2 | 01.
Ff. i-89v: Copia fatta probabilmente in Inghilterra nel sec. xm ex.
di L'Estoire de la guerre sainte, cioè della terza Crociata, scritta da
Amboise; pubblicata da quest'unico ms. da Gaston Paris in Collection de
documents inédits sur l'histoire de France (Paris, 1897) con fotografie dei
ff. 49v e 5or. 7
Ff. 91-100: Copia fatta in Inghilterra durante il sec. xiv del Le petit
plet, di Chardri, poeta anglo-normanno del 1200 circa, pubblicata dal Koch,
Chardrys Josaphaz, ecc. (Heilbronn, 1879).
Dopo XAmen e XExplicit segue nel f. 89^ (tav. \ooà) e f. 90r, con
ogni probabilità del medesimo scriba, una copia del Fort chose est que
tot le maur dam, « plant » (pianto) provenzale sulla morte di Riccardo Cuor
di Leone, del trovatore Gaucelin Faidit (f 1218-20) 8 spesso ristampato.
L'Aubry osserva che si trova, testo e melodia, in tre altri mss., cioè:
Milano, Ambrosiana, R71 sup. f. 29; Parigi, B. N., mss. francais 22543
5 II ms. omette lo iubilus dopo Alleluia e la parola «honoratur» che si trovano p.e.
nei Graduali di Salisbury e di Rouen.
c Adalbert Keller, Romvart (Mannheim e Paris, 1844), 411-436; M. G.H., Script.,
XXVII (1885), p. 532.
■ E. Langlois in Notices et Extraits des manuscrits, ecc., XXXIII (2), pp. 192, 193.
8 Cf. L. Gauchet in Romania, XXIII, pp. 336, 372.