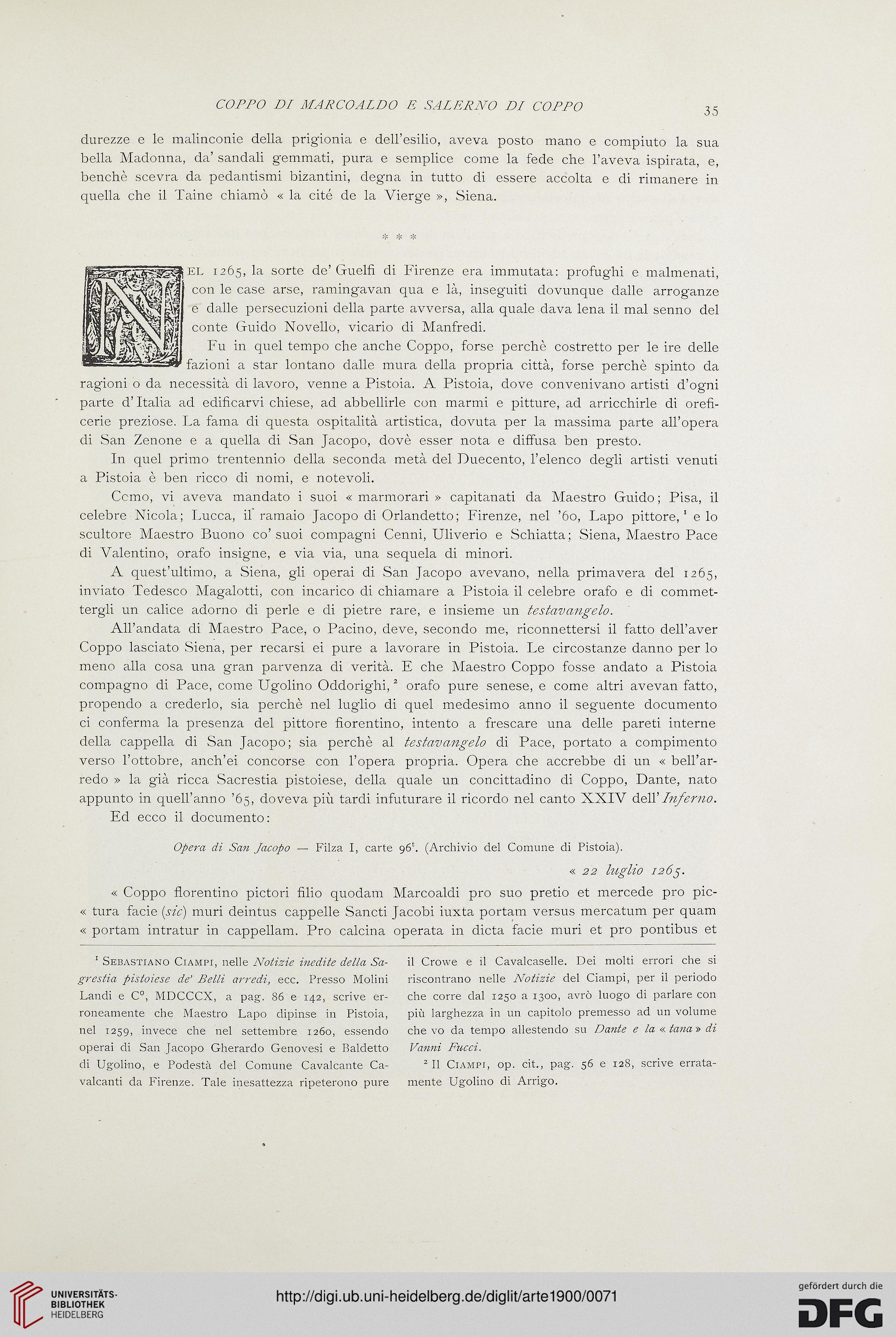COPPO DI MARCOALDO E SALERNO DI COPPO
35
durezze e le malinconie della prigionia e dell'esilio, aveva posto mano e compiuto la sua
bella Madonna, da' sandali gemmati, pura e semplice come la fede che l'aveva ispirata, e,
benché scevra da pedantismi bizantini, degna in tutto di essere accolta e di rimanere in
quella che il Taine chiamò « la cité de la Vierge », Siena.
^sajEL 1265, la sorte de'Guelfi di Firenze era immutata: profughi e malmenati,
con le case arse, ramingavan qua e là, inseguiti dovunque dalle arroganze
e dalle persecuzioni della parte avversa, alla quale dava lena il mal senno del
conte Guido Novello, vicario di Manfredi.
Fu in quel tempo che anche Coppo, forse perchè costretto per le ire delle
fazioni a star lontano dalle mura della propria città, forse perchè spinto da
ragioni o da necessità di lavoro, venne a Pistoia. A Pistoia, dove convenivano artisti d'ogni
parte d'Italia ad edificarvi chiese, ad abbellirle con marmi e pitture, ad arricchirle di orefi-
cerie preziose. La fama di questa ospitalità artistica, dovuta per la massima parte all'opera
di San Zenone e a quella di San Jacopo, dovè esser nota e diffusa ben presto.
In quel primo trentennio della seconda metà del Duecento, l'elenco degli artisti venuti
a Pistoia è ben ricco di nomi, e notevoli.
Cerno, vi aveva mandato i suoi « marmorari » capitanati da Maestro Guido ; Pisa, il
celebre Nicola; Lucca, il ramaio Jacopo di Orlandetto; Firenze, nel '60, Lapo pittore,1 e lo
scultore Maestro Buono co'suoi compagni Cenni, Uliverio e Schiatta; Siena, Maestro Pace
di Valentino^ orafo insigne, e via via, una sequela di minori.
A quest'ultimo, a Siena, gli operai di San Jacopo avevano, nella primavera del 1265,
inviato Ledesco Magalotti, con incarico di chiamare a Pistoia il celebre orafo e di commet-
tergli un calice adorno di perle e di pietre rare, e insieme un testavangelo.
All'andata di Maestro Pace, o Pacino, deve, secondo me, riconnettersi il fatto dell'aver
Coppo lasciato Siena, per recarsi ei pure a lavorare in Pistoia. Le circostanze danno per lo
meno alla cosa una gran parvenza di verità. E che Maestro Coppo fosse andato a Pistoia
compagno di Pace, come Ugolino Oddorighi,2 orafo pure senese, e come altri avevan fatto,
propendo a crederlo, sia perchè nel luglio di quel medesimo anno il seguente documento
ci conferma la presenza del pittore fiorentino, intento a frescare una delle pareti interne
della cappella di San Jacopo; sia perchè al testa-vangelo di Pace, portato a compimento
verso l'ottobre, anch'ei concorse con l'opera propria. Opera che accrebbe di un « bell'ar-
redo » la già ricca Sacrestia pistoiese, della quale un concittadino di Coppo, Dante, nato
appunto in quell'anno '65, doveva più tardi infuturare il ricordo nel canto XXIV dell' Inferno.
Ed ecco il documento:
Opera di San Iacopo — Filza I, carte 96*. (Archivio del Comune di Pistoia).
« 22 luglio 126$.
« Coppo fiorentino pictori filio quodam Marcoaldi prò suo pretio et mercede prò pic-
« tura facie (sic) muri deintus cappelle Sancti Jacobi iuxta portam versus mercatura per quam
« portam intratur in cappellani. Pro calcina operata in dieta facie muri et prò pontibus et
1 Sebastiano Ciampi, nelle Notizie inedite della Sa- il Crowe e il Cavalcasene. Dei molti errori che si
grestia pistoiese de' Belli arredi, ecc. Presso Molini riscontrano nelle Notizie del Ciampi, per il periodo
Landi e C°, MDCCCX, a pag. 86 e 142, scrive er- che corre dal 1250 a 1300, avrò luogo di parlare con
roneamente che Maestro Lapo dipinse in Pistoia, più larghezza in un capitolo premesso ad un volume
nel 1259, invece che nel settembre 1260, essendo che vo da tempo allestendo su Dante e la «tana» di
operai di San Jacopo Gherardo Genovesi e Baldetto Vanni Pucci.
di Ugolino, e Podestà del Comune Cavalcante Ca- 2 II Ciampi, op. cit., pag. 56 e 128, scrive errata-
valcanti da Firenze. Tale inesattezza ripeterono pure mente Ugolino di Arrigo.
35
durezze e le malinconie della prigionia e dell'esilio, aveva posto mano e compiuto la sua
bella Madonna, da' sandali gemmati, pura e semplice come la fede che l'aveva ispirata, e,
benché scevra da pedantismi bizantini, degna in tutto di essere accolta e di rimanere in
quella che il Taine chiamò « la cité de la Vierge », Siena.
^sajEL 1265, la sorte de'Guelfi di Firenze era immutata: profughi e malmenati,
con le case arse, ramingavan qua e là, inseguiti dovunque dalle arroganze
e dalle persecuzioni della parte avversa, alla quale dava lena il mal senno del
conte Guido Novello, vicario di Manfredi.
Fu in quel tempo che anche Coppo, forse perchè costretto per le ire delle
fazioni a star lontano dalle mura della propria città, forse perchè spinto da
ragioni o da necessità di lavoro, venne a Pistoia. A Pistoia, dove convenivano artisti d'ogni
parte d'Italia ad edificarvi chiese, ad abbellirle con marmi e pitture, ad arricchirle di orefi-
cerie preziose. La fama di questa ospitalità artistica, dovuta per la massima parte all'opera
di San Zenone e a quella di San Jacopo, dovè esser nota e diffusa ben presto.
In quel primo trentennio della seconda metà del Duecento, l'elenco degli artisti venuti
a Pistoia è ben ricco di nomi, e notevoli.
Cerno, vi aveva mandato i suoi « marmorari » capitanati da Maestro Guido ; Pisa, il
celebre Nicola; Lucca, il ramaio Jacopo di Orlandetto; Firenze, nel '60, Lapo pittore,1 e lo
scultore Maestro Buono co'suoi compagni Cenni, Uliverio e Schiatta; Siena, Maestro Pace
di Valentino^ orafo insigne, e via via, una sequela di minori.
A quest'ultimo, a Siena, gli operai di San Jacopo avevano, nella primavera del 1265,
inviato Ledesco Magalotti, con incarico di chiamare a Pistoia il celebre orafo e di commet-
tergli un calice adorno di perle e di pietre rare, e insieme un testavangelo.
All'andata di Maestro Pace, o Pacino, deve, secondo me, riconnettersi il fatto dell'aver
Coppo lasciato Siena, per recarsi ei pure a lavorare in Pistoia. Le circostanze danno per lo
meno alla cosa una gran parvenza di verità. E che Maestro Coppo fosse andato a Pistoia
compagno di Pace, come Ugolino Oddorighi,2 orafo pure senese, e come altri avevan fatto,
propendo a crederlo, sia perchè nel luglio di quel medesimo anno il seguente documento
ci conferma la presenza del pittore fiorentino, intento a frescare una delle pareti interne
della cappella di San Jacopo; sia perchè al testa-vangelo di Pace, portato a compimento
verso l'ottobre, anch'ei concorse con l'opera propria. Opera che accrebbe di un « bell'ar-
redo » la già ricca Sacrestia pistoiese, della quale un concittadino di Coppo, Dante, nato
appunto in quell'anno '65, doveva più tardi infuturare il ricordo nel canto XXIV dell' Inferno.
Ed ecco il documento:
Opera di San Iacopo — Filza I, carte 96*. (Archivio del Comune di Pistoia).
« 22 luglio 126$.
« Coppo fiorentino pictori filio quodam Marcoaldi prò suo pretio et mercede prò pic-
« tura facie (sic) muri deintus cappelle Sancti Jacobi iuxta portam versus mercatura per quam
« portam intratur in cappellani. Pro calcina operata in dieta facie muri et prò pontibus et
1 Sebastiano Ciampi, nelle Notizie inedite della Sa- il Crowe e il Cavalcasene. Dei molti errori che si
grestia pistoiese de' Belli arredi, ecc. Presso Molini riscontrano nelle Notizie del Ciampi, per il periodo
Landi e C°, MDCCCX, a pag. 86 e 142, scrive er- che corre dal 1250 a 1300, avrò luogo di parlare con
roneamente che Maestro Lapo dipinse in Pistoia, più larghezza in un capitolo premesso ad un volume
nel 1259, invece che nel settembre 1260, essendo che vo da tempo allestendo su Dante e la «tana» di
operai di San Jacopo Gherardo Genovesi e Baldetto Vanni Pucci.
di Ugolino, e Podestà del Comune Cavalcante Ca- 2 II Ciampi, op. cit., pag. 56 e 128, scrive errata-
valcanti da Firenze. Tale inesattezza ripeterono pure mente Ugolino di Arrigo.