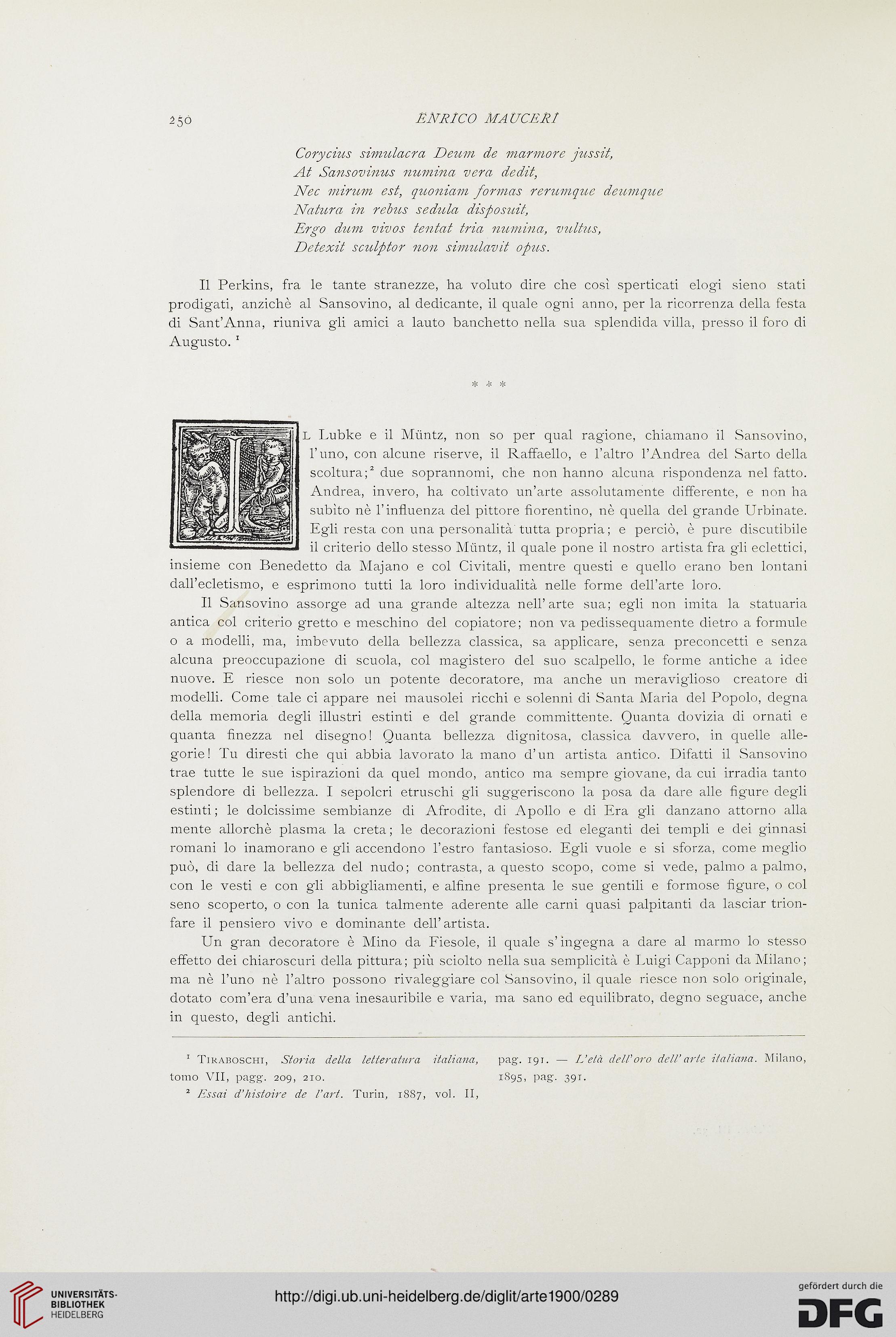250
ENRICO MAUCERl
Corycius simulacro, Deum de marmore jussit,
At Sansovinus manina vera dedit,
Nec mirum est, quoniam formas rertimque detimque
Nahira in rebtis seduta disposuit,
Ergo dttm vivos tentai trio numina, vultus,
Detexit sculptor non simulavit opus.
Il Perkins, fra le tante stranezze, ha voluto dire che così sperticati elogi sieno stati
prodigati, anziché al Sansovino, al dedicante, il quale ogni anno, per la ricorrenza della festa
di Sant'Anna, riuniva gli amici a lauto banchetto nella sua splendida villa, presso il foro di
Augusto. 1
* M *
L Lubke e il Muntz, non so per qual ragione, chiamano il Sansovino,
l'uno, con alcune riserve, il Raffaello, e l'altro l'Andrea del Sarto della
scoltura;2 due soprannomi, che non hanno alcuna rispondenza nel fatto.
Andrea, invero, ha coltivato un'arte assolutamente differente, e non ha
subito nè l'influenza del pittore fiorentino, nè quella del grande Urbinate.
Egli resta con una personalità tutta propria ; e perciò, è pure discutibile
il criterio dello stesso Muntz, il quale pone il nostro artista fra gli eclettici,
insieme con Benedetto da Majano e col Ci vitali, mentre questi e quello erano ben lontani
dall'ecletismo, e esprimono tutti la loro individualità nelle forme dell'arte loro.
Il Sansovino assorge ad una grande altezza nell'arte sua; egli non imita la statuaria
antica col criterio gretto e meschino del copiatore; non va pedissequamente dietro a formule
o a modelli, ma, imbevuto della bellezza classica, sa applicare, senza preconcetti e senza
alcuna preoccupazione di scuola, col magistero del suo scalpello, le forme antiche a idee
nuove. E riesce non solo un potente decoratore, ma anche un meraviglioso creatore di
modelli. Come tale ci appare nei mausolei ricchi e solenni di Santa Maria del Popolo, degna
della memoria degli illustri estinti e del grande committente. Quanta dovizia di ornati e
quanta finezza nel disegno! Quanta bellezza dignitosa, classica davvero, in quelle alle-
gorie! Tu diresti che qui abbia lavorato la mano d'un artista antico. Difatti il Sansovino
trae tutte le sue ispirazioni da quel mondo, antico ma sempre giovane, da cui irradia tanto
splendore di bellezza. I sepolcri etruschi gli suggeriscono la posa da dare alle figure degli
estinti ; le dolcissime sembianze di Afrodite, di Apollo e di Era gli danzano attorno alla
mente allorché plasma la creta; le decorazioni festose ed eleganti dei templi e dei ginnasi
romani lo inamorano e gli accendono l'estro fantasioso. Egli vuole e si sforza, come meglio
può, di dare la bellezza del nudo; contrasta, a questo scopo, come si vede, palmo a palmo,
con le vesti e con gli abbigliamenti, e alfine presenta le sue gentili e formose figure, o col
seno scoperto, o con la tunica talmente aderente alle carni quasi palpitanti da lasciar trion-
fare il pensiero vivo e dominante dell'artista.
Un gran decoratore è Mino da Fiesole, il quale s'ingegna a dare al marmo lo stesso
effetto dei chiaroscuri della pittura; più sciolto nella sua semplicità è Luigi Capponi da Milano;
ma nè l'uno nè l'altro possono rivaleggiare col Sansovino, il quale riesce non solo originale,
dotato com'era d'una vena inesauribile e varia, ma sano ed equilibrato, degno seguace, anche
in questo, degli antichi.
1 Tikaboschi, Storia della letteratura italiana,
tomo VII, pagg. 209, 210.
2 Essai d'histoire de l'art. Turili, 1887, voi. II,
pag. 191. — L'età dell'oro dell'arte italiana. Milano,
1895, pag. 39T.
ENRICO MAUCERl
Corycius simulacro, Deum de marmore jussit,
At Sansovinus manina vera dedit,
Nec mirum est, quoniam formas rertimque detimque
Nahira in rebtis seduta disposuit,
Ergo dttm vivos tentai trio numina, vultus,
Detexit sculptor non simulavit opus.
Il Perkins, fra le tante stranezze, ha voluto dire che così sperticati elogi sieno stati
prodigati, anziché al Sansovino, al dedicante, il quale ogni anno, per la ricorrenza della festa
di Sant'Anna, riuniva gli amici a lauto banchetto nella sua splendida villa, presso il foro di
Augusto. 1
* M *
L Lubke e il Muntz, non so per qual ragione, chiamano il Sansovino,
l'uno, con alcune riserve, il Raffaello, e l'altro l'Andrea del Sarto della
scoltura;2 due soprannomi, che non hanno alcuna rispondenza nel fatto.
Andrea, invero, ha coltivato un'arte assolutamente differente, e non ha
subito nè l'influenza del pittore fiorentino, nè quella del grande Urbinate.
Egli resta con una personalità tutta propria ; e perciò, è pure discutibile
il criterio dello stesso Muntz, il quale pone il nostro artista fra gli eclettici,
insieme con Benedetto da Majano e col Ci vitali, mentre questi e quello erano ben lontani
dall'ecletismo, e esprimono tutti la loro individualità nelle forme dell'arte loro.
Il Sansovino assorge ad una grande altezza nell'arte sua; egli non imita la statuaria
antica col criterio gretto e meschino del copiatore; non va pedissequamente dietro a formule
o a modelli, ma, imbevuto della bellezza classica, sa applicare, senza preconcetti e senza
alcuna preoccupazione di scuola, col magistero del suo scalpello, le forme antiche a idee
nuove. E riesce non solo un potente decoratore, ma anche un meraviglioso creatore di
modelli. Come tale ci appare nei mausolei ricchi e solenni di Santa Maria del Popolo, degna
della memoria degli illustri estinti e del grande committente. Quanta dovizia di ornati e
quanta finezza nel disegno! Quanta bellezza dignitosa, classica davvero, in quelle alle-
gorie! Tu diresti che qui abbia lavorato la mano d'un artista antico. Difatti il Sansovino
trae tutte le sue ispirazioni da quel mondo, antico ma sempre giovane, da cui irradia tanto
splendore di bellezza. I sepolcri etruschi gli suggeriscono la posa da dare alle figure degli
estinti ; le dolcissime sembianze di Afrodite, di Apollo e di Era gli danzano attorno alla
mente allorché plasma la creta; le decorazioni festose ed eleganti dei templi e dei ginnasi
romani lo inamorano e gli accendono l'estro fantasioso. Egli vuole e si sforza, come meglio
può, di dare la bellezza del nudo; contrasta, a questo scopo, come si vede, palmo a palmo,
con le vesti e con gli abbigliamenti, e alfine presenta le sue gentili e formose figure, o col
seno scoperto, o con la tunica talmente aderente alle carni quasi palpitanti da lasciar trion-
fare il pensiero vivo e dominante dell'artista.
Un gran decoratore è Mino da Fiesole, il quale s'ingegna a dare al marmo lo stesso
effetto dei chiaroscuri della pittura; più sciolto nella sua semplicità è Luigi Capponi da Milano;
ma nè l'uno nè l'altro possono rivaleggiare col Sansovino, il quale riesce non solo originale,
dotato com'era d'una vena inesauribile e varia, ma sano ed equilibrato, degno seguace, anche
in questo, degli antichi.
1 Tikaboschi, Storia della letteratura italiana,
tomo VII, pagg. 209, 210.
2 Essai d'histoire de l'art. Turili, 1887, voi. II,
pag. 191. — L'età dell'oro dell'arte italiana. Milano,
1895, pag. 39T.