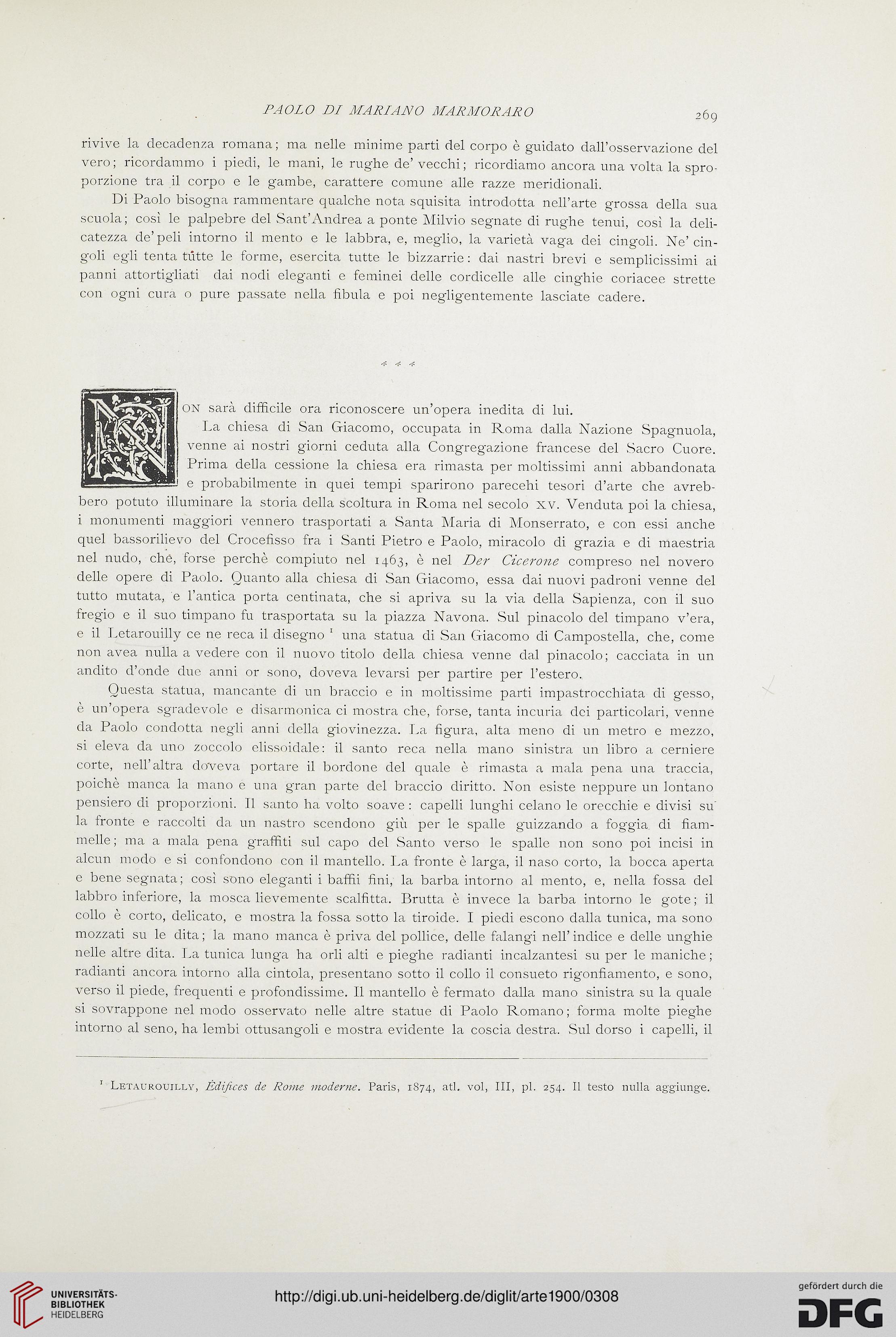PAOLO DI MARIANO MARMORARO
rivive la decadenza romana; ma nelle minime parti del corpo è guidato dall'osservazione del
vero; ricordammo i piedi, le mani, le rughe de' vecchi; ricordiamo ancora una volta la spro-
porzione tra il corpo e le gambe, carattere comune alle razze meridionali.
Di Paolo bisogna rammentare qualche nota squisita introdotta nell'arte grossa della sua
scuola; così le palpebre del Sant'Andrea a ponte Milvio segnate di rughe tenui, così la deli-
catezza de'peli intorno il mento e le labbra, e, meglio, la varietà vaga dei cingoli. Ne'cin-
goli egli tenta tutte le forme, esercita tutte le bizzarrie : dai nastri brevi e semplicissimi ai
panni attortigliati dai nodi eleganti e feminei delle cordicelle alle cinghie coriacee strette
con ogni cura o pure passate nella fibula e poi negligentemente lasciate cadere.
■f -f -f
ON sarà difficile ora riconoscere un'opera inedita di lui.
La chiesa di San Giacomo, occupata in Roma dalla Nazione Spagnuola,
venne ai nostri giorni ceduta alla Congregazione francese del Sacro Cuore.
Prima della cessione la chiesa era rimasta per moltissimi anni abbandonata
e probabilmente in quei tempi sparirono parecehi tesori d'arte che avreb-
bero potuto illuminare la storia della scoltura in Roma nel secolo XV. Venduta poi la chiesa,
i monumenti maggiori vennero trasportati a Santa Maria di Monserrato, e con essi anche
quel bassorilievo del Crocefisso fra i Santi Pietro e Paolo, miracolo di grazia e di maestria
nel nudo, che, forse perchè compiuto nel 1463, è nel Der Cicerone compreso nel novero
delle opere di Paolo. Quanto alla chiesa di San Giacomo, essa dai nuovi padroni venne del
tutto mutata, e l'antica porta centinata, che si apriva su la via della Sapienza, con il suo
fregio e il suo timpano fu trasportata su la piazza Navona. Sul pinacolo del timpano v'era,
e il Letarouilly ce ne reca il disegno 1 una statua di San Giacomo di Campostella, che, come
non avea nulla a vedere con il nuovo titolo della chiesa venne dal pinacolo; cacciata in un
andito d'onde due anni or sono, doveva levarsi per partire per l'estero.
Questa statua, maricante di un braccio e in moltissime parti impastrocchiata di gesso,
è un'opera sgradevole e disarmonica ci mostra che, forse, tanta incuria dei particolari, venne
da Paolo condotta negii anni della giovinezza. La figura, alta meno di un metro e mezzo,
si eleva da uno zoccolo elissoidale: il santo reca nella mano sinistra un libro a cerniere
corte, nell'altra doveva portare il bordone del quale è rimasta a mala pena una traccia,
poiché manca la mano e una gran parte del braccio diritto. Non esiste neppure un lontano
pensiero di proporzioni. Il santo ha volto soave : capelli lunghi celano le orecchie e divisi su
la fronte e raccolti da un nastro scendono giù per le spalle guizzando a foggia di fiam-
melle ; ma a mala pena graffiti sul capo del Santo verso le spalle non sono poi incisi in
alcun modo e si confondono con il mantello. La fronte è larga, il naso corto, la bocca aperta
e bene segnata; così sono eleganti i baffii fini, la barba intorno al mento, e, nella fossa del
labbro inferiore, la mosca lievemente scalfìtta. Brutta è invece la barba intorno le gote ; il
collo è corto, delicato, e mostra la fossa sotto la tiroide. I piedi escono dalla tunica, ma sono
mozzati su le dita ; la mano manca è priva del pollice, delle falangi neh' indice e delle unghie
nelle altre dita. La tunica lunga ha orli alti e pieghe radianti incalzantesi su per le maniche;
radianti ancora intorno alla cintola, presentano sotto il collo il consueto rigonfiamento, e sono,
verso il piede, frequenti e profondissime. Il mantello è fermato dalla mano sinistra su la quale
si sovrappone nel modo osservato nelle altre statue di Paolo Romano ; forma molte pieghe
intorno al seno, ha lembi ottusangoli e mostra evidente la coscia destra. Sul dorso i capelli, il
1 Letaurouilly, Èdifices de Rome moderne. Paris, 1874, atl. voi, III, pi. 254. Il testo nulla aggiunge.
rivive la decadenza romana; ma nelle minime parti del corpo è guidato dall'osservazione del
vero; ricordammo i piedi, le mani, le rughe de' vecchi; ricordiamo ancora una volta la spro-
porzione tra il corpo e le gambe, carattere comune alle razze meridionali.
Di Paolo bisogna rammentare qualche nota squisita introdotta nell'arte grossa della sua
scuola; così le palpebre del Sant'Andrea a ponte Milvio segnate di rughe tenui, così la deli-
catezza de'peli intorno il mento e le labbra, e, meglio, la varietà vaga dei cingoli. Ne'cin-
goli egli tenta tutte le forme, esercita tutte le bizzarrie : dai nastri brevi e semplicissimi ai
panni attortigliati dai nodi eleganti e feminei delle cordicelle alle cinghie coriacee strette
con ogni cura o pure passate nella fibula e poi negligentemente lasciate cadere.
■f -f -f
ON sarà difficile ora riconoscere un'opera inedita di lui.
La chiesa di San Giacomo, occupata in Roma dalla Nazione Spagnuola,
venne ai nostri giorni ceduta alla Congregazione francese del Sacro Cuore.
Prima della cessione la chiesa era rimasta per moltissimi anni abbandonata
e probabilmente in quei tempi sparirono parecehi tesori d'arte che avreb-
bero potuto illuminare la storia della scoltura in Roma nel secolo XV. Venduta poi la chiesa,
i monumenti maggiori vennero trasportati a Santa Maria di Monserrato, e con essi anche
quel bassorilievo del Crocefisso fra i Santi Pietro e Paolo, miracolo di grazia e di maestria
nel nudo, che, forse perchè compiuto nel 1463, è nel Der Cicerone compreso nel novero
delle opere di Paolo. Quanto alla chiesa di San Giacomo, essa dai nuovi padroni venne del
tutto mutata, e l'antica porta centinata, che si apriva su la via della Sapienza, con il suo
fregio e il suo timpano fu trasportata su la piazza Navona. Sul pinacolo del timpano v'era,
e il Letarouilly ce ne reca il disegno 1 una statua di San Giacomo di Campostella, che, come
non avea nulla a vedere con il nuovo titolo della chiesa venne dal pinacolo; cacciata in un
andito d'onde due anni or sono, doveva levarsi per partire per l'estero.
Questa statua, maricante di un braccio e in moltissime parti impastrocchiata di gesso,
è un'opera sgradevole e disarmonica ci mostra che, forse, tanta incuria dei particolari, venne
da Paolo condotta negii anni della giovinezza. La figura, alta meno di un metro e mezzo,
si eleva da uno zoccolo elissoidale: il santo reca nella mano sinistra un libro a cerniere
corte, nell'altra doveva portare il bordone del quale è rimasta a mala pena una traccia,
poiché manca la mano e una gran parte del braccio diritto. Non esiste neppure un lontano
pensiero di proporzioni. Il santo ha volto soave : capelli lunghi celano le orecchie e divisi su
la fronte e raccolti da un nastro scendono giù per le spalle guizzando a foggia di fiam-
melle ; ma a mala pena graffiti sul capo del Santo verso le spalle non sono poi incisi in
alcun modo e si confondono con il mantello. La fronte è larga, il naso corto, la bocca aperta
e bene segnata; così sono eleganti i baffii fini, la barba intorno al mento, e, nella fossa del
labbro inferiore, la mosca lievemente scalfìtta. Brutta è invece la barba intorno le gote ; il
collo è corto, delicato, e mostra la fossa sotto la tiroide. I piedi escono dalla tunica, ma sono
mozzati su le dita ; la mano manca è priva del pollice, delle falangi neh' indice e delle unghie
nelle altre dita. La tunica lunga ha orli alti e pieghe radianti incalzantesi su per le maniche;
radianti ancora intorno alla cintola, presentano sotto il collo il consueto rigonfiamento, e sono,
verso il piede, frequenti e profondissime. Il mantello è fermato dalla mano sinistra su la quale
si sovrappone nel modo osservato nelle altre statue di Paolo Romano ; forma molte pieghe
intorno al seno, ha lembi ottusangoli e mostra evidente la coscia destra. Sul dorso i capelli, il
1 Letaurouilly, Èdifices de Rome moderne. Paris, 1874, atl. voi, III, pi. 254. Il testo nulla aggiunge.