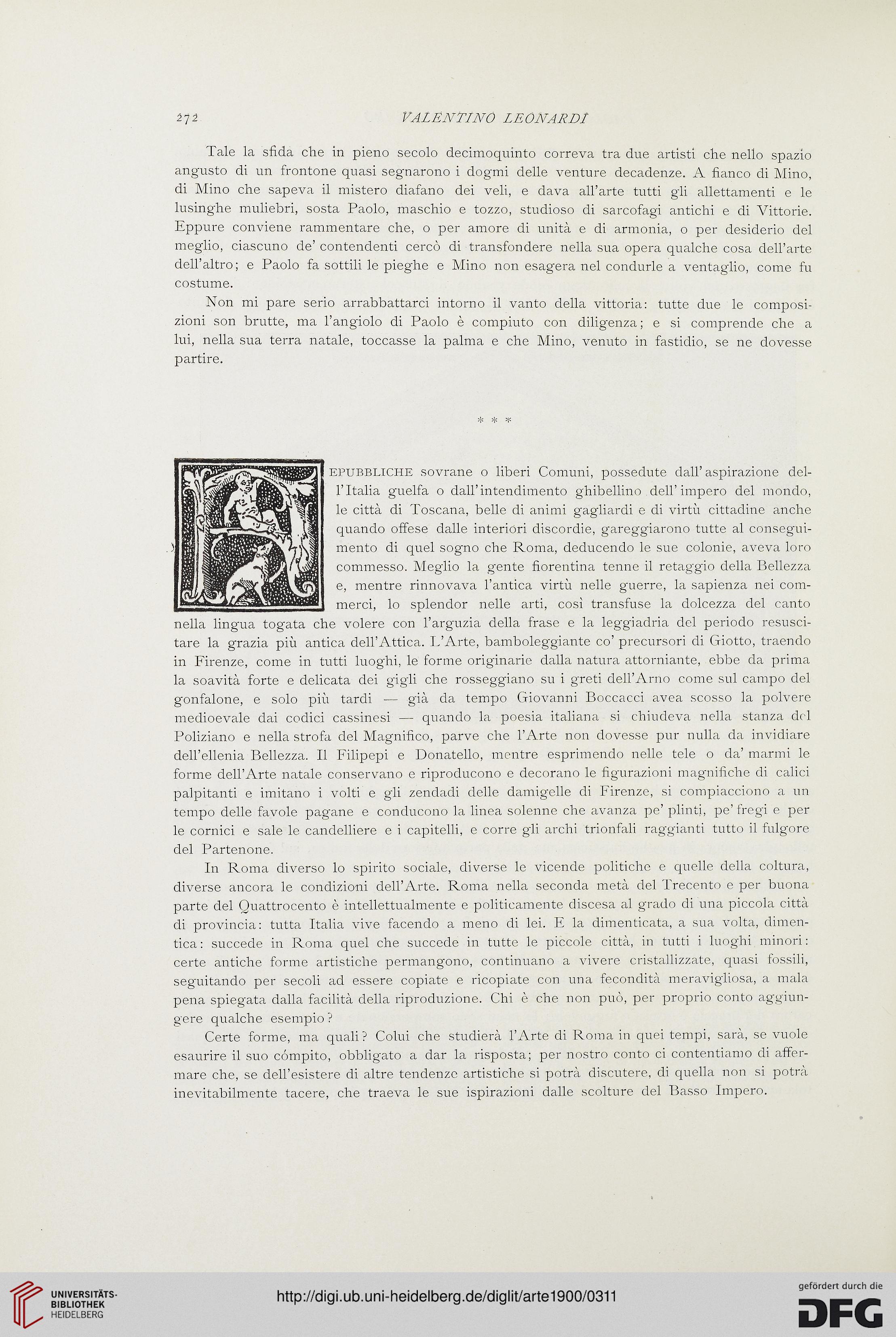VALENTINO LEONARDI
Tale la sfida che in pieno secolo decimoquinto correva tra due artisti che nello spazio
angusto di un frontone quasi segnarono i dogmi delle venture decadenze. A fianco di Mino,
di Mino che sapeva il mistero diafano dei veli, e dava all'arte tutti gli allettamenti e le
lusinghe muliebri, sosta Paolo, maschio e tozzo, studioso di sarcofagi antichi e di Vittorie.
Eppure conviene rammentare che, o per amore di unità e di armonia, o per desiderio del
meglio, ciascuno de'contendenti cercò di transfondere nella sua opera qualche cosa dell'arte
dell'altro; e Paolo fa sottili le pieghe e Mino non esagera nel condurle a ventaglio, come fu
costume.
Non mi pare serio arrabbattarci intorno il vanto della vittoria: tutte due le composi-
zioni son brutte, ma l'angiolo di Paolo è compiuto con diligenza; e si comprende che a
lui, nella sua terra natale, toccasse la palma e che Mino, venuto in fastidio, se ne dovesse
partire.
* * ^
EPUBBLICHE sovrane o liberi Comuni, possedute dall' aspirazione del-
l'Italia guelfa o dall'intendimento ghibellino dell'impero del mondo,
le città di Toscana, belle di animi gagliardi e di virtù cittadine anche
quando offese dalle interiori discordie, gareggiarono tutte al consegui-
mento di quel sogno che Roma, deducendo le sue colonie, aveva loro
commesso. Meglio la gente fiorentina tenne il retaggio della Bellezza
e, mentre rinnovava l'antica virtù nelle guerre, la sapienza nei com-
merci, lo splendor nelle arti, così transfuse la dolcezza del canto
nella lingua togata che volere con l'arguzia della frase e la leggiadria del periodo resusci-
tare la grazia più antica dell'Attica. T'Arte, bamboleggiante co' precursori di Giotto, traendo
in Firenze, come in tutti luoghi, le forme originarie dalla natura attorniante, ebbe da prima
la soavità forte e delicata dei gigli che rosseggiano su i greti dell'Arno come sul campo del
gonfalone, e solo più tardi — già da tempo Giovanni Boccacci avea scosso la polvere
medioevale dai codici cassinesi • quando la poesia italiana si chiudeva nella stanza del
Poliziano e nella strofa del Magnifico, parve che l'Arte non dovesse pur nulla da invidiare
dell'ellenia Bellezza. Il Filipepi e Donatello, mentre esprimendo nelle tele o da' marmi le
forme dell'Arte natale conservano e riproducono e decorano le figurazioni magnifiche di calici
palpitanti e imitano i volti e gli zendadi delle damigelle di Firenze, si compiacciono a un
tempo delle favole pagane e conducono la linea solenne che avanza pe' plinti, pe' fregi e per
le cornici e sale le candelliere e i capitelli, e corre gli archi trionfali raggianti tutto il fulgore
del Partenone.
In Roma diverso lo spirito sociale, diverse le vicende politiche e quelle della coltura,
diverse ancora le condizioni dell'Arte. Roma nella seconda metà del Trecento e per buona
parte del Quattrocento è intellettualmente e politicamente discesa al grado di una piccola città
di provincia: tutta Italia vive facendo a meno di lei. E la dimenticata, a sua volta, dimen-
tica: succede in Roma quel che succede in tutte le piccole città, in tutti i luoghi minori:
certe antiche forme artistiche permangono, continuano a vivere cristallizzate, quasi fossili,
seguitando per secoli ad essere copiate e ricopiate con una fecondità meravigliosa, a mala
pena spiegata dalla facilità della riproduzione. Chi è che non può, per proprio conto aggiun-
gere qualche esempio ?
Certe forme, ma quali? Colui che studierà l'Arte di Roma in quei tempi, sarà, se vuole
esaurire il suo compito, obbligato a dar la risposta; per nostro conto ci contentiamo di affer-
mare che, se dell'esistere di altre tendenze artistiche si potrà discutere, di quella non si potrà
inevitabilmente tacere, che traeva le sue ispirazioni dalle scolture del Basso Impero.
Tale la sfida che in pieno secolo decimoquinto correva tra due artisti che nello spazio
angusto di un frontone quasi segnarono i dogmi delle venture decadenze. A fianco di Mino,
di Mino che sapeva il mistero diafano dei veli, e dava all'arte tutti gli allettamenti e le
lusinghe muliebri, sosta Paolo, maschio e tozzo, studioso di sarcofagi antichi e di Vittorie.
Eppure conviene rammentare che, o per amore di unità e di armonia, o per desiderio del
meglio, ciascuno de'contendenti cercò di transfondere nella sua opera qualche cosa dell'arte
dell'altro; e Paolo fa sottili le pieghe e Mino non esagera nel condurle a ventaglio, come fu
costume.
Non mi pare serio arrabbattarci intorno il vanto della vittoria: tutte due le composi-
zioni son brutte, ma l'angiolo di Paolo è compiuto con diligenza; e si comprende che a
lui, nella sua terra natale, toccasse la palma e che Mino, venuto in fastidio, se ne dovesse
partire.
* * ^
EPUBBLICHE sovrane o liberi Comuni, possedute dall' aspirazione del-
l'Italia guelfa o dall'intendimento ghibellino dell'impero del mondo,
le città di Toscana, belle di animi gagliardi e di virtù cittadine anche
quando offese dalle interiori discordie, gareggiarono tutte al consegui-
mento di quel sogno che Roma, deducendo le sue colonie, aveva loro
commesso. Meglio la gente fiorentina tenne il retaggio della Bellezza
e, mentre rinnovava l'antica virtù nelle guerre, la sapienza nei com-
merci, lo splendor nelle arti, così transfuse la dolcezza del canto
nella lingua togata che volere con l'arguzia della frase e la leggiadria del periodo resusci-
tare la grazia più antica dell'Attica. T'Arte, bamboleggiante co' precursori di Giotto, traendo
in Firenze, come in tutti luoghi, le forme originarie dalla natura attorniante, ebbe da prima
la soavità forte e delicata dei gigli che rosseggiano su i greti dell'Arno come sul campo del
gonfalone, e solo più tardi — già da tempo Giovanni Boccacci avea scosso la polvere
medioevale dai codici cassinesi • quando la poesia italiana si chiudeva nella stanza del
Poliziano e nella strofa del Magnifico, parve che l'Arte non dovesse pur nulla da invidiare
dell'ellenia Bellezza. Il Filipepi e Donatello, mentre esprimendo nelle tele o da' marmi le
forme dell'Arte natale conservano e riproducono e decorano le figurazioni magnifiche di calici
palpitanti e imitano i volti e gli zendadi delle damigelle di Firenze, si compiacciono a un
tempo delle favole pagane e conducono la linea solenne che avanza pe' plinti, pe' fregi e per
le cornici e sale le candelliere e i capitelli, e corre gli archi trionfali raggianti tutto il fulgore
del Partenone.
In Roma diverso lo spirito sociale, diverse le vicende politiche e quelle della coltura,
diverse ancora le condizioni dell'Arte. Roma nella seconda metà del Trecento e per buona
parte del Quattrocento è intellettualmente e politicamente discesa al grado di una piccola città
di provincia: tutta Italia vive facendo a meno di lei. E la dimenticata, a sua volta, dimen-
tica: succede in Roma quel che succede in tutte le piccole città, in tutti i luoghi minori:
certe antiche forme artistiche permangono, continuano a vivere cristallizzate, quasi fossili,
seguitando per secoli ad essere copiate e ricopiate con una fecondità meravigliosa, a mala
pena spiegata dalla facilità della riproduzione. Chi è che non può, per proprio conto aggiun-
gere qualche esempio ?
Certe forme, ma quali? Colui che studierà l'Arte di Roma in quei tempi, sarà, se vuole
esaurire il suo compito, obbligato a dar la risposta; per nostro conto ci contentiamo di affer-
mare che, se dell'esistere di altre tendenze artistiche si potrà discutere, di quella non si potrà
inevitabilmente tacere, che traeva le sue ispirazioni dalle scolture del Basso Impero.