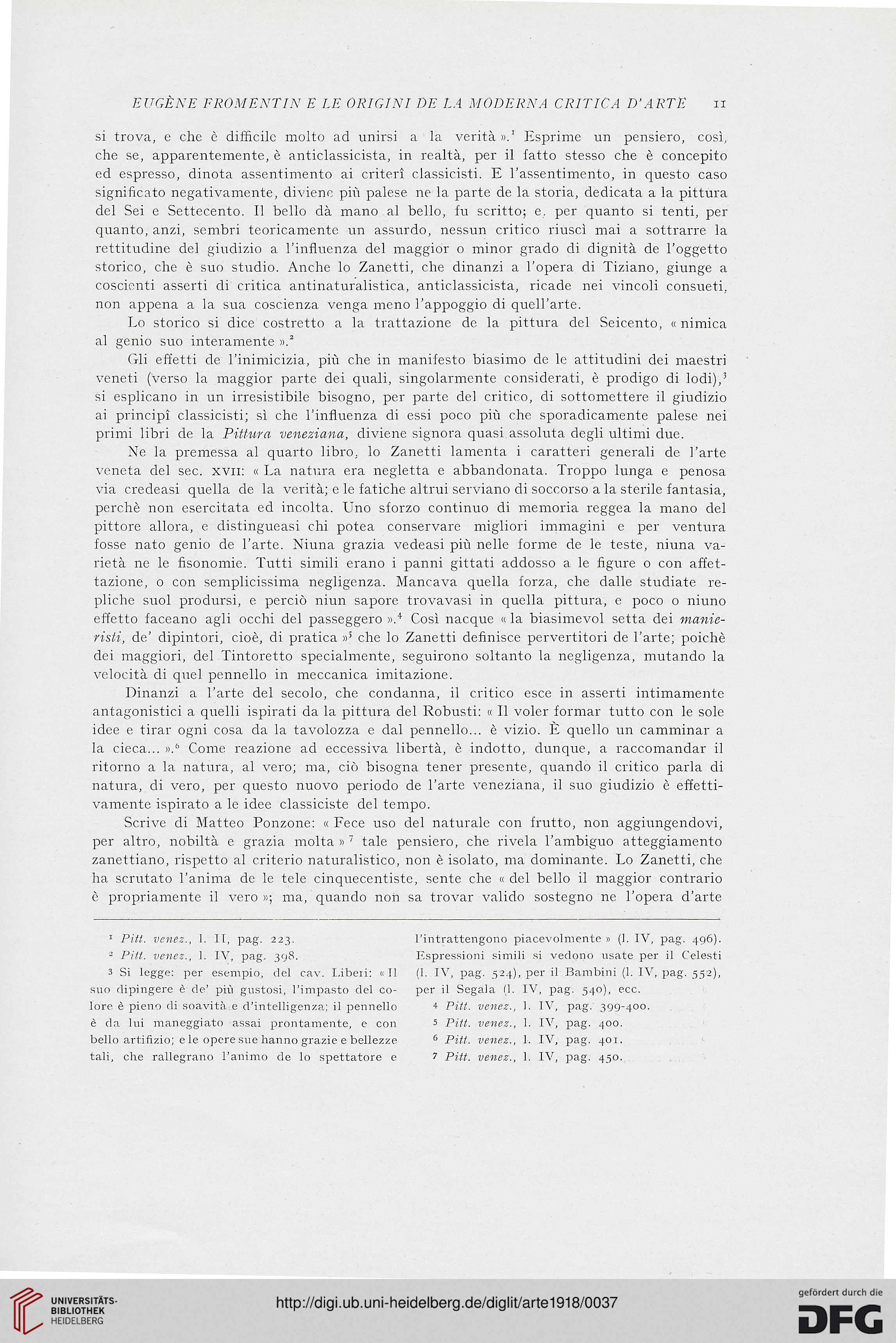EUGÈNE F ROM E NT IN E LE ORIGINI DE LA MODERNA CRITICA D'ARTE n
si trova, e che è diffìcile molto ad unirsi a la verità ».' Esprime un pensiero, così,
che se, apparentemente, è anticlassicista, in realtà, per il fatto stesso che è concepito
ed espresso, dinota assentimento ai criteri classicisti. E l'assentimento, in questo caso
significato negativamente, diviene più palese ne la parte de la storia, dedicata a la pittura
del Sei e Settecento. 11 bello dà mano al bello, fu scritto; e. per quanto si tenti, per
quanto, anzi, sembri teoricamente un assurdo, nessun critico riuscì mai a sottrarre la
rettitudine del giudizio a l'influenza del maggior o minor grado di dignità de l'oggetto
storico, che è suo studio. Anche lo Zanetti, che dinanzi a l'opera di Tiziano, giunge a
coscienti asserti di critica antinaturalistica, anticlassicista, ricade nei vincoli consueti,
non appena a la sua coscienza venga meno l'appoggio di quell'arte.
Lo storico si dice costretto a la trattazione de la pittura del Seicento, « nimica
al genio suo interamente ».2
(ìli effetti de l'inimicizia, più che in manifesto biasimo de le attitudini dei maestri
veneti (verso la maggior parte dei quali, singolarmente considerati, è prodigo di lodi),3
si esplicano in un irresistibile bisogno, per parte del critico, di sottomettere il giudizio
ai principi classicisti; sì che l'influenza di essi poco più che sporadicamente palese nei
primi libri de la Pittura veneziana, diviene signora quasi assoluta degli ultimi due.
Ne la premessa al quarto libro, lo Zanetti lamenta i caratteri generali de l'arte
veneta del sec. xvn: « La natura era negletta e abbandonata. Troppo lunga e penosa
via credeasi quella de la verità; e le fatiche altrui serviano di soccorso a la sterile fantasia,
perchè non esercitata ed incolta. Uno sforzo continuo di memoria reggea la mano del
pittore allora, e distingueasi chi potea conservare migliori immagini e per ventura
fosse nato genio de l'arte. Niuna grazia vedeasi più nelle forme de le teste, niuna va-
rietà ne le fìsonomie. Tutti simili erano i panni gittati addosso a le figure o con affet-
tazione, o con semplicissima negligenza. Mancava quella forza, che dalle studiate re-
pliche suol prodursi, e perciò niun sapore trovavasi in quella pittura, e poco o niuno
effetto faceano agli occhi del passeggero ».+ Così nacque « la biasimevol setta dei manie-
risti, de' dipintori, cioè, di pratica »■? che lo Zanetti definisce pervertitori de l'arte; poiché
dei maggiori, del Tintoretto specialmente, seguirono soltanto la negligenza, mutando la
velocità di quel pennello in meccanica imitazione.
Dinanzi a l'arte del secolo, che condanna, il critico esce in asserti intimamente
antagonistici a quelli ispirati da la pittura del Robusti: « 11 voler formar tutto con le sole
idee e tirar ogni cosa da la tavolozza e dal pennello... è vizio. È quello un camminar a
la cieca... »." Come reazione ad eccessiva libertà, è indotto, dunque, a raccomandar il
ritorno a la natura, al vero; ma, ciò bisogna tener presente, quando il critico parla di
natura, di vero, per questo nuovo periodo de l'arte veneziana, il suo giudizio è effetti-
vamente ispirato a le idee classiciste del tempo.
Scrive di Matteo Ponzone: « Fece uso del naturale con frutto, non aggiungendovi,
per altro, nobiltà e grazia molta » 7 tale pensiero, che rivela l'ambiguo atteggiamento
zancttiano, rispetto al criterio naturalistico, non è isolato, ma dominante. Lo Zanetti, che
ha scrutato l'anima de le tele cinquecentiste, sente che « del bello il maggior contrario
è propriamente il vero »; ma, quando non sa trovar valido sostegno ne l'opera d'arte
1 Pitt. venez., 1. II, pag. 223.
2 Pìlt. venez., 1. IV, pag, 398.
3 Si legge: per esempio, del cav. Liberi: «Il
suo dipingere è de' più gustosi, l'impasto del co-
lore è pieno di soavità e d'intelligenza; il pennello
è da lui maneggiato assai prontamente, e con
bello artifizio; eie opere sue hanno grazie e bellezze
tali, che rallegrano l'animo de lo spettatore e
l'intrattengono piacevolmente » (1. IV, pag. 496).
Espressioni simili si vedono usate per il Celesti
(1. IV, pag. 524), per il Bambini (1. IV, pag. 552),
per il Segala (1. IV, pag. 540), ecc.
4 Pitt. venez., 1. IV, pag.' 399-400.
5 Pitt. venez., 1. IV, pag. 400.
6 Pitt. venez., 1. IV, pag. 401. 1
^ Pitt. venez., 1. IV, pag. 450.
si trova, e che è diffìcile molto ad unirsi a la verità ».' Esprime un pensiero, così,
che se, apparentemente, è anticlassicista, in realtà, per il fatto stesso che è concepito
ed espresso, dinota assentimento ai criteri classicisti. E l'assentimento, in questo caso
significato negativamente, diviene più palese ne la parte de la storia, dedicata a la pittura
del Sei e Settecento. 11 bello dà mano al bello, fu scritto; e. per quanto si tenti, per
quanto, anzi, sembri teoricamente un assurdo, nessun critico riuscì mai a sottrarre la
rettitudine del giudizio a l'influenza del maggior o minor grado di dignità de l'oggetto
storico, che è suo studio. Anche lo Zanetti, che dinanzi a l'opera di Tiziano, giunge a
coscienti asserti di critica antinaturalistica, anticlassicista, ricade nei vincoli consueti,
non appena a la sua coscienza venga meno l'appoggio di quell'arte.
Lo storico si dice costretto a la trattazione de la pittura del Seicento, « nimica
al genio suo interamente ».2
(ìli effetti de l'inimicizia, più che in manifesto biasimo de le attitudini dei maestri
veneti (verso la maggior parte dei quali, singolarmente considerati, è prodigo di lodi),3
si esplicano in un irresistibile bisogno, per parte del critico, di sottomettere il giudizio
ai principi classicisti; sì che l'influenza di essi poco più che sporadicamente palese nei
primi libri de la Pittura veneziana, diviene signora quasi assoluta degli ultimi due.
Ne la premessa al quarto libro, lo Zanetti lamenta i caratteri generali de l'arte
veneta del sec. xvn: « La natura era negletta e abbandonata. Troppo lunga e penosa
via credeasi quella de la verità; e le fatiche altrui serviano di soccorso a la sterile fantasia,
perchè non esercitata ed incolta. Uno sforzo continuo di memoria reggea la mano del
pittore allora, e distingueasi chi potea conservare migliori immagini e per ventura
fosse nato genio de l'arte. Niuna grazia vedeasi più nelle forme de le teste, niuna va-
rietà ne le fìsonomie. Tutti simili erano i panni gittati addosso a le figure o con affet-
tazione, o con semplicissima negligenza. Mancava quella forza, che dalle studiate re-
pliche suol prodursi, e perciò niun sapore trovavasi in quella pittura, e poco o niuno
effetto faceano agli occhi del passeggero ».+ Così nacque « la biasimevol setta dei manie-
risti, de' dipintori, cioè, di pratica »■? che lo Zanetti definisce pervertitori de l'arte; poiché
dei maggiori, del Tintoretto specialmente, seguirono soltanto la negligenza, mutando la
velocità di quel pennello in meccanica imitazione.
Dinanzi a l'arte del secolo, che condanna, il critico esce in asserti intimamente
antagonistici a quelli ispirati da la pittura del Robusti: « 11 voler formar tutto con le sole
idee e tirar ogni cosa da la tavolozza e dal pennello... è vizio. È quello un camminar a
la cieca... »." Come reazione ad eccessiva libertà, è indotto, dunque, a raccomandar il
ritorno a la natura, al vero; ma, ciò bisogna tener presente, quando il critico parla di
natura, di vero, per questo nuovo periodo de l'arte veneziana, il suo giudizio è effetti-
vamente ispirato a le idee classiciste del tempo.
Scrive di Matteo Ponzone: « Fece uso del naturale con frutto, non aggiungendovi,
per altro, nobiltà e grazia molta » 7 tale pensiero, che rivela l'ambiguo atteggiamento
zancttiano, rispetto al criterio naturalistico, non è isolato, ma dominante. Lo Zanetti, che
ha scrutato l'anima de le tele cinquecentiste, sente che « del bello il maggior contrario
è propriamente il vero »; ma, quando non sa trovar valido sostegno ne l'opera d'arte
1 Pitt. venez., 1. II, pag. 223.
2 Pìlt. venez., 1. IV, pag, 398.
3 Si legge: per esempio, del cav. Liberi: «Il
suo dipingere è de' più gustosi, l'impasto del co-
lore è pieno di soavità e d'intelligenza; il pennello
è da lui maneggiato assai prontamente, e con
bello artifizio; eie opere sue hanno grazie e bellezze
tali, che rallegrano l'animo de lo spettatore e
l'intrattengono piacevolmente » (1. IV, pag. 496).
Espressioni simili si vedono usate per il Celesti
(1. IV, pag. 524), per il Bambini (1. IV, pag. 552),
per il Segala (1. IV, pag. 540), ecc.
4 Pitt. venez., 1. IV, pag.' 399-400.
5 Pitt. venez., 1. IV, pag. 400.
6 Pitt. venez., 1. IV, pag. 401. 1
^ Pitt. venez., 1. IV, pag. 450.