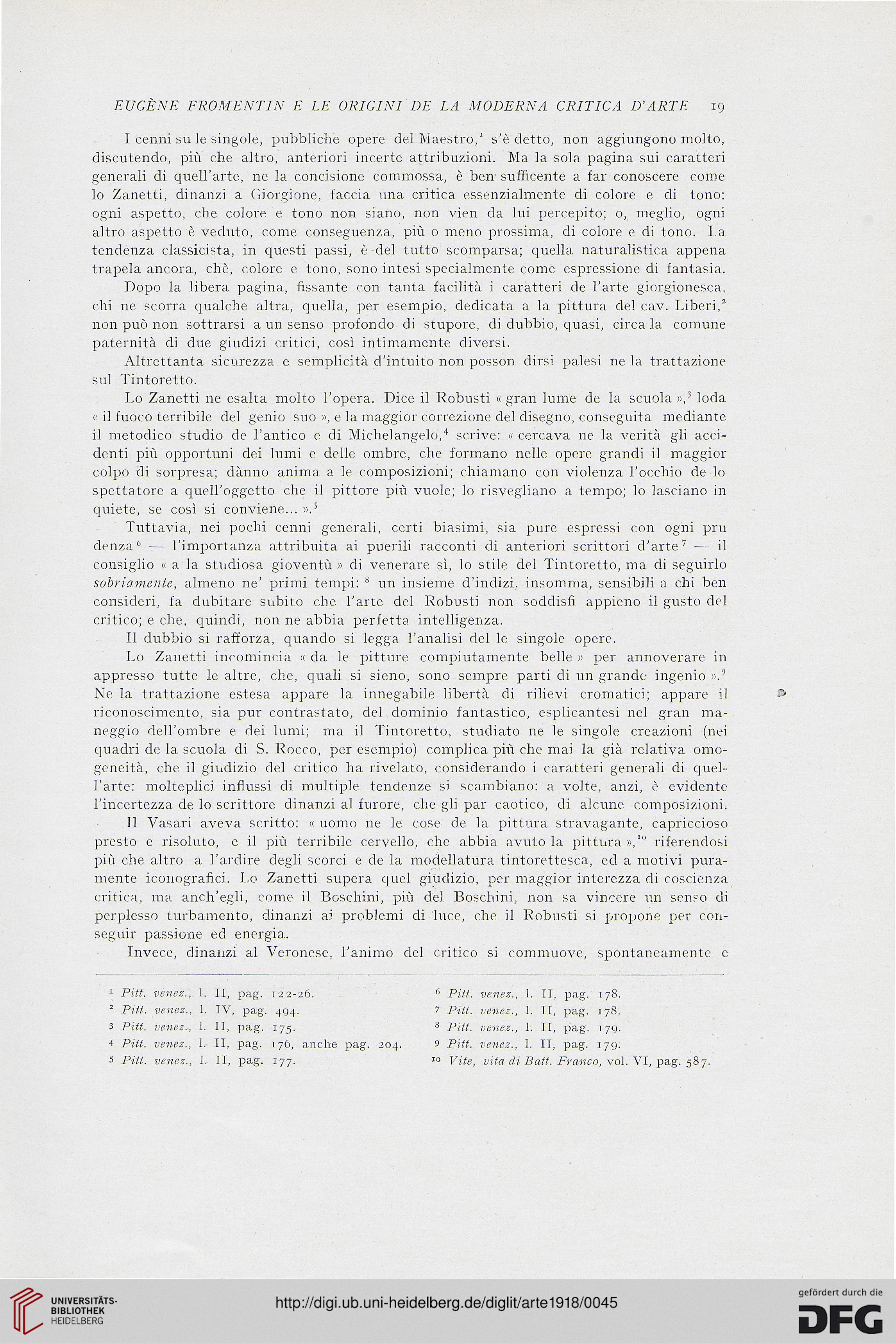EU GÈNE FROMENTIN E LE ORIGINI DE LA MODERNA CRITICA D'ARTE 19
J cenni svi le singole, pubbliche opere del Maestro/ s'è detto, non aggiungono molto,
discutendo, più che altro, anteriori incerte attribuzioni. Ma la sola pagina sui caratteri
generali di quell'arte, ne la concisione commossa, è ben sufficentc a far conoscere come
10 Zanetti, dinanzi a Giorgione, faccia una critica essenzialmente di colore e di tono:
ogni aspetto, che colore e tono non siano, non vien da lui percepito; o, meglio, ogni
altro aspetto è veduto, come conseguenza, piti 0 meno prossima, di colore e di tono, f a
tendenza classicista, in questi passi, è del tutto scomparsa; quella naturalistica appena
trapela ancora, che, colore e tono, sono intesi specialmente come espressione di fantasia.
Dopo la libera pagina, fissante con tanta facilità i caratteri de l'arte giorgionesca,
chi ne scorra qualche altra, quella, per esempio, dedicata a la pittura del cav. Liberi,2
non può non sottrarsi a un senso profondo di stupore, di dubbio, quasi, circa la comune
paternità di due giudizi critici, così intimamente diversi.
Altrettanta sicurezza e semplicità d'intuito non posson dirsi palesi ne la trattazione
sul Tintoretto.
ho Zanetti ne esalta molto l'opera. Dice il Robusti « gran lume de la scuola »,3 loda
e il fuoco terribile del genio suo », e la maggior correzione del disegno, conseguita mediante
11 metodico studio de l'antico e di Michelangelo,4 scrive: « cercava ne la verità gli acci-
denti più opportuni dei lumi e delle ombre, che formano nelle opere grandi il maggior
colpo di sorpresa; clànno anima a le composizioni; chiamano con violenza l'occhio de lo
spettatore a quell'oggetto che il pittore più vuole; lo risvegliano a tempo; lo lasciano in
quiete, se così si conviene... ».s
Tuttavia, nei pochi cenni generali, certi biasimi, sia pure espressi con ogni pru
denza6 — l'importanza attribuita ai puerili racconti di anteriori scrittori d'arte7 — il
consiglio « a la studiosa gioventù » di venerare sì, lo stile del Tintoretto, ma di seguirlo
sobriamente, almeno ne' primi tempi: 8 un insieme d'indizi, insomma, sensibili a chi ben
consideri, fa dubitare subito che l'arte del Robusti non soddisfi appieno il gusto del
critico; e clic, quindi, non ne abbia perfetta intelligenza.
Il dubbio si rafforza, quando si legga l'analisi del le singole opere.
ho Zanetti incomincia « da le pitture compiutamente belle » per annoverare in
appresso tutte le altre, che, quali si sieno, sono sempre parti di un grande ingenio ».9
Ne la trattazione estesa appare la innegabile libertà di rilievi cromatici; appare il
riconoscimento, sia pur contrastato, del dominio fantastico, esplicantesi nel gran ma-
neggio dell'ombre e dei lumi; ma il Tintoretto, studiato ne le singole creazioni (nei
quadri de la scuola di S. Rocco, per esempio) complica pivi che mai la già relativa omo-
geneità, che il giudizio del critico ha rivelato, considerando i caratteri generali di quel-
l'arte: molteplici influssi di multiple tendenze si scambiano: a volte, anzi, è evidente
l'incertezza de lo scrittore dinanzi al furore, (die gli par caotico, di alcune composizioni.
Il Vasari aveva scritto: «uomo ne le cose de la pittura stravagante, capriccioso
presto e risoluto, e il più terribile cervello, che abbia avuto la pittura »/" riferendosi
più che altro a l'ardire degli scorci e de la modellatura tintorettesca, ed a motivi pura-
mente iconografici. Lo Zanetti supera quel giudizio, per maggior interezza di coscienza
critica, ma, anch'egli, come il Boschini, più del Boschini, non sa vincere un senso di
perplesso turbamento, dinanzi ai problemi di luce, che il Robusti si propone per con-
seguir passione ed energia.
Invece, dinanzi al Veronese, l'animo del critico si commuove, spontaneamente e
1 Pitt. venez.,. 1. II, pag. 122-26.
2 Pitt. venez., 1. IV, pag. 494.
3 Pitt. venez.-, 1. II, pag. 175.
4 Piti, venez., 1. IT, pag. 176, anche pag. 204.
5 Pitt. venez., L II, pag. 177;
6 Pìtt. venez., 1. II, pag. 178.
7 Pitt. venez., 1. II, pag. 178.
8 Pitt. venez., 1. II, pag. 179.
9 Pitt. venez., 1. II, pag. 179.
10 Vite, vita di Batt. Franco, voi. VI, pag. 587.
J cenni svi le singole, pubbliche opere del Maestro/ s'è detto, non aggiungono molto,
discutendo, più che altro, anteriori incerte attribuzioni. Ma la sola pagina sui caratteri
generali di quell'arte, ne la concisione commossa, è ben sufficentc a far conoscere come
10 Zanetti, dinanzi a Giorgione, faccia una critica essenzialmente di colore e di tono:
ogni aspetto, che colore e tono non siano, non vien da lui percepito; o, meglio, ogni
altro aspetto è veduto, come conseguenza, piti 0 meno prossima, di colore e di tono, f a
tendenza classicista, in questi passi, è del tutto scomparsa; quella naturalistica appena
trapela ancora, che, colore e tono, sono intesi specialmente come espressione di fantasia.
Dopo la libera pagina, fissante con tanta facilità i caratteri de l'arte giorgionesca,
chi ne scorra qualche altra, quella, per esempio, dedicata a la pittura del cav. Liberi,2
non può non sottrarsi a un senso profondo di stupore, di dubbio, quasi, circa la comune
paternità di due giudizi critici, così intimamente diversi.
Altrettanta sicurezza e semplicità d'intuito non posson dirsi palesi ne la trattazione
sul Tintoretto.
ho Zanetti ne esalta molto l'opera. Dice il Robusti « gran lume de la scuola »,3 loda
e il fuoco terribile del genio suo », e la maggior correzione del disegno, conseguita mediante
11 metodico studio de l'antico e di Michelangelo,4 scrive: « cercava ne la verità gli acci-
denti più opportuni dei lumi e delle ombre, che formano nelle opere grandi il maggior
colpo di sorpresa; clànno anima a le composizioni; chiamano con violenza l'occhio de lo
spettatore a quell'oggetto che il pittore più vuole; lo risvegliano a tempo; lo lasciano in
quiete, se così si conviene... ».s
Tuttavia, nei pochi cenni generali, certi biasimi, sia pure espressi con ogni pru
denza6 — l'importanza attribuita ai puerili racconti di anteriori scrittori d'arte7 — il
consiglio « a la studiosa gioventù » di venerare sì, lo stile del Tintoretto, ma di seguirlo
sobriamente, almeno ne' primi tempi: 8 un insieme d'indizi, insomma, sensibili a chi ben
consideri, fa dubitare subito che l'arte del Robusti non soddisfi appieno il gusto del
critico; e clic, quindi, non ne abbia perfetta intelligenza.
Il dubbio si rafforza, quando si legga l'analisi del le singole opere.
ho Zanetti incomincia « da le pitture compiutamente belle » per annoverare in
appresso tutte le altre, che, quali si sieno, sono sempre parti di un grande ingenio ».9
Ne la trattazione estesa appare la innegabile libertà di rilievi cromatici; appare il
riconoscimento, sia pur contrastato, del dominio fantastico, esplicantesi nel gran ma-
neggio dell'ombre e dei lumi; ma il Tintoretto, studiato ne le singole creazioni (nei
quadri de la scuola di S. Rocco, per esempio) complica pivi che mai la già relativa omo-
geneità, che il giudizio del critico ha rivelato, considerando i caratteri generali di quel-
l'arte: molteplici influssi di multiple tendenze si scambiano: a volte, anzi, è evidente
l'incertezza de lo scrittore dinanzi al furore, (die gli par caotico, di alcune composizioni.
Il Vasari aveva scritto: «uomo ne le cose de la pittura stravagante, capriccioso
presto e risoluto, e il più terribile cervello, che abbia avuto la pittura »/" riferendosi
più che altro a l'ardire degli scorci e de la modellatura tintorettesca, ed a motivi pura-
mente iconografici. Lo Zanetti supera quel giudizio, per maggior interezza di coscienza
critica, ma, anch'egli, come il Boschini, più del Boschini, non sa vincere un senso di
perplesso turbamento, dinanzi ai problemi di luce, che il Robusti si propone per con-
seguir passione ed energia.
Invece, dinanzi al Veronese, l'animo del critico si commuove, spontaneamente e
1 Pitt. venez.,. 1. II, pag. 122-26.
2 Pitt. venez., 1. IV, pag. 494.
3 Pitt. venez.-, 1. II, pag. 175.
4 Piti, venez., 1. IT, pag. 176, anche pag. 204.
5 Pitt. venez., L II, pag. 177;
6 Pìtt. venez., 1. II, pag. 178.
7 Pitt. venez., 1. II, pag. 178.
8 Pitt. venez., 1. II, pag. 179.
9 Pitt. venez., 1. II, pag. 179.
10 Vite, vita di Batt. Franco, voi. VI, pag. 587.