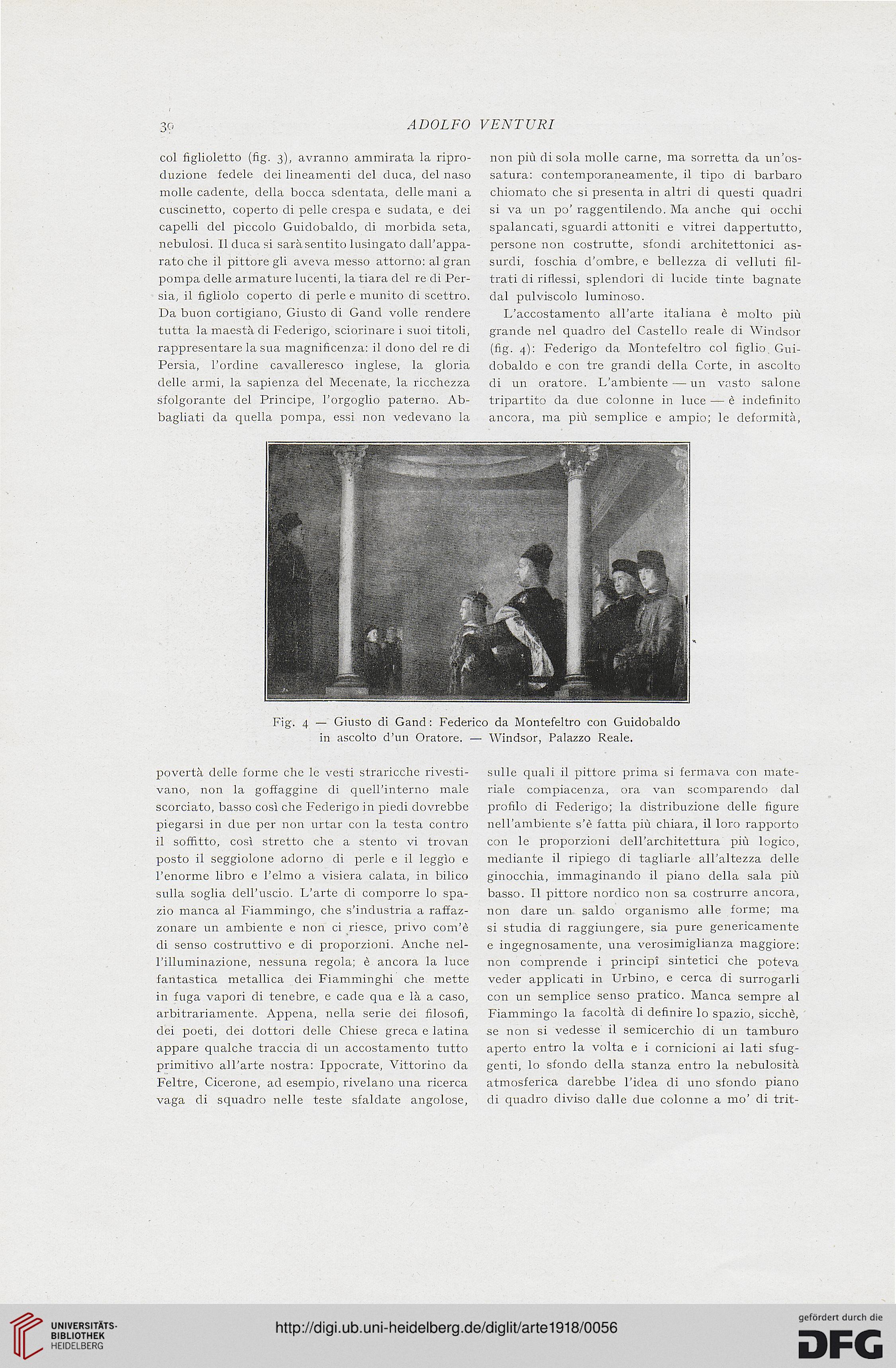3°
ADOLFO VENTURI
col figlioletto (fig. 3), avranno ammirata la ripro-
duzione fedele dei lineamenti del duca, del naso
molle cadente, della bocca sdentata, delle mani a
cuscinetto, coperto di pelle crespa e sudata, e dei
capelli del piccolo Guidobaldo, di morbida seta,
nebulosi. Il duca si sarà sentito lusingato dall'appa-
rato che il pittore gli aveva messo attorno: al gran
pompa delle armature lucenti, la tiara del re di Per-
sia, il figliolo coperto di perle e munito di scettro.
Da buon cortigiano, Giusto di Ganci volle rendere
tutta la maestà di Federigo, sciorinare i suoi titoli,
rappresentare la sua magnificenza: il dono del re di
Persia, l'ordine cavalleresco inglese, la gloria
delle armi, la sapienza del Mecenate, la ricchezza
sfolgorante del Principe, l'orgoglio paterno. Ab-
bagliati da quella pompa, essi non vedevano la
povertà delle forme che le vesti straricche rivesti-
vano, non la goffaggine di quell'interno male
scorciato, basso così che Federigo in piedi dovrebbe
piegarsi in due per non urtar con la testa contro
il soffitto, così stretto che a stento vi trovan
posto il seggiolone adorno di perle e il leggìo e
l'enorme libro e l'elmo a visiera calata, in bilico
sulla soglia dell'uscio. L'arte di comporre lo spa-
zio manca al Fiammingo, che s'industria a raffaz-
zonare un ambiente e non ci riesce, privo com'è
di senso costruttivo e di proporzioni. Anche nel-
l'illuminazione, nessuna regola; è ancora la luce
fantastica metallica dei Fiamminghi che mette
in fuga vapori di tenebre, e cade qua e là a caso,
arbitrariamente. Appena, nella serie dei filosofi,
dei poeti, dei dottori delle Chiese greca e latina
appare qualche traccia di un accostamento tutto
primitivo all'arte nostra: Ippocrate, Vittorino da
Feltre, Cicerone, ad esempio, rivelano una ricerca
vaga di squadro nelle teste sfaldate angolose,
non più di sola molle carne, ma sorretta da un'os-
satura: contemporaneamente, il tipo di barbaro
chiomato che si presenta in altri di questi quadri
si va un po' raggentilendo. Ma anche qui occhi
spalancati, sguardi attoniti e vitrei dappertutto,
persone non costrutte, sfondi architettonici as-
surdi, foschia d'ombre, e bellezza di velluti fil-
trati di riflessi, splendori di lucide tinte bagnate
dal pulviscolo luminoso.
L'accostamento all'arte italiana è molto più
grande nel quadro del Castello reale di Windsor
(fig. 4): Federigo da Montcfeltro col figlio. Gui-
dobaldo e con tre grandi della Corte, in ascolto
di un oratore. L'ambiente — un vasto salone
tripartito da due colonne in luce — è indefinito
ancora, ma più semplice e ampio; le deformità,
il
sulle quali il pittore prima si fermava con mate-
riale compiacenza, ora van scomparendo dal
profilo di Federigo; la distribuzione delle figure
nell'ambiente s'è fatta più chiara, il loro rapporto
con le proporzioni dell'architettura più logico,
mediante il ripiego di tagliarle all'altezza delle
ginocchia, immaginando il piano della sala più
basso. Il pittore nordico non sa costrurre ancora,
non dare un saldo organismo alle forme; ma
si studia di raggiungere, sia pure genericamente
e ingegnosamente, una verosimiglianza maggiore:
non comprende i principi sintetici che poteva
veder applicati in Urbino, e cerca di surrogarli
con un semplice senso pratico. Manca sempre al
Fiammingo la facoltà di definire lo spazio, sicché,
se non si vedesse il semicerchio di un tamburo
aperto entro la volta e i cornicioni ai lati sfug-
genti, lo sfondo della stanza entro la nebulosità
atmosferica darebbe l'idea di uno sfondo piano
di quadro diviso dalle due colonne a mo' di trit-
Kig. 4 — Giusto di Gand : Federico da Montefeltro con Guidobaldo
in ascolto d'un Oratore. — Windsor, Palazzo Reale.
ADOLFO VENTURI
col figlioletto (fig. 3), avranno ammirata la ripro-
duzione fedele dei lineamenti del duca, del naso
molle cadente, della bocca sdentata, delle mani a
cuscinetto, coperto di pelle crespa e sudata, e dei
capelli del piccolo Guidobaldo, di morbida seta,
nebulosi. Il duca si sarà sentito lusingato dall'appa-
rato che il pittore gli aveva messo attorno: al gran
pompa delle armature lucenti, la tiara del re di Per-
sia, il figliolo coperto di perle e munito di scettro.
Da buon cortigiano, Giusto di Ganci volle rendere
tutta la maestà di Federigo, sciorinare i suoi titoli,
rappresentare la sua magnificenza: il dono del re di
Persia, l'ordine cavalleresco inglese, la gloria
delle armi, la sapienza del Mecenate, la ricchezza
sfolgorante del Principe, l'orgoglio paterno. Ab-
bagliati da quella pompa, essi non vedevano la
povertà delle forme che le vesti straricche rivesti-
vano, non la goffaggine di quell'interno male
scorciato, basso così che Federigo in piedi dovrebbe
piegarsi in due per non urtar con la testa contro
il soffitto, così stretto che a stento vi trovan
posto il seggiolone adorno di perle e il leggìo e
l'enorme libro e l'elmo a visiera calata, in bilico
sulla soglia dell'uscio. L'arte di comporre lo spa-
zio manca al Fiammingo, che s'industria a raffaz-
zonare un ambiente e non ci riesce, privo com'è
di senso costruttivo e di proporzioni. Anche nel-
l'illuminazione, nessuna regola; è ancora la luce
fantastica metallica dei Fiamminghi che mette
in fuga vapori di tenebre, e cade qua e là a caso,
arbitrariamente. Appena, nella serie dei filosofi,
dei poeti, dei dottori delle Chiese greca e latina
appare qualche traccia di un accostamento tutto
primitivo all'arte nostra: Ippocrate, Vittorino da
Feltre, Cicerone, ad esempio, rivelano una ricerca
vaga di squadro nelle teste sfaldate angolose,
non più di sola molle carne, ma sorretta da un'os-
satura: contemporaneamente, il tipo di barbaro
chiomato che si presenta in altri di questi quadri
si va un po' raggentilendo. Ma anche qui occhi
spalancati, sguardi attoniti e vitrei dappertutto,
persone non costrutte, sfondi architettonici as-
surdi, foschia d'ombre, e bellezza di velluti fil-
trati di riflessi, splendori di lucide tinte bagnate
dal pulviscolo luminoso.
L'accostamento all'arte italiana è molto più
grande nel quadro del Castello reale di Windsor
(fig. 4): Federigo da Montcfeltro col figlio. Gui-
dobaldo e con tre grandi della Corte, in ascolto
di un oratore. L'ambiente — un vasto salone
tripartito da due colonne in luce — è indefinito
ancora, ma più semplice e ampio; le deformità,
il
sulle quali il pittore prima si fermava con mate-
riale compiacenza, ora van scomparendo dal
profilo di Federigo; la distribuzione delle figure
nell'ambiente s'è fatta più chiara, il loro rapporto
con le proporzioni dell'architettura più logico,
mediante il ripiego di tagliarle all'altezza delle
ginocchia, immaginando il piano della sala più
basso. Il pittore nordico non sa costrurre ancora,
non dare un saldo organismo alle forme; ma
si studia di raggiungere, sia pure genericamente
e ingegnosamente, una verosimiglianza maggiore:
non comprende i principi sintetici che poteva
veder applicati in Urbino, e cerca di surrogarli
con un semplice senso pratico. Manca sempre al
Fiammingo la facoltà di definire lo spazio, sicché,
se non si vedesse il semicerchio di un tamburo
aperto entro la volta e i cornicioni ai lati sfug-
genti, lo sfondo della stanza entro la nebulosità
atmosferica darebbe l'idea di uno sfondo piano
di quadro diviso dalle due colonne a mo' di trit-
Kig. 4 — Giusto di Gand : Federico da Montefeltro con Guidobaldo
in ascolto d'un Oratore. — Windsor, Palazzo Reale.